di Fabio Ciabatti
 La triste commedia messa in scena dalla classe politica durante l’ultima crisi di governo è stata unanimemente e fortemente condannata dai media main stream. Siamo di fronte a una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti, si lamentano commentatori di ogni risma, e i partiti sono capaci soltanto di fare giochi di palazzo dimenticandosi dell’interesse generale. Vergogna! Alla gogna! Eppure la maniacalità con cui viene seguito ogni sussurro proveniente dalle stanze e dai corridoi del “palazzo” suscita molti dubbi sul significato reale dell’indignazione sbandierata da giornalisti e opinionisti. Se del solito teatrino della politica si tratta, perché puntare ossessivamente i riflettori su questi attori di serie B? In realtà quello che è andato in scena con la complicità di giornali, televisioni e media digitali non è tanto una rappresentazione teatrale di pessima fattura quanto un vero e proprio spettacolo, nel senso che a questo termine attribuiva Debord.
La triste commedia messa in scena dalla classe politica durante l’ultima crisi di governo è stata unanimemente e fortemente condannata dai media main stream. Siamo di fronte a una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti, si lamentano commentatori di ogni risma, e i partiti sono capaci soltanto di fare giochi di palazzo dimenticandosi dell’interesse generale. Vergogna! Alla gogna! Eppure la maniacalità con cui viene seguito ogni sussurro proveniente dalle stanze e dai corridoi del “palazzo” suscita molti dubbi sul significato reale dell’indignazione sbandierata da giornalisti e opinionisti. Se del solito teatrino della politica si tratta, perché puntare ossessivamente i riflettori su questi attori di serie B? In realtà quello che è andato in scena con la complicità di giornali, televisioni e media digitali non è tanto una rappresentazione teatrale di pessima fattura quanto un vero e proprio spettacolo, nel senso che a questo termine attribuiva Debord.
“Lo spettacolo – sostiene il padre del situazionismo – riunisce il separato, ma lo riunisce in quanto separato”.1 Per quel che qui ci interessa possiamo sostenere che lo spettacolo della crisi di governo ha riunificato, a suo modo, la sfera politica e quella economica; la prima intesa come l’istanza che si presume possa garantire l’interesse generale e la coesione complessiva di una società, la seconda come l’ambito in cui i singoli capitali organizzano la produzione finalizzata al perseguimento del profitto.
A questo proposito chiediamo un po’ di pazienza perché vorremmo ribadire, come si sarebbe detto un tempo, alcune banalità di base. E ci piace farlo, a mo’ di omaggio, attraverso un testo di qualche anno fa di Ellen Meiksins Wood, importante esponente del marxismo politico, scomparsa nel gennaio di cinque anni fa.2 Ebbene, secondo l’autrice il sistema capitalistico è caratterizzato da una separazione senza precedenti della sfera economica da quella politica. Lo stato rimane essenzialmente separato dall’economia anche quando interviene in essa. In altri termini il capitalismo è caratterizzato da una divisione del lavoro in cui i due momenti dello sfruttamento capitalistico – l’appropriazione e la coercizione – sono separati: il primo viene assegnato a una classe privata appropriatrice, i capitalisti, il secondo a una istituzione pubblica specializzata nella coercizione, lo stato. Quest’ultimo, da una parte, ha il monopolio della forza coercitiva; dall’altra, attraverso questa forza, sostiene un potere economico “privato”, la proprietà capitalistica che è investita dell’autorità di organizzare la produzione. Un’autorità probabilmente senza precedenti storici nel suo grado di controllo sull’attività produttiva e sugli esseri umani impegnati in essa.
 Ciò significa che l’appropriazione del surplus avviene nella sfera economica con mezzi economici. Data la separazione dei produttori diretti dalle condizioni di lavoro, la pressione diretta extraeconomica, l’aperta coercizione, per principio, non sono necessarie per costringere i lavoratori a cedere al capitale il loro pluslavoro, cioè il tempo di lavoro eccedente rispetto alla produzione dei beni necessari alla loro riproduzione. A tal fine è sufficiente il bisogno economico che si esplica nell’ambito dello scambio di merci, basato sulla relazione contrattuale tra “liberi” produttori. Le società precapitalistiche, invece, sono caratterizzate da mezzi extra-economici di estrazione del surplus: coercizione politica, legale, militare, vincoli e doveri consuetudinari, obbligazioni religiose, deliberazioni comunitarie regolano il trasferimento del pluslavoro ai signori privati o allo stato attraverso corvée, rendita, tasse ecc.
Ciò significa che l’appropriazione del surplus avviene nella sfera economica con mezzi economici. Data la separazione dei produttori diretti dalle condizioni di lavoro, la pressione diretta extraeconomica, l’aperta coercizione, per principio, non sono necessarie per costringere i lavoratori a cedere al capitale il loro pluslavoro, cioè il tempo di lavoro eccedente rispetto alla produzione dei beni necessari alla loro riproduzione. A tal fine è sufficiente il bisogno economico che si esplica nell’ambito dello scambio di merci, basato sulla relazione contrattuale tra “liberi” produttori. Le società precapitalistiche, invece, sono caratterizzate da mezzi extra-economici di estrazione del surplus: coercizione politica, legale, militare, vincoli e doveri consuetudinari, obbligazioni religiose, deliberazioni comunitarie regolano il trasferimento del pluslavoro ai signori privati o allo stato attraverso corvée, rendita, tasse ecc.
Il processo attraverso cui si afferma l’autorità della proprietà privata, unendo il potere dell’appropriazione con l’autorità di organizzare la produzione nella mani di un proprietario privato per il suo beneficio, può essere visto come la privatizzazione del potere politico, cioè l’assunzione da parte di un proprietario privato di funzioni che erano originariamente appannaggio di un’autorità pubblica o comunitaria. Allo stesso tempo, questo potere non porta più con sé l’obbligo di adempiere a funzioni pubbliche, sociali. In ogni caso la separazione tra economia e politica svaluta la sfera politica e di conseguenza il significato della cittadinanza che perciò può essere estesa, tendenzialmente, senza limitazioni. La cittadinanza si fa formale non potendo investire una vasta area delle nostre vite quotidiane: i luoghi di lavoro, la distribuzione del lavoro e delle risorse ecc.
Non vorremmo essere fraintesi. Meiksins Wood non vuole affermare una rigida separazione concettuale tra economico e politico, cosa che avrebbe la conseguenza di svuotare il capitalismo del suo contenuto sociale e politico. Sostiene invece che i rapporti di produzione devono essere presentati nel loro aspetto politico, come rapporti di dominazione, diritti di proprietà, potere di governare e organizzare la produzione e l’appropriazione e perciò come terreno di lotta. In questo senso le relazioni politiche e giuridiche non sono riflessi secondari o meri supporti esterni, ma parti costituenti dei rapporti di produzione. Economico e politico vanno dunque intesi come momenti la cui unità interna si muove attraverso opposizioni esterne. Da ciò deriva una conseguenza: come sostiene Marx, “Se il farsi esteriormente indipendenti dei due momenti, che internamente non sono indipendenti perché si integrano reciprocamente, prosegue fino ad un certo punto, l’unità si fa valere con la violenza, attraverso una crisi”.3 E con ciò torniamo all’attualità.
Quella cui stiamo assistendo in Italia, e non solo, è una crisi di sistema, già da tempo in incubazione ma accelerata dalle conseguenze della pandemia, mascherata da crisi politica. L’ossessiva attenzione nei confronti dei rumor di palazzo sono funzionali a un processo di villanizzazione della classe politica, cioè alla creazione del villain della storia, del cattivo colpevole di tutti i mali sofferti da una nazione che altrimenti sarebbe in grado di reagire all’attacco del virus e, come la Roma di Nerone/Petrolini, rinascere “più bella e più superba che pria”. Risulta allora chiaro che la separazione tra sfera economica e sfera politica, per quanto possa sembrare a prima vista una debolezza del sistema perché limita la concentrazione del potere, risulta in realtà un suo punto di forza in quanto consente di affrontare le sue crisi senza investire direttamente i suoi fondamenti, i rapporti sociali di produzione capitalistici. La politica diviene il perfetto capro espiatorio. A essa, infatti, viene attribuito il compito di risolvere i problemi socio-economici, ma al contempo ha limitate capacità di intervento in questi campi, fermi restando il potere di appropriazione del surplus e l’autorità di organizzazione della produzione nella mani dei singoli capitali.
 Non è un caso, sostiene ancora Meiksins Wood, che le moderne rivoluzioni si siano verificate laddove il modo di produzione capitalistico era meno sviluppato e coesisteva con più antiche forme di produzione, in particolare la produzione contadina. In questi casi, infatti, la coercizione extraeconomica esercitava un ruolo maggiore nell’organizzazione della produzione e nell’estrazione di pluslavoro e lo stato agiva non soltanto in appoggio alle classi proprietarie ma, similmente allo stato precapitalistico, anche come diretto appropriatore. In breve dove il conflitto economico e quello politico apparivano immediatamente come inseparabili e lo stato rappresentava un nemico di classe più visibile e centralizzato. Di contro, nei paesi a capitalismo sviluppato la lotta di classe, che nella storia ha sempre riguardato il potere sul pluslavoro, tende a convogliarsi nel luogo della produzione perché è lì che si concentra e si esercita questo potere. In altri termini la lotta di classe da politica diventa economica, trasformandosi tendenzialmente in qualcosa di locale e particolaristico. Una lotta che riguarda i termini e le condizioni di lavoro che, per quanto feroce possa essere, non mette direttamente in questione il rapporto tra capitale e lavoro, almeno finché non esce dalle mura dei luoghi di lavoro.
Non è un caso, sostiene ancora Meiksins Wood, che le moderne rivoluzioni si siano verificate laddove il modo di produzione capitalistico era meno sviluppato e coesisteva con più antiche forme di produzione, in particolare la produzione contadina. In questi casi, infatti, la coercizione extraeconomica esercitava un ruolo maggiore nell’organizzazione della produzione e nell’estrazione di pluslavoro e lo stato agiva non soltanto in appoggio alle classi proprietarie ma, similmente allo stato precapitalistico, anche come diretto appropriatore. In breve dove il conflitto economico e quello politico apparivano immediatamente come inseparabili e lo stato rappresentava un nemico di classe più visibile e centralizzato. Di contro, nei paesi a capitalismo sviluppato la lotta di classe, che nella storia ha sempre riguardato il potere sul pluslavoro, tende a convogliarsi nel luogo della produzione perché è lì che si concentra e si esercita questo potere. In altri termini la lotta di classe da politica diventa economica, trasformandosi tendenzialmente in qualcosa di locale e particolaristico. Una lotta che riguarda i termini e le condizioni di lavoro che, per quanto feroce possa essere, non mette direttamente in questione il rapporto tra capitale e lavoro, almeno finché non esce dalle mura dei luoghi di lavoro.
A maggior ragione, come già accennato, il conflitto tra i diversi attori nella sfera politica, non potendo oltrepassare il suo limitato ambito di competenza, non è in grado di prendere di petto il tema del rapporto tra capitale e lavoro. Ma, a differenza del conflitto che si dà sul luogo della produzione, è in grado, per così dire, di sublimarlo. Proprio per questo nella sfera politica si può dare una ricomposizione spettacolare tra economico e politico. Una ricomposizione di cui abbiamo un esempio nell’esito dell’ultima crisi di governo. Non c’è nulla di più spettacolare, infatti, di un salvatore della patria cui vengono attribuiti connotati spudoratamente eroici: “Super Mario” Draghi, appunto. Un individuo straordinario che ha già mostrato le sue eccezionali capacità decisionali quando, come ci viene ripetutamente ricordato, affermò in pubblico che per salvare l’euro avrebbe fatto “whatever it takes”. Frase che si concludeva così: “And believe me, it will be enough”. Una dichiarazione che starebbe bene in bocca anche al più coatto dei cowboy hollywoodiani.
Draghi è con ogni evidenza un esponente di spicco dell’élite economico-finanziario europea chiamato a rimediare al fallimento della politica nazionale. Non è perciò esagerato parlare di un commissariamento dell’Italia da parte del capitale finanziario continentale sotto lo sguardo attento dei poteri atlantici. Però, a ben vedere, c’è qualcosa di più da dire. La questione ripetutamente sollevata sulla natura tecnica o politica del suo governo, per quanto stucchevole, indica in modo confuso una difficoltà reale che affiora dalla profondità della crisi socio-economica in corso: è proprio l’andamento dell’economia, così come governato dal capitale, a costituire un problema. In altri termini, sebbene in modo tutt’altro che trasparente, affiora la necessità di scelte, propriamente politiche, che modifichino questo andamento interferendo con il governo capitalistico della produzione. Questo, per meglio dire, è il fantasma che va esorcizzato.
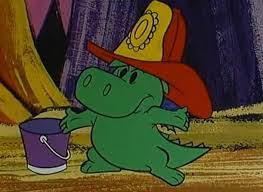 Prendiamo il caso della campagna vaccinale, uno dei compiti prioritari cui si dovrebbe dedicare il nuovo governo. E’ chiaro che le decisioni sovrane delle case farmaceutiche, basate ovviamente sulla ricerca del massimo profitto, sono un ostacolo fondamentale per una efficiente programmazione della campagna di immunizzazione di massa. Il potere e gli enormi profitti delle grandi imprese farmaceutiche sono normalmente giustificati dal loro ingente investimento nella creazione di nuovi farmaci. Ma le cose non stanno così. Con riferimento agli Stati Uniti, Marianna Mazzuccato rilevava qualche anno fa come tra il 1994 e il 2003 siano stati gli Istituti Nazionali di Sanità finanziati dal governo americano a condurre le ricerche che hanno portato a tre quarti dei nuovi farmaci (le cosiddette nuove entità molecolari), mentre le case farmaceutiche si limitavano ad investire prevalentemente sulle varianti meno rischiose (in termini di profitti attesi) dei farmaci già esistenti.4 Con la crisi pandemica l’impegno pubblico sarà con ogni probabilità ancora più significativo. Soltanto il governo statunitense, nell’ambito dell’Operazione Warp Speed, avrebbe inizialmente stanziato 9 miliardi di dollari per finanziare lo sviluppo e la produzione dei vaccini. Ma non è tutto. La scelta dei vaccini come arma principale, se non unica, per sconfiggere la pandemia non è un’opzione obbligata come dimostrano le efficienti strategie di contenimento messe in atto principalmente dai paesi asiatici (per non parlare di Cuba). Si tratta in realtà di una scelta dettata dagli interessi di Big Pharma che in tutto l’Occidente ha trasformato la medicina in senso ospedale-centrico e farmaco-centrico, trascurando prevenzione e medicina territoriale.5
Prendiamo il caso della campagna vaccinale, uno dei compiti prioritari cui si dovrebbe dedicare il nuovo governo. E’ chiaro che le decisioni sovrane delle case farmaceutiche, basate ovviamente sulla ricerca del massimo profitto, sono un ostacolo fondamentale per una efficiente programmazione della campagna di immunizzazione di massa. Il potere e gli enormi profitti delle grandi imprese farmaceutiche sono normalmente giustificati dal loro ingente investimento nella creazione di nuovi farmaci. Ma le cose non stanno così. Con riferimento agli Stati Uniti, Marianna Mazzuccato rilevava qualche anno fa come tra il 1994 e il 2003 siano stati gli Istituti Nazionali di Sanità finanziati dal governo americano a condurre le ricerche che hanno portato a tre quarti dei nuovi farmaci (le cosiddette nuove entità molecolari), mentre le case farmaceutiche si limitavano ad investire prevalentemente sulle varianti meno rischiose (in termini di profitti attesi) dei farmaci già esistenti.4 Con la crisi pandemica l’impegno pubblico sarà con ogni probabilità ancora più significativo. Soltanto il governo statunitense, nell’ambito dell’Operazione Warp Speed, avrebbe inizialmente stanziato 9 miliardi di dollari per finanziare lo sviluppo e la produzione dei vaccini. Ma non è tutto. La scelta dei vaccini come arma principale, se non unica, per sconfiggere la pandemia non è un’opzione obbligata come dimostrano le efficienti strategie di contenimento messe in atto principalmente dai paesi asiatici (per non parlare di Cuba). Si tratta in realtà di una scelta dettata dagli interessi di Big Pharma che in tutto l’Occidente ha trasformato la medicina in senso ospedale-centrico e farmaco-centrico, trascurando prevenzione e medicina territoriale.5 E si tratta anche di una scelta che consente di alimentare una perniciosa illusione a beneficio del potere capitalistico complessivamente inteso: si può contrastare l’epidemia proseguendo nel nostro stile di vita quasi come se nulla fosse. Business as usual. Avremmo a che fare, in altri termini, con un’opzione che, per sconfiggere la pandemia, non necessiterebbe, nel breve periodo, di adottare provvedimenti coercitivi sul governo capitalistico dell’economia evitando la limitazione del movimento di merci e persone (leggi lockdown) e, nel medio-lungo periodo, di ripensare un modello di sviluppo che stravolgendo gli ecosistemi planetari favorisce la possibilità del salto di specie dei virus.
E si tratta anche di una scelta che consente di alimentare una perniciosa illusione a beneficio del potere capitalistico complessivamente inteso: si può contrastare l’epidemia proseguendo nel nostro stile di vita quasi come se nulla fosse. Business as usual. Avremmo a che fare, in altri termini, con un’opzione che, per sconfiggere la pandemia, non necessiterebbe, nel breve periodo, di adottare provvedimenti coercitivi sul governo capitalistico dell’economia evitando la limitazione del movimento di merci e persone (leggi lockdown) e, nel medio-lungo periodo, di ripensare un modello di sviluppo che stravolgendo gli ecosistemi planetari favorisce la possibilità del salto di specie dei virus.
Insomma proprio quando appare che alla politica venga richiesto uno sforzo straordinario per modificare il corso degli eventi nella realtà accade che gli vengono negati gli strumenti per agire. Solo lo spettacolare intervento di un eroe ci può aiutare in un compito così disperato e al tempo stesso così importante. Vediamo dunque che tutto si raddoppia e si capovolge. La sfera economica invade quella politica, ma è la politica che deve apparire in grado come non mai di governare l’economia: la prassi sociale, direbbe Debord, si è scissa in realtà e immagine. In altri termini la politica può riprendere il comando solo negando se stessa. L’appoggio praticamente unanime al governo Draghi nega infatti uno degli elementi essenziali che si suppone debba caratterizzare la sfera politica moderna: quel politeismo dei valori che implica la possibilità di effettuare scelte diverse, o anche divergenti, nel governare il bene comune.
E allora di fronte al fantastico mondo di Super Mario chiudiamo ribadendo di nuovo alcune banalità di base, utilizzando le parole di Meiksins Wood: “le battaglie puramente ‘politiche’ sul potere di governare e dirigere, rimangono incompiute finché non coinvolgono oltre alle istituzioni dello stato anche il potere politico che è stato privatizzato e trasferito nella sfera economica. In questo senso, è proprio la differenziazione dell’economico e del politico nel capitalismo – la simbiotica divisione del lavoro tra stato e classe – ciò che rende propriamente essenziale l’unità delle lotte politiche ed economiche e che deve rendere sinonimi socialismo e democrazia”.6
