di Gioacchino Toni
 Consapevoli che lo sguardo sull’alterità è inevitabilmente anche uno sguardo su se stessi, sulla propria identità, alcune opere cinematografiche, uscite all’aprirsi degli anni Ottanta – Alien (id, 1979) e Blade Runner (id, 1982), entrambe di Ridley Scott, La cosa (The Thing, 1982) di John Carpenter e per certi versi Videodrome (id. 1983) di David Cronenberg, insieme a qualche suo altro film gravitante attorno alla “nuova carne” –, hanno affrontato in maniera del tutto nuova le montanti paure identitarie del periodo costringendole al confronto con alterità sempre più spaventose.
Consapevoli che lo sguardo sull’alterità è inevitabilmente anche uno sguardo su se stessi, sulla propria identità, alcune opere cinematografiche, uscite all’aprirsi degli anni Ottanta – Alien (id, 1979) e Blade Runner (id, 1982), entrambe di Ridley Scott, La cosa (The Thing, 1982) di John Carpenter e per certi versi Videodrome (id. 1983) di David Cronenberg, insieme a qualche suo altro film gravitante attorno alla “nuova carne” –, hanno affrontato in maniera del tutto nuova le montanti paure identitarie del periodo costringendole al confronto con alterità sempre più spaventose.
In un suo recente libro Boris Battaglia, Alien. Nascita di un nuovo immaginario (Armillaria, 2019), sottolinea sin dal sottotitolo come a suo parere sia proprio la pellicola del 1979 di Ridley Scott a dare/portare alla luce un nuovo immaginario: ed in effetti quest’opera sembra davvero inaugurare una nuova stagione e non solo dal punto di vista cinematografico.
Battaglia ricostruisce dettagliatamente la genesi di Alien a partire dalle vicende dello sceneggiatore Dan O’Bannon che, dopo aver inutilmente lavorato con Alejandro Jodorowsky alla sceneggiatura per un film tratto dal romanzo Dune (1965) di Frank Herbert, si cimenta insieme a Ronald Shusett nella scrittura di una storia incentrata su di un demone dello spazio poi presentata, tramite Walter Hill, ad Alan Ladd della 20th Century Fox. Quella sceneggiatura viene poi ripresa e modificata da Hill assecondando l’idea di Ladd di sostituire il protagonista maschile previsto da O’Bannon con una donna sull’onda del recente successo della principessa Leila Organa di Guerre stellari (Star Wars, 1977) di George Lucas e, forse, con l’intento di richiamare l’immaginario ruotante attorno alla protagonista del film Barbarella (1968) di Roger Vadim. Pur andando in porto l’idea di affidare il ruolo di protagonista a un’attrice, circa le caratteristiche del personaggio da lei interpretato le cose vanno diversamente rispetto a quanto auspicato dalla 20th Century Fox.
Una volta scelto per la regia l’inglese Ridley Scott, fresco del debutto dietro alla macchina da presa con I duellanti (The Duellists, 1977), si è trattato di pensare alle sembianze da dare all’entità aliena affinandosi alla fantasia di Hans Ruedi Giger, autore dell’inquietante raccolta Necronomicon (1977) pubblicata in quel periodo. Abbandonate le forme tutto sommato umanoidi degli alieni della fantascienza tradizionale, il mostro proposto dallo svizzero – poi realizzato da Carlo Rambaldi – si presenta come un enorme insetto con la coda e l’esoscheletro dall’evidente simbologia sessuale in tutte le forme che assume (facehugger, chestbuster e adulto) che, sostiene Battaglia, parrebbe rimandare ai peggiori aspetti dell’uomo.
lo xenomorfo di Giger è un costrutto immaginativo primordiale, che irrompe con inaudita e reale violenza nel nostro immaginario, e attraverso il quale ci è possibile indagare ciò che più ci rende umani: la paura di noi stessi. Non si scappa: lo xenomorfo […] siamo noi con forma diversa. Ma al contempo lo xenomorfo è altro da noi1.
Secondo Battaglia tra le caratteristiche che rendono lo xenomorfo proposto da Giger davvero altro rispetto all’umano vi è l’assenza di occhi che lo priva della possibilità di contatto. A rendere attuale Alien non sono gli effetti speciali, che a distanza di tempo mostrano impietosamente tutta la loro obsolescenza, quanto piuttosto le modalità con cui «viene mostrato quello che c’è da mostrare, ovvero la nostra paura del contatto»2. Ed in effetti, come negli altri film citati precedentemente, l’opera di Scott è imperniata sulla paura del contatto.
Se la genesi di Alien può aver tratto suggestioni dai racconti di Robert Anson Heinlein e da film come Il mostro dell’astronave (It! The Terror from Beyond Space, 1958) di Edward L. Cahn, non di meno, secondo Battaglia, deve essere messa in relazione con l’emergere di diversi indicatori di cambiamento che caratterizzano il momento storico-culturale nordamericano. Ed indicatori in tal senso, sostiene l’autore, possono persino essere le mutate modalità con cui sul finire degli anni Settanta si guarda al surf ed all’autostop, pratiche fino ad allora associate ad immaginari libertari.
Proprio in chiusura di decennio, nota Battaglia, il surf smette di rimandare all’immaginario hippie per trasformarsi in metafora bellica. Non a caso il Vietnam aleggia in Un mercoledì da Leoni (Big Wednesday, 1978) di John Milius e, a maggior ragione, è al centro di Apocalypse Now (id., 1979) di Francis Ford Coppola, ove l’immaginario statunitense ricorre proprio alla metafora del surf per autoconvincersi della propria superiorità nei confronti del nemico: Charlie don’t surf.
Lo spettatore, come il surfista e come l’attore, trova la propria soddisfazione nell’inquietante presenza del peggio che potrà capitare. […] Come il surfista, anche lo spettatore, scivolando su un elemento tutto sommato indifferente alla sua vita (per il surfista è l’onda, per lo spettatore è la pellicola), desidera che quel momento non termini mai, ma a differenza del surfista lo spettatore può fare pulizia di ogni speranza […] godendosi lo spettacolo dell’imprevedibile, dell’incognito e della tragedia3.
È lo stesso equipaggio dell’astronave Nostromo ad assomigliare, continua Battaglia, ad una banda di surfisti che, come si conviene, «ha un unico interesse: la soddisfazione del proprio desiderio. Non sono animati, come invece accadeva per i protagonisti della fantascienza classica, dalla volontà di conoscenza, e nemmeno dal desiderio di avventura. L’unico motivo che spinge l’equipaggio della Nostromo, Ripley compresa, è il compenso per il lavoro svolto»4. Evidentemente questi novelli surfisti della Nostromo hanno sostituito il soddisfacimento di un desiderio ludico-gratuito con uno di ordine prescrittivo-lavorativo. Come a dire “È uno sporco lavoro quello che dobbiamo portare a termine… ma è quello per cui siamo pagati e di metterlo in discussione non se ne parla”. Insomma, benvenuti negli anni Ottanta.
Lo stesso autostop si è rapidamente trasformato nel corso degli anni Ottanta da esperienza conoscitiva e di condivisione esaltata dalla beat generation a potenziale, se non scontato, momento di pericolo di cui occorre aver paura.
Il momento in cui è cominciato questo radicale cambiamento di paradigma culturale ce lo ha mostrato Ridley Scott quando, contravvenendo al protocollo e alla decisione del tenente Ripley, […] Ash fa salire a bordo della Nostromo un passeggero alieno. […] è in questo preciso momento, attraverso quello che possiamo definire il contatto con l’autostoppista xenomorfo, che la nostra paura comincia a diffondersi e il paradigma a cambiare5.
Tornando alla protagonista femminile di Alien, Battaglia sottolinea come la speranza della produzione di avere come protagonista una sorta di novella Barbarella venga sostanzialmente rifiutata da Scott a cui non interessa affatto riproporre un’eroina che, per quanto autodeterminata, resti sostanzialmente prigioniera dello sguardo maschile. Al regista di Alien interessa piuttosto creare un personaggio in linea con una certa fluidità del gender – cosa che «non comporta l’indistinzione o la neutralità, in quanto ogni esperienza, avvenendo attraverso il corpo, è sessuata»6 – utile a generare un’immedesimazione nel tenente Ripley che vada al di là della mera biologia. Ed infatti, sottolinea Battaglia, Sigourney Weaver usa – «surfandoci sopra» – la fluidità del genere, sia sessuale che narrativa, per costruire sul personaggio di Ripley un’identità del tutto originale.
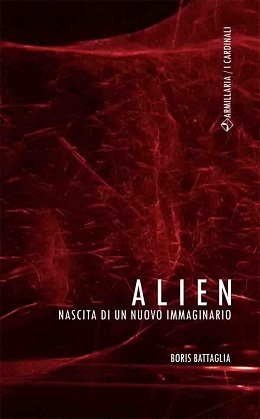 Non è infrequente imbattersi in film horror in cui la protagonista femminile, restata l’ultima sopravvissuta all’interno di un gruppo annientato dalla ferocia di qualche essere mostruoso, venga salvata da un intervento esterno o che, in alternativa, riesca ad annientare il mostro in maniera del tutto fortuita. Anche nell’opera di Scott si ha in Ripley l’unica a sopravvivere allo xenomorfo, ma in questo caso nessuno deve venire a salvarla, la protagonista è consapevole di doversi arrangiare e si mostra pronta a prendere il controllo della situazione ogni qual volta è necessario giungendo ad eliminare lo xenomorfo non certo per fortuna ma grazie a una tattica ben precisa.
Non è infrequente imbattersi in film horror in cui la protagonista femminile, restata l’ultima sopravvissuta all’interno di un gruppo annientato dalla ferocia di qualche essere mostruoso, venga salvata da un intervento esterno o che, in alternativa, riesca ad annientare il mostro in maniera del tutto fortuita. Anche nell’opera di Scott si ha in Ripley l’unica a sopravvivere allo xenomorfo, ma in questo caso nessuno deve venire a salvarla, la protagonista è consapevole di doversi arrangiare e si mostra pronta a prendere il controllo della situazione ogni qual volta è necessario giungendo ad eliminare lo xenomorfo non certo per fortuna ma grazie a una tattica ben precisa.
A differenza di chi ha visto in Ripley un surrogato maschile, una trovata della produzione affinché vi si potesse identificare tanto il pubblico femminile quanto quello maschile, Battaglia sottolinea invece come l’intero equipaggio della Nostromo manchi sostanzialmente di caratterizzazione sessuale, l’unica forma di sessualità espressa è quella dell’essere xenomorfo. Certo, Ripley, per quasi tutto il film, al pari del resto dell’equipaggio, si presenta come personaggio intersessuale ma
se Scott cancella dalla narrazione il tipo di esperienza sessuata che deriva dalle basi culturali di una società, non può cancellare certo quella fisica. Infatti mantiene per tutti i membri dell’equipaggio la differenza di genere (che è sessuata anche solo per le differenze fisiche). Tutti e sette hanno un’identità di genere genetica, ma su di essa non pesano ancora – quasi fossero tutti novelle creature nell’Eden (che poi si rivela un inferno) – le sovrastrutture culturali che dettano le regole dei comportamenti sessuali standardizzati dalla cultura che li genera. Infatti, sarà solo attraverso la sessualità dell’alieno che, da una situazione asessuata, si avvia una presa di posizione sessuale piena. Nella sequenza finale, quella in cui uccide lo xenomorfo, il corpo di Ripley, spogliato, compie una scelta. Una scelta divenuta obbligata nel momento in cui l’alieno, attraverso il parto biologico, ha introdotto la sessualità in questa enclave, rompendone ogni equilibrio. Una scelta di campo e di sessualità. Ripley si salverà perché sarà l’unica a farla.7.
Una delle scene centrali del film è sicuramente il momento in cui il mostro esce dalla pancia di Kane; ad inquietare il pubblico, più che la violenza della sequenza, secondo Battaglia è la presa d’atto della necessità di mettersi in gioco per godersi il film ed accettare che a partire dallo stupro facciale messo in atto dal facehugger nei confronti di Kane il corpo maschile di quest’ultimo assuma un inaspettato ruolo riproduttivo.
Cadono così, anche nella fiction, certezze identitarie: tutto diviene fluido e ci si trova a dover scegliere se «surfare» su tale fluidità o chiudersi a riccio in un monolite identitario tramandato. Film come Alien, Blade Runner, La cosa e Videodrome non hanno evidentemente alcuna intenzione rassicurante, nascono sulle inquietudini per dispensare dubbi ma è però proprio in questi ultimi che si annida qualche pallida speranza mentre, al contrario, nel regno delle certezze più facilmente dimora la disperazione.
Lee E. Heller8 ha notato come negli anni Ottanta e Novanta le relazioni eterosessuali siano state insistentemente descritte dai media come caratterizzate da conflitti e differenze insormontabili tra i generi, quasi che uomini e donne non possano che considerarsi reciprocamente specie aliene. Scrive a tal proposito Nicholas Mirzoeff:
Una delle proteste principali in questa guerra dei generi è, per usare il popolare titolo di un’opera, Gli uomini che non sanno essere intimi. Sotto questo aspetto, tutti gli uomini sono replicanti. Il personaggio di Harrison Ford, Rick Deckard, l’eroe, è un “Blade Runner”, il cui compito è “mettere a riposo” i replicanti, uccidendoli. Ma quando Deckard alla fine fugge con la replicante Rachel, un avanzato modello femminile, ciò sembra perfettamente appropriato. Deckard può ora avere la donna perfetta delle fantasie maschili, che non farà alcuna irritante richiesta di intimità emotiva. D’altro canto, la versione del 1992 del montaggio del regista accenna al fatto che Deckard stesso potrebbe essere un replicante, rendendo Rachel e Deckard la perfetta coppia androide. Blade Runner ha fuso le tematiche di razza e genere, messe in scena da La cosa, nella singola persona del replicante. La paura inespressa è che tutti i corpi umani siano già cambiati così tanto, che sia comunque difficile capire la differenza tra esseri umani e macchine. Tant’è vero che ci vogliono cento domande, prima che persino un veterano come Deckard possa capire che Rachel è un replicante9.
Mirzoeff sottolinea che film come Alien e Blade Runner – ma qualcosa di analogo accade anche in Videodrome – presentano un futuro in cui le conquiste tecnologiche
hanno permesso di emergere a una cultura aziendale globale, motivata esclusivamente dal profitto. In Alien, la Compagnia preferirebbe la sopravvivenza delle specie aliene maligne, piuttosto che del suo equipaggio, mentre Blade Runner presenta un mondo in cui tutte le parti dei corpi umani sono in vendita senza difficoltà. Entrambi invitano il pubblico a considerare le corporation responsabili – l’una di aver creato i replicanti, l’altra di aver salvato l’alieno più inumano di qualunque altra specie aliena o androide10.
Nella denuncia alle corporation è possibile leggere un’accusa a quel capitalismo che, come scrive Rosi Braidotti, ormai da tempo ha palesato il suo essere «un sistema tendente all’auto-implosione che non si ferma davanti a nulla pur di realizzare il suo obiettivo: il profitto. Questo sistema intrinsecamente auto-distruttivo nutre, per poi distruggere, le condizioni stesse della sua sopravvivenza: è onnivoro e in ultima analisi ciò che mangia è il futuro in sé»11
Se in termini di rappresentazione dell’essere alieno questa generazione di opere dei primi anni Ottanta, sostiene Mirzoeff, oscilla tra rinnovamento e recupero di alcuni tratti dell’immaginario degli anni Cinquanta, resta il fatto che prospetta una nuova e drammatica visualizzazione distopica del futuro. Blade Runner, ad esempio, offre quella che Vivian Sobchak12 ha efficacemente definito un’immagine “trash” di quei radiosi scenari futuristici tipici del genere, prospettando una Los Angeles per certi versi obsolescente e non troppo lontana nel tempo, una metropoli caotica, cosmopolita, immersa nel buio e battuta da una pioggia incessante e marcata da una rigida suddivisione di classe verticale in cui i poveri vivono nelle strade ed i ricchi nell’aria.
Analogamente, continua Mirzoeff, Alien rende “trash” l’astronave, vero e proprio emblema del progresso tecnologico, presentandola umida, cupa e «costruita in modo tale che il suo spazio sia allo stesso tempo femminile, nella sua scura umidità, e orientale, attraverso un labirinto infinito di depositi, condotti di aerazione, e passaggi»13. Anziché l’ansiogena geopolitica della guerra fredda il film sembra mettere in scena quelle inquietudini di genere, classe e identità che attraversano gli Stati Uniti a cavallo tra anni Settanta e Ottanta.
Tanto Blade Runner quanto Alien, come già aveva fatto l’Invasione degli ultracorpi (Invasion of the Body Snatchers, 1956) di Don Siegel, individuano il mostruoso nella replica degli esseri umani, quasi a suggerire che la mostruosità aleggia anche in questi ultimi. In Alien, ad esempio, si scopre che l’ufficiale scientifico Ash è in realtà un androide programmato per far sopravvivere l’essere alieno, una creatura che, abbandonate le movenze rallentate dei mostri degli anni Cinquanta, si muove velocemente ed è abile nel nascondersi.
La seconda ondata di femminismo in Occidente aveva ottenuto diritti relativi alla riproduzione, il diritto di scelta della donna, e spingeva per una legge sulle pari opportunità negli Stati Uniti. Questo contesto rende l’ossessione della riproduzione parassita dell’alien più di un semplice artificio testuale. L’alieno impianta un feto in un maschio umano da un bozzolo simile a una pianta, ricordando l’Invasione degli ultracorpi. Il neonato alieno in seguito esplode fuori dallo stomaco della sua vittima, portandola alla morte – come a mettere in guardia dalle conseguenze della distruzione dei “naturali” processi riproduttivi14.
Blade Runner mette in scena l’ossessione per l’individuazione e l’eliminazione di replicanti ribelli indistinguibili dagli esseri umani se non per la mancanza di emozioni; si tratta di una distinzione ricorrente nell’ambito della fantascienza tanto che la si trova nel film Invasione degli ultracorpi del 1956. Nel film di Scott si fatica però a non provare un minimo di simpatia per i replicanti, quando non veri e propri momenti di identificazione, condannati come sono a una vita breve e programmata da una cinica corporation.
Mirzoeff coglie anche l’importanza rivestita dalla fotografia nella trama di Blade Runner: essa si rivela utile nel rintracciare i replicanti ed è proprio a fotografie contraffatte che ricorre la corporation nel momento in cui impianta in essi una memoria. Riflettendo sullo status della fotografia come indice di realtà il film sottolinea la manipolabilità dell’immagine fotografica nell’era elettronica e l’incapacità dei sensi umani di discernere tra reale e rappresentazione, dunque la fine della credenza acritica in ciò che si vede.
Su riflessioni di tal tipo insiste Videodrome di Cronenberg nel suo porre inquietanti interrogativi circa la natura riproduttiva delle immagini e circa il rapporto di fascinazione/repulsione che l’occhio umano prova al cospetto dei propri sogni/incubi reificati e riprodotti in un loop senza fine dagli schermi. È un mondo condannato a vivere in uno stato di perenne allucinazione quello messo in scena dal canadese, abitato da esseri umani programmabili. Davvero in anticipo di alcuni decenni rispetto alla serie televisiva Black Mirror (Id., dal 2011 – in produzione, Channel 4; Netflix), riflettendo sul consumo di immagini, Videodrome fa provare direttamente allo spettatore gli splendori e le miserie insite nel desiderio di consumo tecnologico delle immagini. [Al cinema di Cronenberg è dedicata la serie di scritti Processi di ibridazione su Carmilla].
 Un interessante confronto tre La cosa da un altro mondo (The Thing from Another World, 1951) di Christian Nyby ed Howard Hawks e La cosa (The Thing, 1982) di John Carpenter è proposto da Mirzoeff che segnala come nelle due versioni liberamente derivate dal racconto La cosa da un altro mondo (Who Goes There?, 1938) di John W. Campbell sia ravvisabile il passaggio dal contesto della guerra fredda all’età “postmoderna” e con esso un vero e proprio mutamento di immaginario.
Un interessante confronto tre La cosa da un altro mondo (The Thing from Another World, 1951) di Christian Nyby ed Howard Hawks e La cosa (The Thing, 1982) di John Carpenter è proposto da Mirzoeff che segnala come nelle due versioni liberamente derivate dal racconto La cosa da un altro mondo (Who Goes There?, 1938) di John W. Campbell sia ravvisabile il passaggio dal contesto della guerra fredda all’età “postmoderna” e con esso un vero e proprio mutamento di immaginario.
Nella versione degli anni Cinquanta, ambientata in una base aerea statunitense in Alaska, aleggia il timore di un possibile attacco sovietico dal Polo ed è sospettando un coinvolgimento dei russi che, saputo di un disastro aereo vicino al polo, il capitano Pat Hendry decide di indagare sull’accaduto, salvo poi trovarsi poi di fronte ad un essere alieno simile ad una pianta che si nutre di sangue. Nonostante la ritrosia dello scienziato Carrington che, al pari di tanti altri suoi colleghi che si incontrano nella fantascienza, non esita a sacrificare vite umane per poter condurre le sue ricerche, l’equipaggio statunitense decide di eliminare l’entità aliena. Di fronte all’invulnerabilità di quest’ultima alle pallottole spetta a Nikki Nicholson, l’unica donna del gruppo, proporre una soluzione alternativa: se l’alieno è una pianta, allora non resta che provare a “cuocerlo”.
Questa opposizione tra logica pura (maschile) e intuizione (femminile) è un elemento fondamentale nel dibattito della fantascienza sull’essenza dell’umanità. Anche se la science fiction si risolve quasi sempre con la forza, sono spesso gli attributi femminili di emozione e intuizione che segnano la differenza tra uomini e alieni, e permettono la vittoria umana15.
Se i protagonisti dei film degli anni Cinquanta si mostrano certi della netta distinzione tra se stessi e gli alieni, nel remake di Carpenter gli umani sono alla ricerca di conferme circa il loro essere restati tali. Se la minaccia nella prima pellicola è identificabile con un nemico esterno (i sovietici), agli albori di un mondo che, perdendo le sue certezze, sembra avviarsi verso trasformazioni che condurranno alla globalizzazione e alla digitalizzazione, i timori derivano piuttosto dalla difficoltà di definire “cosa” stia divenendo l’umano. È forse questa l’angoscia a cui allude la difficoltà e l’urgenza dei protagonisti di distinguersi dagli alieni.
Nel ripetere a se stesso “I know I’m human” McReady, il protagonista del remake di Carpenter, pur alludendo al timore di non essere effettivamente biologicamente diverso dagli alieni, tradisce anche un più o meno consapevole timore della “mescolanza razziale” e soprattutto, secondo Mirzoeff, uno strenuo tentativo di difesa del proprio orientamento (etero)sessuale. A differenza del film degli anni Cinquanta, nel remake di Carpenter tutti i personaggi umani sono maschi.
Nel suo mondo omosociale, l’alieno porta alla luce l’omofobia delle istituzioni esclusivamente maschili. Allo stesso tempo, il test del sangue per l’umanità di McReady evoca chiaramente le paure della mescolanza razziale. Anche se il mostro è sconfitto, McReady è lasciato ad attendere la morte per ipotermia alla fine del film, dopo la distruzione della base con il fuoco. Il futuro non è più un posto migliore, ma semplicemente un altro luogo in cui mettere in scena le nostre ansie culturali16.
Nel bene e nel male, i primi anni Ottanta hanno davvero rappresentato un importante spartiacque politico, culturale ed estetico. È in quel pugno di anni che molto – tutto sarebbe forse troppo – cambia. Film come Alien, Blade Runner, La cosa e Videodrome hanno sapientemente fornito immagine ad un nuovo immaginario contribuendo allo stesso tempo a crearlo. Non è stato che l’inizio… la storia continua (dentro e fuori gli schermi).
