di Franco Pezzini
 Lettori, ancora uno sforzo se volete essere sadiani
Lettori, ancora uno sforzo se volete essere sadiani
Paolo Bellini, Lorenzo Rustighi, Erasmo Silvio Storace, Il potere sadico. Politica e nichilismo in D.A.F. de Sade, a cura di Erasmo Silvio Storace, pp. 100, € 12, Meltemi, Milano 2017.
Alberto Brodesco, Sguardo, corpo, violenza. Sade e il cinema, pp. 368, € 24, Mimesis, Sesto San Giovanni MI 2014.
Passato da qualche anno il bicentenario della morte (2 dicembre 1814), Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814) continua a conoscere rievocazioni e chiamate in causa: magari abusive, in quest’epoca di cinquanta sfumature di manette & catene su YouTube, dove di lui tripudiano di solito gli aspetti più grotteschi e superficiali. Nei fatti Sade si presenta sulla piazza culturale tra Sette e Ottocento con un ruolo di agitatore un po’ simile a quello di un libertino ben diverso, Aleister Crowley, tra Otto e Novecento: entrambi impresentabili, entrambi coi piedi ben saldi nei sogni e negli incubi del proprio tempo, entrambi necessari per capire correnti significative del mondo estremo in cui viviamo oggi, in chiave anche (non solo) pop. Insediato idealmente come ai limiti sfuggenti del campo visivo rispetto a una serie di insospettabili della letteratura (Dumas e Le Fanu, solo per fare due esempi) – in quella posizione cioè dove il lettore può non vederlo affatto, ma chi cerchi lo trova senza fatica – Sade non può che tornare di continuo in un mondo come il nostro: una sorta di anima inquieta, di spettro infestante le forme dei desideri del nuovo millennio, assai più presente di quei Cenobiti/Supplizianti di Clive Barker che pure gli devono parecchio, perché infinitamente più complesso e dunque pervasivo per molti rivoli.
Merita allora dar conto di alcuni recenti testi d’interesse che lo riguardano: a partire da due studi saggistici. Il primo, una breve raccolta, lo firmano da coautori Paolo Bellini, Lorenzo Rustighi, Erasmo Silvio Storace (anche curatore), col titolo Il potere sadico. Politica e nichilismo in D.A.F. de Sade, per Meltemi, 2017. Dove il contributo di Bellini che costituisce il primo capitolo, “L’utopia politica sadiana tra nichilismo e relativismo”, prende di petto il senso dell’opera Francesi ancora uno sforzo se volete essere repubblicani, contenuta all’interno del terribile dialogo sadiano La filosofia nel boudoir (1795) a riprendere i temi degli Opuscoli politici (1790-1799). L’autore non prende in esame le diverse interpretazioni critiche sul senso di questo problematico testo, scegliendo di assumerlo nella sua letteralità:
[…] la strategia concettuale seguita dall’autore consiste nel delegittimare la morale tradizionale, ereditata dalla cultura cristiana, introducendo al posto di Dio e di qualsiasi realtà trascendente, una concezione secondo la quale il cosmo intero consisterebbe in un perpetuo movimento, la cui arida meccanica legittima ogni piacere e ogni violenza.
Tutto questo, infatti, sarebbe coerente con il principio per cui ogni cosa è destinata alla decomposizione e a un’incessante trasformazione, sicché l’opera distruttiva del libertino lo renderebbe sostanzialmente prossimo alla vera essenza del reale. Quindi la società ideale, immaginata dall’autore, non è nient’altro che un gigantesco mattatoio, dove ogni essere vivente è sostanzialmente sottoposto all’arbitrio di coloro che hanno scoperto il segreto della vita e della natura, consistente nell’abusare degli altri e nell’annichilire ogni cosa.
La distopia sadiana, dunque, come inferno sulla terra in cui ogni uomo è radicalmente separato dall’altro, potenziali persecutori e nemici a vicenda.
Poco importa, in tal senso, che l’autore si proponga, di fatto, di superare la dicotomia tra bene e male, appellandosi a una natura intesa in senso puramente materialistico come movimento costante di distruzione e creazione in se stesso compiuto. Per il lettore dotato di un minimo di buon senso un tale ordine sociale, dominato dall’arbitrio e dalla licenza più sfrenata, è un vero e proprio incubo senza alcuna via d’uscita. Ciò che sostanzialmente viene del tutto meno, in questa breve fondazione teorica dell’immoralità come modo di esistere, è il senso del limite, sicché ogni possibile confine tra ciò che è lecito, morale, etico e ciò che non lo è, viene sostanzialmente cancellato. Si palesa, così, un insopprimibile desiderio di legittimare a ogni costo pratiche e atteggiamenti mentali abnormi, mostruosi e incontenibili, anche manipolando e decontestualizzando dati storici e antropologici di ogni genere, in modo da indurre il lettore a considerare l’eccezione come norma.
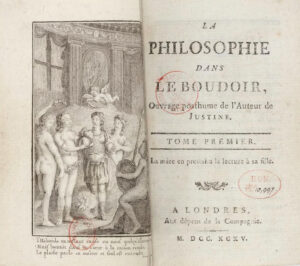 Si tratta in fondo di un esito ultimo ed estremizzato della riflessione libertina. Sembra di cogliere peraltro nel tono di Bellini la tensione polemica a un possibile contraddittorio (“Per il lettore dotato di un minimo di buon senso”, eccetera, probabilmente in polemica con gli entusiasti del Marchese) ed è indubbio che, a voler assumere quello di Sade come un sistema, l’insieme risulti abbastanza raggelante. Per Sade, sintetizza Bellini, non esiste alcuna forma di “sacro”, neppure nelle accezioni più laiche: l’assoluto è un ordine empirico del reale. Come istanze dell’entropia, i Lumi della ragione indicherebbero anzi vizio e crimine a connotare le relazioni umane, a fondamento di un nuovo sistema di valori sul piano etico, ma anche conseguentemente su quello politico. Ragione ed emozioni, in tale visione, sarebbero mosse essenzialmente da un istinto di distruzione: e la prima, legittimando le azioni più turpi, svelerebbe anche i propri limiti.
Si tratta in fondo di un esito ultimo ed estremizzato della riflessione libertina. Sembra di cogliere peraltro nel tono di Bellini la tensione polemica a un possibile contraddittorio (“Per il lettore dotato di un minimo di buon senso”, eccetera, probabilmente in polemica con gli entusiasti del Marchese) ed è indubbio che, a voler assumere quello di Sade come un sistema, l’insieme risulti abbastanza raggelante. Per Sade, sintetizza Bellini, non esiste alcuna forma di “sacro”, neppure nelle accezioni più laiche: l’assoluto è un ordine empirico del reale. Come istanze dell’entropia, i Lumi della ragione indicherebbero anzi vizio e crimine a connotare le relazioni umane, a fondamento di un nuovo sistema di valori sul piano etico, ma anche conseguentemente su quello politico. Ragione ed emozioni, in tale visione, sarebbero mosse essenzialmente da un istinto di distruzione: e la prima, legittimando le azioni più turpi, svelerebbe anche i propri limiti.
[…] in questa apologia del male vi è qualcosa di innegabilmente affascinante per il lettore post-moderno, che vi può trovare interessanti spunti di riflessione per un ripensamento critico della propria civiltà. In fondo Sade auspica un mondo dominato da una logica del piacere in cui il godimento maggiore e il miglior ordine civile consistono in un consumo ossessivo e totalizzante, che assume prevalentemente la forma dell’annientamento dell’altro e della sua dignità spirituale. Cosa, infatti, accade in una società di tal genere? Non avendo nessun altro narcotico di cui cibarsi per sfuggire al desolante spettacolo di una realtà dominata solo da un ordine naturale il cui fine ultimo è l’annichilimento di sé e degli esseri che lo popolano, il cittadino di Sade può soddisfare le proprie ansie e la propria desolante solitudine solo abusando dei suoi simili. Così, condannando perpetuamente ciascuno a un potenziale stato di assoggettamento al più forte, la mente può distogliere se stessa dal nulla cui sembra destinata dopo la morte. In un tale stato di insicurezza e di perenne sopraffazione, non resta quindi che l’ottundimento di ogni capacità di giudizio, attraverso un godimento mostruoso che non lascia spazio a nient’altro.
È questo il lato oscuro di ogni materialismo assoluto e totalizzante che, negando ogni dignità possibile a ciò che non ha densità empirica, si trova a dover gestire una realtà priva di senso, votata a un’esistenza così vana da avere come unico scopo solo la propria fine. Purtroppo questa è, per alcuni aspetti, la situazione in cui si trova la civiltà dei consumi di massa che, alla violenza come forma estrema di narcotizzazione (individuale e collettiva) e di ricerca del piacere, sostituisce il consumo come modo di costruzione di senso e di interpretazione di una realtà intesa in senso decisamente materialistico.
È proprio una vera meditazione sull’oscuro abisso che è racchiuso nel cuore di ogni essere pensante e cosciente di sé che viene stimolata dalla lettura di un’opera di tal genere. Essa, per questo suo aspetto, è profondamente attuale, in un mondo dove gli atti di violenza estrema e insensata si moltiplicano senza sosta e dove è molto faticoso insegnare alle nuove generazioni il senso del limite e della responsabilità individuale. In fondo la convivenza civile tipica del XXI secolo si regge su un equilibrio sottile tra pulsioni creative e atteggiamenti distruttivi, dettati dall’ansia per il proprio futuro e da un sostanziale spaesamento causato dalla complessità e la multiformità di questa civiltà globalizzata, in cui usi e costumi assai eterogenei entrano in contatto reciproco e spesso, inevitabilmente, confliggono tra loro. Da qui la tentazione, che si manifesta con una certa frequenza all’interno della civiltà occidentale, di adottare un relativismo culturale così radicale da legittimare in fondo qualsiasi atteggiamento etico e morale, in nome di un malinteso e presunto rispetto delle altre culture, che si traduce in una sostanziale resa del pensiero anche a ciò che sembra del tutto riprovevole e ripugnante. D’altronde lo stesso Sade, per quanto in modo sommario e del tutto improprio, si riferisce costantemente a dati di tipo antropologico, storico ed etnografico che hanno il fine di facilitare l’accettazione di bassezze, volgarità e depravazioni di ogni genere. In un senso legato, quindi, quasi esclusivamente alla strategia argomentativa, piuttosto che ai contenuti, la cui mostruosità del tutto iperbolica ne induce un assoluto e totale rifiuto, è possibile tuttavia tracciare un interessante parallelismo.
La civiltà occidentale post-coloniale divorata, infatti, da uno strano senso di colpa verso le altre culture, pur ovviamente evitando di legittimare in alcun modo le mostruosità pensate da Sade, sembra a volte scivolare pericolosamente lungo la china di un relativismo altrettanto semplicistico, dove sembra quasi che atteggiamenti e valori assolutamente riprovevoli, possano essere considerati legittimi e tollerati, se praticati all’interno di altre culture e civiltà. È proprio questo l’errore del relativismo più radicale, e lo stesso che Sade commette spesso in questo scritto, ovvero quello di promuovere un’usanza decontestualizzandola e arrivando ad ammetterla all’interno della propria cultura come se fosse perfettamente compatibile con il proprio stile di vita.
Di qui l’invito a ripensare il testo sadiano come un caveat sui rischi corsi da una “società liberale”, tale da spingere a leggere le relative pagine “con un misto di rabbia e inquietudine per il futuro della civiltà post-moderna”. Non entriamo in questa sede nel tema dello “strano senso di colpa verso le altre culture” (magari quelle brutalmente soffocate dal colonialismo occidentale?), in quelli degli orrori concretamente perpetrati da una “società liberale” senza scomodare Sade, o, nelle riflessioni successive allo stralcio riportato, nel tema dei “valori non negoziabili […] non necessariamente […] pensati in quanto assoluti” (e da considerare “piuttosto […] come parti irrinunciabili della propria identità culturale, la cui difesa permettere di garantire il benessere e la felicità del maggior numero possibile di individui”): si tratta di punti su cui una dialettica anche vivace porterebbe troppo distante dalla presente recensione. Non è in questione il carattere ulcerante delle riflessioni del pamphlet, il tipo di forzature retoriche cui Sade ricorre o la pericolosità dell’assunzione di certe tesi; e si può capire la sottesa polemica del critico contro chi beatifichi semplicisticamente il filosofo libertino. 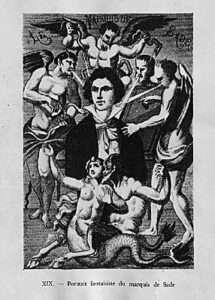 Il dubbio semmai, per il lettore, è se davvero il pamphlet si esaurisca in una tanto radicale e sterile apoteosi del Male – ma i successivi due contributi del volume arricchiranno notevolmente il quadro interpretativo – o se la riflessione sadiana non suoni anzitutto provocazione intellettuale, come interpreta un certo filone critico: e tanto più in un contesto dove chi si beava di idee tanto più morali l’aveva ingabbiato per un’insopportabile vita di quasi continua prigionia. Aggiungiamo che la prassi del Marchese, al di là di alcuni episodi molto strombazzati (ma ridicoli a fronte di ciò che perpetrava la cattolicissima nobiltà francese persino a corte, o agli eccidi in nome della virtù rivoluzionaria nel periodo successivo), non rispecchia affatto le terribilissime idee da lui fantasticate in gran parte nella sua solitudine prigioniera – dove è difficile immaginare quale cortocircuito interiore avremmo conosciuto noi stessi. Senza canonizzare fuori luogo l’uomo Sade, possiamo ricordare il suo senso personale di giustizia attestato dalla documentazione storica, la sua attenzione – assistenzialistica, sia pure – ai disagiati della regione, e per contro l’uso convulso del paradosso nella scrittura utopica/distopica del Settecento; come anche il clima spregevole e ipocrita della sua famiglia di provenienza, con genitori pessimi e un losco zio abate, che certo non poteva ben disporre il rampollo verso i “valori” più tradizionali. E tutto ciò senza entrare nel merito di ciò che la vecchia scuola considererebbe tout court l’orizzonte delle parafilie di Sade, o comunque un quadro patologico a monte della sua scrittura, mentre oggi andiamo più cauti: e resta molto difficile trarre un quadro clinico convincente dalla pur ricca documentazione su di lui.
Il dubbio semmai, per il lettore, è se davvero il pamphlet si esaurisca in una tanto radicale e sterile apoteosi del Male – ma i successivi due contributi del volume arricchiranno notevolmente il quadro interpretativo – o se la riflessione sadiana non suoni anzitutto provocazione intellettuale, come interpreta un certo filone critico: e tanto più in un contesto dove chi si beava di idee tanto più morali l’aveva ingabbiato per un’insopportabile vita di quasi continua prigionia. Aggiungiamo che la prassi del Marchese, al di là di alcuni episodi molto strombazzati (ma ridicoli a fronte di ciò che perpetrava la cattolicissima nobiltà francese persino a corte, o agli eccidi in nome della virtù rivoluzionaria nel periodo successivo), non rispecchia affatto le terribilissime idee da lui fantasticate in gran parte nella sua solitudine prigioniera – dove è difficile immaginare quale cortocircuito interiore avremmo conosciuto noi stessi. Senza canonizzare fuori luogo l’uomo Sade, possiamo ricordare il suo senso personale di giustizia attestato dalla documentazione storica, la sua attenzione – assistenzialistica, sia pure – ai disagiati della regione, e per contro l’uso convulso del paradosso nella scrittura utopica/distopica del Settecento; come anche il clima spregevole e ipocrita della sua famiglia di provenienza, con genitori pessimi e un losco zio abate, che certo non poteva ben disporre il rampollo verso i “valori” più tradizionali. E tutto ciò senza entrare nel merito di ciò che la vecchia scuola considererebbe tout court l’orizzonte delle parafilie di Sade, o comunque un quadro patologico a monte della sua scrittura, mentre oggi andiamo più cauti: e resta molto difficile trarre un quadro clinico convincente dalla pur ricca documentazione su di lui.
Quanto dunque dobbiamo considerare un certo filosofeggiare come effettiva teoria, e quanto come sofismi rabbiosi, provocazione letteraria dissacrante saettata alla Francia che al tempo della redazione l’ha scarcerato da poco (e magari buttata in faccia a indignati critici della posterità)? Con quel quid di eros nero che oggi il fruitore medio di un certo tipo di fantasie soddisfa davanti a un film: non bello, d’accordo, ma sorta di sfiato sociale comunque incompatibile con un ordine d’epoca che pretendeva di controllare poliziottescamente le anime o la ragione (salvo condannare al rogo i sodomiti). Evocare la concretezza dei lager – che hanno tutt’altra genesi filosofica e realtà storica alla base – come sorta di concretizzazione delle fantasie sadiane non ci aiuta a entrare nel labirinto delle intenzioni dell’autore in rapporto al pamphlet in questione.
Qualche chiave più problematica la offre il secondo capitolo/contributo, un saggio molto interessante, convincente e articolato a firma di Lorenzo Rustighi, “Justine contro Juliette, o del discorso del sovrano: i limiti della rappresentazione in Sade”, e sviluppa le implicazioni della lettura di Sade proposte da Michel Foucault in Le parole e le cose.
L’idea foucaultiana è che in Sade assisteremmo, ad un tempo, tanto all’apogeo quanto al definitivo sgretolarsi di ciò che chiama episteme classica, prodottasi sul finire del secolo XVI e fondata sul primato gnoseologico e ontologico della rappresentazione. Sade sarebbe l’ultima vera testimonianza di una teoria della conoscenza radicata nel potere rappresentativo dell’intelletto, di cui sperimenterebbe le estreme possibilità. In un certo senso, forse, si potrebbe perfino dire che l’interesse sadiano per quanto v’è di estremo nell’esperienza umana abbia a che fare proprio con questo suo sostare sui confini di un modo storicamente determinato della sua comprensione – Kant gli farà da specchio alla fine del XVIII secolo, sul limitare di ciò che Foucault chiama modernità. Maturità e crisi del linguaggio classico farebbero così per il marchese una cosa sola […].
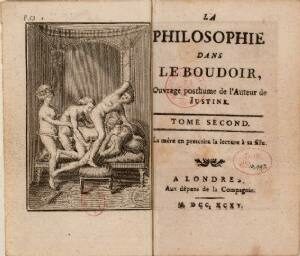 Come prisma d’analisi, Rustighi sceglie la categoria di souffrance, la sofferenza, tra gli oggetti privilegiati delle rappresentazioni di Sade. Alla luce dell’interpretazione foucaultiana, mostra anzitutto come la rappresentazione della sofferenza in Sade non solo abiti i limiti epistemici dell’età classica, ma abbia anche una certa vaga consapevolezza della propria condizione liminare (ecco perché i suoi libertini si adoperano “senza sosta per riaffermare e governare la potenza delle loro rappresentazioni, possibilità di cui Sade vede di fatto approssimarsi la fine”); quando il marchese insiste sull’importanza dell’immaginazione nel godimento, fa della rappresentazione l’esperienza fondamentale e forse la sola possibile – il solo teatro, letteralmente – per i suoi eroi libertini. Si pensi alla funzione degli specchi nel boudoir di Madame de Saint-Ange che moltiplicano il piacere raddoppiando all’infinito le rappresentazioni: fine ultimo dei personaggi di Sade è esattamente quello di comporre una serie continua di tableaux o scene, che per loro sono a pieno titolo scene teatrali.
Come prisma d’analisi, Rustighi sceglie la categoria di souffrance, la sofferenza, tra gli oggetti privilegiati delle rappresentazioni di Sade. Alla luce dell’interpretazione foucaultiana, mostra anzitutto come la rappresentazione della sofferenza in Sade non solo abiti i limiti epistemici dell’età classica, ma abbia anche una certa vaga consapevolezza della propria condizione liminare (ecco perché i suoi libertini si adoperano “senza sosta per riaffermare e governare la potenza delle loro rappresentazioni, possibilità di cui Sade vede di fatto approssimarsi la fine”); quando il marchese insiste sull’importanza dell’immaginazione nel godimento, fa della rappresentazione l’esperienza fondamentale e forse la sola possibile – il solo teatro, letteralmente – per i suoi eroi libertini. Si pensi alla funzione degli specchi nel boudoir di Madame de Saint-Ange che moltiplicano il piacere raddoppiando all’infinito le rappresentazioni: fine ultimo dei personaggi di Sade è esattamente quello di comporre una serie continua di tableaux o scene, che per loro sono a pieno titolo scene teatrali.
Nell’epoca classica cui Sade ancora appartiene il desiderio può ancora definirsi come passione; e la passione classica, anche nelle sue manifestazioni più eccessive, resta legata a razionalità e volontà, al limite nella forma della sragione – déraison. Anche nei ritratti dei criminali sadiani, la passione si lega al calcolo. Mentre a partire dalla modernità, alla fine del Settecento, il desiderio assume una struttura nuova: rappresentazioni, passioni, affetti passano in posizione subordinata, per la dinamica morbosa degli istinti. Impulsi e istinti iniziano a emergere nella scrittura di Sade: “l’oscura violenza ripetuta del desiderio sopraggiunge a percuotere i limiti della rappresentazione”.
Eppure Sade – questa è la prima delle tesi che vorrei sostenere – continua paradossalmente a trattare questo desiderio e questa inclinazione come se fossero passioni, ordinandole al parossismo infinito, all’accumulazione morbosa delle rappresentazioni e delle immaginazioni di cui ho abbozzato le coordinate. È qui forse la vera soglia insuperabile della scrittura di Sade, il suo carattere grottesco e talvolta perfino incomprensibile. Nella conferenza a Buffalo del 1971, Foucault afferma esplicitamente: non c’è sessualità in Sade, se per sessualità si intende il sapere sul sesso che si forma nel XIX secolo; perché nei suoi racconti il desiderio non si presenta mai se non nella performatività dei quadri e delle scene, quindi sempre accanto al discorso, sulla sua superficie, e mai come suo oggetto proprio. Ecco perché non possiamo leggere Sade attraverso Freud, in qualche modo, secondo Foucault.
La mia ipotesi è che ciò che permette a Sade di fare questo tipo di operazione, lo strumento che gli consente di trattenersi testardamente in questa regione oscura ed incerta che separa l’età della rappresentazione classica dall’età delle scienze umane, questo strumento è la sofferenza. La sofferenza in altre parole – che in fondo è uno dei modi del godimento, della jouissance, non la sua negazione – non è semplicemente l’oggetto principale delle rappresentazioni disegnate da Sade, che scompongono, raddoppiano e ricompongono le scene teatrali immaginate e costruite ad arte dai suoi libertini; tutto al contrario, è prima ancora la rappresentazione in quanto tale a costituire l’oggetto privilegiato e l’interesse fondamentale della sofferenza. Ancor più radicalmente, diremo che la sofferenza è la vera condizione della possibilità che si dia e continui a darsi qualcosa come una rappresentazione.
La sofferenza avrebbe questa capacità per piani intrecciati a costituire ciò che Sade intende per scène e tableau: anzitutto “la verità delle sofferenze ‘confessate’ dalla vittima attraverso la sofferenza stessa”, perché la sofferenza è l’unica passione che non può essere né nascosta né dissimulata, cioè che non può fare a meno di rappresentarsi; è, in termini performativi, in grado di dire una verità fondamentale, rispondendo in modo adeguato al bisogno di rappresentazioni dell’immaginazione; ha la capacità di funzionare come una sorta di confessione, di publicatio sui, dove si tratta di rivelare una verità che il soggetto può nascondere o mascherare, ma che in ogni caso conosce e che dunque può rappresentare a se stesso e agli altri (dove scena teatrale e scena giudiziaria si confondono: la volontà di sapere del sadico è soprattutto volontà di dolore). In secondo luogo, “la verità della rappresentazione del carnefice […] si traduce in godimento”, e “gli ultimi guardiani della rappresentazione classica sono proprio i criminali che Sade mette in scena”. “La seconda ragione della supremazia rappresentativa della sofferenza è che in realtà solo da essa, secondo Sade, può sorgere il piacere” (primo livello), per un legame fisiologico in termini di shock, cui poi sovvengono abitudine, esercizio e immaginazione; ma la sofferenza (secondo livello) produce piacere anche nello spettatore, in virtù della natura della rappresentazione, con il sadico quale osservatore esterno (persino quando sperimenta in prima persona: però i grandi libertini delle sue storie sono immuni da sofferenza, non solo per la fondamentale apatia che li connota, ma perché per loro il rapporto tra bene e male è sbilanciato sul male che per loro è il solo bene). E la terza ragione del privilegio concesso alla sofferenza deriva dalle prime due, permettendo un’indefinita rappresentazione, un’indefinita soddisfazione del desiderio.
D’altra parte non si tratta di una sofferenza qualunque: le scene
devono essere al contrario studiate e preparate nei più piccoli, perfino tediosi dettagli. Il libertino è un medico, un fisiologo, un anatomista e un chirurgo, oltre che un attore e un capocomico. Ma allora perché la sofferenza piuttosto che qualcos’altro? Detto altrimenti: perché Justine ha da essere rigorosamente vittima di disgrazie e dolori per funzionare come catalizzatore delle passioni libertine? Perché Sade, a mio modo di vedere, ha compreso che le condizioni d’esistenza del soggetto morale proprio del mondo classico sono ormai gravemente compromesse dall’emersione di una diversa forma della soggettività.
In effetti, sembra dire Sade,
non c’è più altro se non la ferocia e la crudeltà che siano capaci di restare ancorate al meccanismo immaginario proprio della natura del pensiero, di non uscire mai dal reciproco e infinito rimando delle immagini. È questione di sicurezza, di veridicità, di regolarità. Di nuovo, nulla di male può capitare a chi non vuole altro che il male, perché il male, a prenderlo sul serio, non può essere mai disatteso: la volonté de souffrir del sadico potrà essere soltanto amplificata, mai ostacolata, dal momento che è sempre in grado di rappresentarsi qualunque cosa come un’occasione di malvagità o di supplizio, di assorbire tutto quanto nella sua rappresentazione di un male illimitato.
Se Justine non può fare la stessa cosa con il bene che tanto ardentemente desidera, è proprio perché ha ormai perduto gli strumenti necessari per rappresentarsi questa sua inclinazione come una passione, come un calcolo d’interessi, quindi come un’operazione dell’intelletto. Mentre la propensione sadica di Juliette riesce ancora a travestirsi come una forma di volontà, come un procedimento della ragione, la carità e la bontà non si prestano più ad una rappresentazione completa, esaustiva, autonoma. Perché in fondo anch’esse sono già il risultato di una serie di tendenze di per sé interamente involontarie, che si si sottraggono alle categorie dell’interesse-passione.
Per esempio, Justine parla di errore, stravaganza, follia, per descrivere il fatto che sia invaghita del feroce conte di Bressac che la tiene prigioniera – ha solo le parole della passione, mentre in gioco c’è altro:
Per essere felice […] Justine dovrebbe essere in grado di rassegnarsi al fatto che desiderio e interesse, impulso e volontà, non sono più sinonimi. E quindi ammettere, in ultima analisi, che per fare il bene cui tanto anela sia è talvolta costretti non solo a soffrire ma perfino a fare il male, o meglio, ciò che ci rappresentiamo come il male. Kant, da parte sua, non avrà dubbi a questo proposito. Ma Justine non può ancora ammettere una cosa simile. Né possono farlo i suoi persecutori del resto, per i quali la logica coerenza della rappresentazione rimane altrettanto fondamentale.
Al contrario,
Juliette è felice […] proprio perché riesce a vivere in una dimensione in cui la dialettica tradizionale tra virtù e vizio è ancora resa paradossalmente possibile dalla rappresentazione di questo male supremo e assoluto, che viene a sostituire a colpo sicuro il summum bonum – divenuto irrappresentabile – dell’etica classica.
Se tutto ciò è vero, come si sarà ormai compreso, mi sembra che si possa dire che, in mancanza di questa rappresentazione e di questa perfetta evidenza di cui Juliette è ancora sovrana, a Justine non resti più altra virtù possibile che quella kantiana.
Come “dice Lacan, in Sade ‘seguire il proprio desiderio’ significa esattamente ‘fare il proprio dovere’” (e torniamo in qualche modo a Crowley).
Ecco perché nella sofferenza di cui il soggetto sadico gode – di un godimento che come si è visto vive ancora tutto nella rappresentazione – il suo più grande interesse coincide in realtà con il massimo disinteresse possibile. Il carnefice sadico è solo lo strumento, l’enunciatore appunto, del “godimento dell’Altro”, come nel desiderio di mortificazione di Teresa d’Avila; o come nella “santa indifferenza” dei quietisti.
Se potesse aderire interamente al regime epistemico classico, Justine sarebbe forse proprio una mistica. Mentre Juliette sarebbe una strega o una maniaca, un’alienata rinchiusa alla Salpetrière, prigioniera del circolo vizioso delle proprie rappresentazioni. Per l’età classica, infatti, l’alienazione non è che l’effetto di un gioco morboso, malinconico e ripetitivo del pensiero, cioè delle passioni e dell’immaginazione. Ma ora le cose iniziano in qualche modo a capovolgersi. Quello di Juliette inizia ad apparire paradossalmente come un rapporto sano – ancorché eccessivo, debordante – con il desiderio, proprio perché pretende di non aver bisogno, per poter godere, che di conoscerne l’infinita concatenazione dei moventi razionali: è questa la sua histoire, la vicenda di un desiderio che non è più una passione, e che tuttavia può essere ancora trattato come tale a condizione di esternalizzare sempre il godimento, per così dire, cioè a condizione che a godere sia sempre quell’Altro che il sadico sa di essere. Per questo, di nuovo, la sofferenza si rivela essere il cardine delle rappresentazioni sovrane di Juliette, la chiave di volta che ne garantisce la tenuta: è la mortificazione della carne dei grandi mistici, che Justine, suo malgrado, non è più in grado di comprendere. Dal canto suo, infatti, è proprio Justine a ritrovarsi esposta ad una nuova, incipiente economia della follia (e più precisamente, si potrebbe dire, all’isteria), dominata com’è da un’inclinazione segreta la cui verità non cessa di ritrarsi sul fondo opaco, mai perfettamente confessabile né conoscibile – perché non più aderente al registro immaginario, potremmo dire – della sua anima. Il suo stesso desiderio le è diventato non solo estraneo ma addirittura insopportabile. Per questo il suo amore per il carnefice le è diventato oscuro: è una misteriosa devianza, un desiderio che sfugge alla presa dell’immagine mentale e del tableau, e non già un semplice errore della volontà, come pure si ostina a credere.
Le due sorelle si collocano insomma al bivio di un’alternativa storica: la mistica e l’isterica separano ora i propri itinerari. E Justine prende una china dove non si tratta più di virtù o vizio, ma di sano o malato.
Però il tema della rappresentazione conduce con forza anche sul piano politico. Nel mondo classico, secondo Foucault, soggetto e oggetto della rappresentazione non si identificano; ciò che vale anche per la rappresentanza politica. Il popolo, in quanto soggetto chiamato a trasferire il proprio potere all’attore che lo rappresenta, esiste solo come effetto della rappresentazione stessa, che ad un tempo lo produce e – nota Hobbes – lo dissolve: i membri del popolo possono agire sulla scena politica solo indirettamente, proprio attraverso la fictio che offre forma a una volontà. Se Sieyès teorizza che “il popolo non può parlare e non può agire se non attraverso i suoi rappresentanti”, Joseph de Maistre saetta polemicamente contro Rousseau: “Il popolo è un sovrano che non può esercitare la sovranità”. Tale spoliticizzazione del nesso popolo-sovrano deve apparire a Sade superata e rischiosa. Ed ecco perché nel pamphlet di cui sopra
ne decreta in qualche modo la fine. Questo spiega a mio modo di vedere perché inviti la nazione rivoluzionaria a sbarazzarsi definitivamente dei modelli di governo propri di quella stessa monarchia che ha appena sradicato: anzitutto del suo impianto giuridico. Una volta tagliata la testa del sovrano, la testa del Leviatano, detto altrimenti, “il posto del re” e il suo sguardo restano, per la prima volta, esplicitamente vacanti. La Rivoluzione aprirebbe allora un tempo nuovo – che è insieme il tempo della verità e della crisi del potere dei moderni – che richiede nuove forme di sapere e, soprattutto, nuove tecnologie di governo della società. È il caso, ad esempio, del sistema penale e della gestione dell’illegalismo, nelle cui trasformazioni il marchese vede profilarsi un immenso pericolo, soprattutto nella misura in cui non gli sembrano più in grado di farsi carico di un inedito e decisamente instabile rapporto tra poveri e proprietari. Quando propone di legalizzare il furto e di abolire la proprietà privata, quindi, non si tratta a mio avviso di una semplice provocazione ma di una preoccupazione concreta: Quali sono i fondamenti del patto sociale? Non consiste forse nel cedere una parte della nostra libertà e delle nostre proprietà per garantire e mantenere quanto si conserva dell’una e delle altre? Tutte le leggi poggiano su queste basi che sono all’origine delle punizioni inflitte a chi abusa della propria libertà […] Ma, ancora una volta, a quale titolo chi non ha nulla si piegherà ad un patto che protegge solo chi ha tutto? Se fate un atto di equità conservando, attraverso il vostro giuramento, la proprietà del ricco, non fate un’ingiustizia esigendo questo stesso giuramento di “conservatore” da chi non ha nulla? Quale interesse al vostro giuramento può avere costui? […] Non v’è certamente nulla di più ingiusto: un giuramento deve avere gli stessi effetti su tutti gli individui che lo pronunciano; è impossibile che possa legare chi non ha alcun interesse a mantenerlo, perché in questo caso non sarebbe più il patto di un popolo libero: sarebbe l’arma del forte contro il debole e quest’ultimo dovrebbe ribellarvisi senza tregua.
Del resto Madame Dubois aveva invitato Justine a considerare il furto “semplicemente come un modo per riequilibrare le sorti degli uomini, per fare dell’eguaglianza e della libertà una pratica prima ancora che una condizione formale”. Come anzi si è osservato, i personaggi di Sade vengono in generale dalle condizioni opposte e più estreme di nobiltà (i mostri nel castello delle 120 giornate) o miseria (del popolo più bruto e violento), condizioni che la finzione contrattualistica del Terzo Stato non riesce più a rappresentare, e il cui disagio alle soglie della rivoluzione è ben documentato. L’antico modo di governare la miseria e gli appetiti istintuali è ormai inadeguato, e tutto questo sfocerà nella letteratura poliziesca dell’Ottocento. Mentre per Sade la Francia postrivoluzionaria avrebbe bisogno di un sistema completamente diverso per intercettare esperienze sociali aliene al sistema della rappresentazione, mutuata dal regime di un monarca ormai deposto.
Occorre ancora uno sforzo, allora, non tanto per portare la Rivoluzione a pieno compimento, non tanto, cioè, per rendere la Repubblica davvero repubblicana o la democrazia davvero democratica. Non è ad un semplice deficit di rappresentanza, mi sembra, che Sade ci invita a prestare attenzione. Detto altrimenti, per lui non si tratta di rappresentare meglio, di rappresentare di più. Si tratta invece di far esplodere dall’interno le contraddizioni che abitano la rappresentazione classica, di prenderne sul serio le aporie. Il rischio altrimenti – e in questo il marchese dà prova di grande capacità prognostica – è che dall’età delle rivoluzioni diventi definitivamente impossibile uscire. Alla Francia repubblicana, in definitiva, Sade chiede una risposta efficace e responsabile alla minaccia della guerra civile permanente che ne percorre l’intera trama sociale.
 Il terzo capitolo-contributo, a firma del curatore Storace, “Repubblicanesimo e a-teologia politica in D.A.F. de Sade. Una lettura di Francesi ancora uno sforzo se volete essere repubblicani attraverso F. Nietzsche e C. Schmitt” riprende ancora il citato pamphlet al filtro di interpreti eccellenti: si inizia con una “Nota metodologica: sulla nozione di ‘teologia politica’ a partire da Carl Schmitt” – autore che vede nel deismo la condizione della nascita dello Stato moderno – sulla base dell’interessante considerazione “che de Sade teorizza la possibilità di una politica squisitamente laica e atea, che nasca esclusivamente dall’affrancamento dal monoteismo (il quale rimanderebbe al medesimo immaginario della monarchia)”. Si ricostruiscono “alcune tappe che hanno reso possibile quel ‘Repubblicanesimo’ che de Sade vedrà quale imprescindibile risultato della sua epoca”: in particolare la genesi della laicizzazione dello Stato, la genesi ed eclissi della sovranità nella modernità, e il nodo del rapporto (dalla morale alla politica) tra virtù e vizi che conduce a
Il terzo capitolo-contributo, a firma del curatore Storace, “Repubblicanesimo e a-teologia politica in D.A.F. de Sade. Una lettura di Francesi ancora uno sforzo se volete essere repubblicani attraverso F. Nietzsche e C. Schmitt” riprende ancora il citato pamphlet al filtro di interpreti eccellenti: si inizia con una “Nota metodologica: sulla nozione di ‘teologia politica’ a partire da Carl Schmitt” – autore che vede nel deismo la condizione della nascita dello Stato moderno – sulla base dell’interessante considerazione “che de Sade teorizza la possibilità di una politica squisitamente laica e atea, che nasca esclusivamente dall’affrancamento dal monoteismo (il quale rimanderebbe al medesimo immaginario della monarchia)”. Si ricostruiscono “alcune tappe che hanno reso possibile quel ‘Repubblicanesimo’ che de Sade vedrà quale imprescindibile risultato della sua epoca”: in particolare la genesi della laicizzazione dello Stato, la genesi ed eclissi della sovranità nella modernità, e il nodo del rapporto (dalla morale alla politica) tra virtù e vizi che conduce a
due filoni di pensiero contrapposti: uno più vicino all’interpretazione tradizionale e al razionalismo socratico che vede nell’essere umano una naturale propensione alla virtù, l’altro, più carsico, che vede nell’uomo il germe del male e relaziona irreparabilmente l’esercizio della virtù con la repressione dei più intimi istinti di esso. Il libertinismo trarrà proprio da questa corrente di pensiero le basi sulle quali si svilupperà in differenti modalità espressive e sarà declinato secondo differenti interpretazioni: avremo dunque un libertinismo più religioso, che tenterà di scardinare la precedente tradizione religiosa producendo lo scetticismo e l’ateismo; un libertinismo più filosofico, vicino allo scetticismo; e un libertinismo decisamente più audace, che attaccherà i tre monoteismi.
Di qui il tema del monoteismo, per Sade, come ostacolo al Repubblicanesimo: “Abbattuti i tiranni, è necessario per il popolo abbattere ora religione e costumi: ecco lo sforzo, incredibilmente razionale, ancora da compiere perché la libertà sia veramente piena”. Ma ecco la chiave che dovrebbe essere costantemente considerata leggendo gli scritti di Sade, per non scambiarlo per un protonazista o un LaVey qualsiasi:
Certamente il pensiero di de Sade, ben lungi dal configurarsi come un solido sistema dottrinale basato su assunti teorici, deve essere contestualizzato in prima analisi all’interno della vicenda biografica di Sade stesso, e in secondo luogo inquadrato all’interno del tempo in cui Sade vive.
Si può discutere sulle canonizzazioni di Sade come liberatore della sessualità (Onfray) e portatore di libertà tutta nuova (Breton, Bataille), ma al netto degli scandali è impossibile non riconoscergli un ruolo importante per una riflessione laica sulla sessualità, e quasi profetico di pratiche e temi dei tempi in cui viviamo. Storace analizza a questo punto gli influssi di Sade nel rapporto tra a-teologia e politica in Nietzsche, in particolare sui rispettivi approcci all’ateismo e sull’influsso di Sade nel pensiero teologico-politico di Nietzsche. Nella polifonia, insomma, questo breve volume sembra di grosso interesse per impostare una serie di domande – e tentativi di risposte – sull’impianto teorico del Divin Marchese.
Il secondo volume ci riporta al tema della rappresentazione, corteggiato da Sade anche con i costosissimi drammi teatrali organizzati nel suo castello, e poi con quelli – oggetto di mito anche letterario, si pensi solo al Marat/Sade di Peter Weiss, 1964 – tirati su con i pazienti del manicomio dove sarà rinchiuso. Il fronte del cinema finisce con l’esserne uno sviluppo: per cui merita attenzione questa bellissima monografia per il bicentenario a firma di Alberto Brodesco, Sguardo, corpo, violenza. Sade e il cinema, per Mimesis, 2014. Un’opera articolata in un’introduzione, “Sade. L’occhio tagliato” (sulla triade sguardo-corpo-violenza a partire da quel Luis Buñuel che evoca per la prima volta il Marchese in un film, L’âge d’or, 1930, e nella presa di coscienza che “Sade mette a nudo ‘l’autosoddisfazione compiacente dissimulata sotto la compassione simpatetica dello spettatore della sofferenza”, flirtando con i limiti della rappresentazione) e tre parti. Questo l’impianto:
La filmografia su cui ci concentriamo parte da una definizione circoscritta di cinema sadiano, inteso come una produzione direttamente riconducibile alla presenza di Sade come autore o come personaggio e sintetizzabile nelle seguenti categorie: adattamenti delle opere letterarie di Sade; riferimenti alle opere di Sade; film biografici dedicati a Sade; e apparizioni di Sade come personaggio diegetico. La figura di Sade è un’“elaborazione mitica”, la combinazione del personaggio storico con la sua vicenda biografica e del romanziere con le sue opere: “Sade non è il nome di un individuo ma di un ‘autore’, o meglio di un ‘narratore’ mitico, depositario attraverso il tempo di tutti i sensi che riceve il suo discorso”.
E l’esame di Brodesco verterà particolarmente su opere di quattro registi, appunto Buñuel, poi Peter Brook, Jesús Franco e Pier Paolo Pasolini.
Nella prima, “Il corpo violato, Sade, il cinema sadiano”, si imposta il problema. Si parte così – capitolo primo, “Il cinema e il corpo violato” – dal corpo violato come oggetto di attrazione (dello spettatore; del cinema in sé), si passa al tema della violenza nell’immagine e dell’immagine, alla tradizione interpretativa su una concupiscenza sottesa alla “signoria dello sguardo” fino al morboso e al pornografico, alla distanza tra spettacolo di realtà e spettacolo di finzione; si affrontano i nodi di riflessività (la “capacità della mente di essere allo stesso tempo oggetto e soggetto di se stessa all’interno del processo cognitivo”) e autorizzazione attraverso voyeurismo, sadismo, masochismo, poi le “posizioni spettatoriali” (spettatore masochista, sadico, ludico, curioso, meditativo).
 Il secondo capitolo, “Tableaux. Configurazioni dello sguardo nell’opera di Sade”, affronta i “dispositivi della visione che emergono nell’opera di D. A. F. Sade, all’interno della quale il corpo violato si afferma come elemento di continuo richiamo per lo sguardo del libertino”. Cioè le figure dell’immaginazione (“Sono le storie a eccitare la fantasia, a produrre nella mente dei libertini lo stimolo che potranno poi soddisfare nel contatto con le vittime”, anche se il “flusso libidinale oltrepassa in ogni caso le capacità del dire” e la scrittura deve farsi quadro); le strategie sadiane (a coinvolgere non solo pittura ma drammaturgia, e una scrittura che “aspira ad adeguare nel suo complesso l’immaginazione del lettore a quella dell’autore”, per “convertirlo alla filosofia che sta alla base del […] pensiero” di Sade; il “tempo del discorso non […] sottratto al tempo del godimento, ma [che] ne fa parte” e le quattro fasi dei riti libertini, cioè programmazione, esecuzione, variazioni, saturazione della scena e del corpo); la vista e gli altri sensi, “iper-sfruttati e sovraesposti, continuamente chiamati in causa dal rilancio e dal superamento delle percezioni richiesto dalla libidine libertina” (dalla vista capace di “stupri oculari”, per esempio, ai fondamentali olfatto e gusto: “In modo simile al sesso, nell’universo sadiano nulla è in-edibile”).
Il secondo capitolo, “Tableaux. Configurazioni dello sguardo nell’opera di Sade”, affronta i “dispositivi della visione che emergono nell’opera di D. A. F. Sade, all’interno della quale il corpo violato si afferma come elemento di continuo richiamo per lo sguardo del libertino”. Cioè le figure dell’immaginazione (“Sono le storie a eccitare la fantasia, a produrre nella mente dei libertini lo stimolo che potranno poi soddisfare nel contatto con le vittime”, anche se il “flusso libidinale oltrepassa in ogni caso le capacità del dire” e la scrittura deve farsi quadro); le strategie sadiane (a coinvolgere non solo pittura ma drammaturgia, e una scrittura che “aspira ad adeguare nel suo complesso l’immaginazione del lettore a quella dell’autore”, per “convertirlo alla filosofia che sta alla base del […] pensiero” di Sade; il “tempo del discorso non […] sottratto al tempo del godimento, ma [che] ne fa parte” e le quattro fasi dei riti libertini, cioè programmazione, esecuzione, variazioni, saturazione della scena e del corpo); la vista e gli altri sensi, “iper-sfruttati e sovraesposti, continuamente chiamati in causa dal rilancio e dal superamento delle percezioni richiesto dalla libidine libertina” (dalla vista capace di “stupri oculari”, per esempio, ai fondamentali olfatto e gusto: “In modo simile al sesso, nell’universo sadiano nulla è in-edibile”).
Il terzo capitolo tratta “L’arte che (non) ha movimento. Il cinema, Sade, i limiti della rappresentazione”, a fronte di contenuti tanto estremi:
Il nome di Sade è di fatto destinato a creare aspettative che un film non può che deludere. “Sade” è una promessa impossibile, che non può essere rispettata. Alle urla del titolo corrisponde il silenzio del film; al nome di Sade, l’inimmaginabile, si associa uno schermo nero.
Per inciso, il primo film in cui Sade doveva apparire – secondo la sceneggiatura, ma la scena relativa “non è mai stata girata o è andata perduta” – è Napoléon (1927) di Abel Gance.
Per Foucault, “Non c’è niente di più allergico al cinema delle opere di Sade”. E Barthes, criticando Salò o le 120 giornate di Sodoma: “Sade non è affatto figurabile. Esattamente come non ci sono ritratti di Sade (se non fittizi), così nessuna immagine è possibile dell’universo sadiano, il quale, per una decisione imperiosa dello scrittore Sade, è affidato tutt’intero al solo potere della scrittura”. Jesús Franco, autore di parecchi film ispirati a Sade: “Continuo a pensare che gli adattamenti di Sade al cinema sono sempre molto brutti, compresi i miei!”. Ma sono solo poche voci di un’interessante carrellata di pareri critici che demoliscono la possibilità in radice di portare Sade al cinema. E invece.
(continua)
