di Sandro Moiso
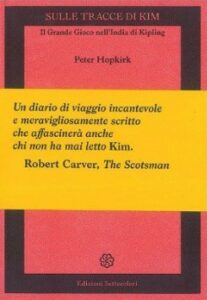 Peter Hopkirk, Sulle tracce di Kim. Il Grande Gioco nell’India di Kipling, Edizioni Settecolori, Milano 2021, pp. 282, 26,00 euro
Peter Hopkirk, Sulle tracce di Kim. Il Grande Gioco nell’India di Kipling, Edizioni Settecolori, Milano 2021, pp. 282, 26,00 euro
Ho letto Kim diverse volte – non so quante – e l’ho portato con me nei miei viaggi.
È l’unico libro di prosa che si può aprire a caso, a qualsiasi pagina, e ricominciare a leggere con lo stesso piacere che se fosse poesia. (Wilfred Thesiger)
Un amico torinese, scrittore, saggista e recensore inveterato, ha definito Kim come il più bel romanzo di avventura che sia mai stato scritto. Certamente l’opera di Rudyard Kipling lo è, ma è anche molto di più: un magnifico romanzo di formazione, un grande affresco storico e antropologico sull’India coloniale e i giochi delle grandi potenze imperialistiche che si svolsero ai suoi confini e al suo interno. Intorno ai personaggi principali, infatti, si sovrappongono, talvolta nell’ombra e talaltra alla luce del sole, i maneggi di spie e avventurieri che incrociano, non sempre solo virtualmente, le loro armi nel tentativo di difendere o indebolire il dominio britannico sul subcontinente indiano e le sue propaggini centro asiatiche.
Ora, prima che sia costituito qualche nuovo ministero da Minculpop perbenista e politically correct destinato a proibire la circolazione e la lettura di un libro scritto da un autore “colonialista”, varrebbe la pena di scoprire quanti di quei personaggi (il curatore del museo di Lahore, il vecchi lama tibetano, i rappresentanti dei servizi segreti inglesi, le spie francesi al soldo dello zar, commercianti e ladri di cavalli, anziane donne indiane autoritarie ma benevole e molti altri ancora) avessero radici e riferimenti in personaggi reali, oltre che in fatti e vicende appartenenti alla dinamica del Grande Gioco ovvero all’infinito sotterraneo conflitto che vide coinvolte, tra l’inizio del XIX secolo e la prima metà del XX secolo Russia e Gran Bretagna per il controllo del grande nulla costituito dall’Asia centrale e dalle aree confinanti con l’India, il Pakistan e il Tibet attuali.
Vicende interessanti soprattutto per chi, ancora oggi e con attori parzialmente cambiati (USA e Cina oltre che la Russia di Putin), si interessi alle vicende centro-asiatiche, e afghane in particolare. Che, al di là del miserrimo e ipocrita discorso liberal sui diritti umani e il politically correct, continuano a sgranare il loro rosario di conflitti, voltafaccia, tradimenti, morti, violenze, contraddizioni, false informazioni, contrasti religiosi e ideologici e, perché no, speranze per le irriducibili popolazioni locali.
 Peter Hopkirk, che prima di affermarsi come saggista storico con i volumi che dedicò al Grande Gioco e ai suoi preamboli ed aspetti avventurosi, di cui Sulle tracce di Kim costituì il sesto e ultimo1, fu ufficiale dell’esercito britannico, viaggiatore e reporter per la «Independent Television News», corrispondente da New York per il «Sunday Express» ed in seguito giornalista, per quasi vent’anni, del «Times», cinque come capo reporter e poi come specialista del Medio ed Estremo Oriente (aree che aveva conosciuto personalmente girovagando a lungo tra Russia, Asia Centrale, Caucaso, Cina, India e Pakistan, Iran e Turchia orientale.
Peter Hopkirk, che prima di affermarsi come saggista storico con i volumi che dedicò al Grande Gioco e ai suoi preamboli ed aspetti avventurosi, di cui Sulle tracce di Kim costituì il sesto e ultimo1, fu ufficiale dell’esercito britannico, viaggiatore e reporter per la «Independent Television News», corrispondente da New York per il «Sunday Express» ed in seguito giornalista, per quasi vent’anni, del «Times», cinque come capo reporter e poi come specialista del Medio ed Estremo Oriente (aree che aveva conosciuto personalmente girovagando a lungo tra Russia, Asia Centrale, Caucaso, Cina, India e Pakistan, Iran e Turchia orientale.
Sostenne sempre che ad ispirare questa sua passione fosse stata proprio la lettura del romanzo di Kipling, cui volle dedicare la sua ultima fatica saggistica. Romanzo che, a sua volta, era strettamente ispirato alle vicende famigliari e d’infanzia dello stesso Kipling, visto, ad esempio, come sia facilmente riconoscibile la figura del padre dell’autore nel personaggio del curatore del Museo di Lahore (la Casa delle Meraviglie) che compare nelle prime pagine del romanzo.
Uomo colto, conoscitore delle culture locali, affascinato dall’arte e dal pensiero buddista, in qualche modo sembra rivelare il cuore dell’attenzione di Kipling per il subcontinente e le sue genti, anche se lo stesso autore fu forse l’inventore del termine Grande Gioco per definire lo scontro tra potenze per il suo controllo e possesso e, ancor peggio, il teorizzatore del white man burden (il fardello dell’uomo bianco) con cui l’Occidente, compresa la sua componente socialdemocratica e socialista, spesso guardò a quello e ad altri nell’intento di giustificare come missione (non si parla forse ancora oggi di missioni di pace e di soccorso oppure di polizia quando si tratta di operare in aree poste al di fuori dei confini ufficiai dell’Occidente?) l’opera predatoria messa in atto di popoli e continenti non bianchi.
Eppure, eppure…
Basterebbe scorrere le pagine di Kim, con un minimo di attenzione, per cogliere il realismo e il rispetto con cui vengono descritti non solo i personaggi principali, ma anche quelli secondari e minori che si incontrano lungo l’interminabile viaggio sulla Grand Trunk Road2 che il giovane protagonista intraprende come servitore, astuto e fedele, di un vecchio lama tibetano intento a visitare, prima di morire, i Quattro Luoghi Sacri e a voler scoprire il fiume da cui tutto ha avuto origine.
Pagine e vicende che, come afferma Hopkirk nel Prologo, hanno colpito non soltanto lui ma tantissimi altri lettori di formazione e convinzioni molte lontane tra loro.
L’indirizzo della mia vita lo devo molto alla lettura da giovane del capolavoro di Kipling. Perché è stato proprio Kim, non riesco neppure a ricordare quanti anni fa, a introdurmi per la prima volta nel mondo intrigante del Grande Gioco. Per l’impressionabile e fantasticante ragazzo di tredici anni qual ero – la stessa età di Kim – le attività misteriose, per non dire torbide, di uomini come il colonnello Creighton, Mahbub Ali e Lurgan Sahib erano davvero roba forte. Dopotutto, si era al tempo in cui la Gran Bretagna governava ancora l’India, e molte altre parti del mondo, per cui quasi tutto pareva possibile.
Ero così stregato da questa mia sbirciata dentro i maneggi del servizio segreto indiano che mi portavo sempre dietro, dovunque andassi, una copia di Kim, anche se tante cose non le avevo capite. Perché Kim, nonostante molti non lo sappiano, non è un libro per ragazzi. E in effetti, all’età di tredici anni, ero ben lontano dal capire di cosa veramente si trattasse dicendo Grande Gioco, «che mai cessa di giorno e di notte». Ciò nonostante, quello che appariva era incredibilmente eccitante, e io anelavo di saperne di più. La ricerca sarebbe durata per tutta la vita, e dura ancora.
Scoprii poi che non ero il solo ad essermi appassionato a Kim. Wilfred Thesiger ci dice che raramente si è messo in viaggio senza una copia di questo libro nella bisaccia, mentre T.S. Eliot lo leggeva a voce alta a sua moglie certe sere, giusto per il piacere di sentire il suo linguaggio. Mark Twain disse che lo leggeva da capo ogni anno […] E io una volta ho sentito dire da Tarik Ali,
quell’ex-fustigatore dell’establishment britannico, che Kim era il libro che amava di più quando stava a Lahore, dove anche lui era cresciuto, come Kim3.
Ma chi volesse vedere nell’opera di Kipling, e nella lettura attenta che ne fa Hopkirk, soltanto un segno del paternalismo occidentale nei confronti dei sottoposti o degli ex-tali, dovrebbe fare i conti anche con l’attenzione che l’autore di Kim pone alla presentazione delle culture e delle arti locali. Ad esempio quando l’Amico del Mondo (uno dei tanti soprannomi assegnati al giovane protagonista) entra con il lama nel museo di Lahore: «Nel salone di ingresso erano esposte le figure più grandi della statuaria greco-buddhista; datarle è impresa da eruditi – opera di artefici anonimi dalle mani impegnate a ritrovare, non senza maestria, il tocco greco misteriosamente trasmesso»4.
Tema che sarai poi ripreso, in un’altra delle sue ricerche, dallo stesso Hopkirk.
La vera base di partenza per la diffusione del buddhismo in Cina, ci spiega infatti l’autore inglese
fu in realtà il regno buddhista di Gandhara situato nella valle di Peshawar, che appartiene oggi al Pakistan nordoccidentale. In questi luoghi si era già realizzata un’altra fusione artistica, tra l’arte buddhista indiana importata dai dominatori Kushan (discendenti degli Yueh-chih) nel I secolo d.C. e l’arte greca, introdotta in quella regione quattro secoli prima da Alessandro il Grande.
Il più rivoluzionario prodotto di questa scuola greco-buddhista, o gandharana, fu la raffigurazione del Buddha in forme umane. Era la prima volta che degli artisti si permettevano di rappresentarlo in questo modo […] I primi viaggiatori occidentali che nell’Ottocento raggiunsero la regione di Gandhara dall’India restarono stupefatti alla vista di quest’arte così differente dalle forme dell’arte religiosa indiana alla quale erano abituati. Nella precipitazione con cui si cercò di ottenere campioni di quell’arte per musei e collezioni, furono inflitti a siti e templi irreparabili danni5.
Metafora di tutti i successivi danni causati dal colonialismo occidentale in India e nelle regioni limitrofe (e già abbondantemente segnalati da Marx ed Engels nei loro scritti sull’India e la Cina6), le descrizioni di Hopkirk (e di Kipling) ci parlano dei tempi lunghi della Storia, degli incontri tra culture e civiltà diverse, segnalandoci, se abbiamo orecchie ed occhi per comprenderlo, che tutto quanto sta avvenendo oggi nell’area centro-asiatica ha una lunga storia pregressa con cui occorrerebbe fare i conti e conoscere nel dettaglio. Magari anche prima di lanciarsi in campagne militari destinate alla sconfitta fin dall’inizio. Proprio come quella occidentale in Afghanistan.
Ora, ed è questo il punto principale di questa riflessione, il vento di revisionismo che percorre il pensiero liberal e una certa sinistra immediatista, che in nome di un loro ipotetico superamento “volontario” intende rimuovere ogni ricordo del passato o dell’attuale regime di differenziazione tra le classi, i generi e gruppi etnici e culturali, rischia di non far altro che nascondere e rimuovere le infinite contraddizioni, passate e attuali, su cui si fonda ogni regime di oppressione di classe, razza e genere.
 Il rischio è costituito, infatti, dal fatto che, passato il momento della rivolta generalizzata e “illegale” durante la quale, giustamente, statue e immagini di dittatori, schiavisti e generali vengono bruciate o abbattute, si pensi di cancellare le contraddizioni reali e persistenti con un volontaristico e “legalitario” colpo di spugna ed un mea culpa generalizzato e infingardo. Rintracciabili, soltanto per fare due esempi, tanto in dichiarazioni come quella rilasciata in un tweet dall’attrice americana Rosanna Arquette («Sono dispiaciuta di essere nata bianca e privilegiata, Mi disgusta. Mi vergogno molto»), quanto nell’abito indossato dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez in occasione di un (ricco) meeting di gala per la raccolta fondi (Met Gala), considerato l’evento mondano più importante di New York, una serata di “beneficenza” da 30mila dollari a biglietto organizzata dalla direttrice di «Vogue» Anna Wintour. Abito di alta sartoria sul quale era scritto provocatoriamente (?), con grandi lettere rosse, Tax the rich (tassate i ricchi).
Il rischio è costituito, infatti, dal fatto che, passato il momento della rivolta generalizzata e “illegale” durante la quale, giustamente, statue e immagini di dittatori, schiavisti e generali vengono bruciate o abbattute, si pensi di cancellare le contraddizioni reali e persistenti con un volontaristico e “legalitario” colpo di spugna ed un mea culpa generalizzato e infingardo. Rintracciabili, soltanto per fare due esempi, tanto in dichiarazioni come quella rilasciata in un tweet dall’attrice americana Rosanna Arquette («Sono dispiaciuta di essere nata bianca e privilegiata, Mi disgusta. Mi vergogno molto»), quanto nell’abito indossato dalla deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez in occasione di un (ricco) meeting di gala per la raccolta fondi (Met Gala), considerato l’evento mondano più importante di New York, una serata di “beneficenza” da 30mila dollari a biglietto organizzata dalla direttrice di «Vogue» Anna Wintour. Abito di alta sartoria sul quale era scritto provocatoriamente (?), con grandi lettere rosse, Tax the rich (tassate i ricchi).
La rivolta e la protesta vengono così sostituite dagli atti di contrizione, cui già spesso ci hanno abituato i social7, oppure dalla loro formale spettacolarizzazione mediatica attraverso logo e frasi ad effetto.
Una furbesca operazione di disarmo delle lotte che attraverso l’eliminazione di film, opere letterarie ed altro8 non fa altro che prolungare l’esistenza di violenza, oppressione e ingiustizia semplicemente nascondendo, nel più borghese ed opportunista dei modi, la polvere sotto il tappeto del salotto buono.
Come ha affermato Barbara Applebaum, che teorizza la Social Justice applicata alla pedagogia: «Spesso gli studenti bianchi ritengono che la loro responsabilità cominci e finisca con la presa di coscienza del privilegio. Ammettendo o confessando il privilegio, tuttavia, finiscono per non fare i conti con la loro complicità nel razzismo sistemico». La finta intolleranza, che non passa attraverso la lotta aperta e dichiarata, finisce soltanto col creare nuova tolleranza nei confronti delle ingiustizie, ben più profonde e radicate che nelle pagine di un romanzo o tra le immagini di un film (dove quasi sempre sono spesso più evidenti proprio perché date per scontate).
Noi, che crediamo che l’attuale modo di produzione abbia bisogno di ben altre iniziative per poter essere negato e rovesciato, continueremo a leggere con attenzione le opere che di tali violenze ed ingiustizie ci parlano, anche e forse soprattutto indirettamente, a distanza di decenni o di secoli da quelle stesse. Per questo vale ancora la pena di leggere la dettagliata ricostruzione storica di Hopkirk e lo stesso romanzo da cui ha tratto ispirazione, prima che nelle biblioteche, solo per fare un’ipotesi banale, siano soltanto più rintracciabili le opere di Elena Ferrante (guarda caso, quest’ultima, autrice prediletta da Hillary Clinton).
Era seduto, in barba alle ordinanze municipali, a cavallo del cannone Zam-Zammah che su un basamento di mattoni fronteggiava il vecchio Ajaib-gher, la Casa delle Meraviglie, come gli indigeni chiamano il museo di Lahore. Chi detiene Zam-Zammah, il «drago sputafuoco», tiene il Punjab, e quel gran pezzo di bronzo verde è sempre stato la preda più ambita del conquistatore.
A parziale giustificazione di Kim – che aveva cacciato il figlio di Lala Dinanath giù dall’affusto – c’era il fatto che gli inglesi tenevano il Punjab, e Kim era inglese. Pur essendo un tizzo nero almeno quanto un indigeno; pur parlando di preferenza il vernacolo, e la lingua madre con un’incerta, zoppicante cantilena; pur facendo comunella su un piano di perfetta parità con i ragazzini del bazar, Kim era bianco…un bianco povero tra i più poveri. La mezzosangue che badava a lui (fumava oppio e faceva mostra di tenere una bottega di mobili usati vicino alla piazza dove stazionavano le vetture da nolo a buon mercato) raccontava a i missionari di essere la sorella della madre di Kim; in realtà la madre del ragazzo aveva fatto la bambinaia presso la famiglia di un colonnello e aveva sposato Kimball O’Hara, giovane sergente portabandiera dei Maverick, un reggimento irlandese. In seguito O’Hara aveva trovato impiego alla Sind, Punjab and Delhi Railway, e il reggimento era tornato in patria senza di lui. La moglie era morta di colera a Ferozepore e O’Hara si era messo a bere e vagabondare su e giù lungo la linea ferroviaria assieme al figlio, un bimbo di tre anni con due occhi vispi. Istituti e cappellani, preoccupati per il piccolo, avevano cercato di sottrarglielo, ma O’Hara aveva preso il largo fino a quando, incontrata la donna che faceva uso di oppio, ci aveva preso gusto anche lui ed era morto come muoiono i bianchi poveri in India 9.
Questo l’incipit del grande romanzo e della contraddizione che il giovane protagonista vivrà sempre nella sua appartenenza a due mondi, entrambi poveri e complessi.
