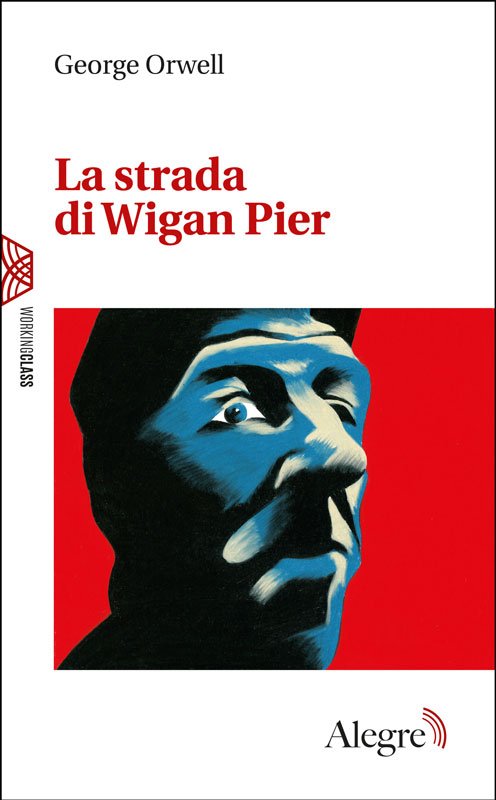
[Esce oggi in libreria, nella collana Working Class curata da Alberto Prunetti per le Edizioni Alegre, la nuova edizione italiana de La strada di Wigan Pier (€16), la celebre indagine sociale e conseguente riflessione politica che George Orwell realizzò e scrisse nel 1936, nei distretti minerari del Nord dell’Inghilterra.
Nonostante i quasi novant’anni che ci separano dall’epoca in cui quel testo fu scritto, le riflessioni di Orwell contengono spunti tutt’ora interessanti. Non soltanto perché la precarietà di vita e la condizione di certo proletariato persistono, e non soltanto fuori dal nostro continente; ma anche perché le riflessioni di Orwell si illuminano oggi di una luce nuova, se è vero, come scriveva il grande storico marxista Christopher Hill, che «la storia deve essere riscritta da ogni nuova generazione, perché, se il passato non cambia, è il presente che muta; ogni generazione rivolge al passato domande diverse, e nel rivivere aspetti diversi delle esperienze dei suoi predecessori, scopre di avere con essi nuovi punti in comune». Di seguito riportiamo la prefazione scritta da Wu Ming 4.]
Prefazione
«La condizione della classe operaia è la vera base e il punto di partenza di tutti i movimenti sociali del presente poiché essa è la più alta e la più palese vetta della miseria sociale esistente ai nostri giorni.»
Friedrich Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra
Un celebre aneddoto vuole che nel 1891 il passeggero di un treno fermatosi alla periferia di Wigan per un guasto sulla linea ferroviaria si affacciasse al finestrino e guardandosi attorno pronunciasse la fatidica domanda: «Where the bloody hell are we?».

Qualche anno dopo, il personaggio di “John Willie”, impersonato nei music-hall dal cantante comico George Formby Sr (1875-1921), che fu tra le fonti d’ispirazione del più celebre “Charlot”, soleva presentarsi al pubblico tra un colpo di tosse e l’altro dicendo di essere di ritorno da una vacanza a Wigan Pier. La comicità della gag nasceva dal fatto che quel nome evocava il lungomare di località balneari come Blackpool, quando in realtà l’unico «pier» di Wigan era un molo fluviale per il carico del carbone e i dintorni erano proverbiali per l’aria malsana. Anche se alla fine degli anni Venti il molo venne abbattuto, il sense of humour britannico garantì che quella zona dell’Inghilterra settentrionale mantenesse il nomignolo antifrastico.
La realtà era che le conurbazioni industriali e minerarie di città come Manchester e Leeds a cavallo dei due secoli erano quanto di più simile alla tolkieniana Mordor ci fosse in Gran Bretagna. Ancora negli anni Trenta quegli scorci rappresentavano uno shock percettivo per chiunque arrivasse dal sud. Nelle parole pittoriche di Orwell:
«Alle periferie delle città minerarie i paesaggi sono spaventosi e l’orizzonte è chiuso completamente ad anello da montagne grigie e frastagliate. Sotto i vostri piedi ci sono fango e cenere e sopra la testa sono tesi dei cavi d’acciaio dove carrelli carichi di scorie viaggiano lentamente attraverso il paese per miglia e miglia. Spesso questi cumuli di scorie di carbone sono incendiati e di notte potrete vedere i rivoletti rossi del fuoco che serpeggiano da una parte all’altra, assieme alle fiammelle azzurre e lente dello zolfo, che sembrano sempre sul punto di estinguersi e che poi si riattizzano. […] Ricordo un pomeriggio d’inverno negli orribili paraggi di Wigan. Tutt’intorno regnava il paesaggio lunare dei cumuli di scorie e a nord, attraverso i valichi – per così dire, attraverso i cumuli di scorie –, si potevano vedere le ciminiere delle fabbriche che emettevano le loro creste di fumo».

Eccolo il «bloody hell» dell’ignaro passeggero ferroviario, in cui menava la vita una popolazione pari a quella di Londra. Ma ancora tanta parte di quella vita non era visibile dal finestrino del treno, perché si svolgeva sottoterra, per estrarre il carbone che faceva viaggiare il treno stesso, ma anche la nave, faceva funzionare la fabbrica, riscaldava le case. Era ancora così nel 1936, quando George Orwell andò al nord per la sua inchiesta sul campo, per trasformare l’ideologia in carne e sangue e vite, per vivere con i minatori, nei loro tuguri, visitare i loro luoghi di lavoro, le miniere di carbonfossile. Nei suoi appunti disegnò quadretti e schizzi biografici che in pochi tratti affrescano un mondo. Orwell descrive ambienti, paesaggi, nuclei famigliari, e fa letteralmente i conti della spesa. Conteggia, con il pallottoliere, come un ragioniere economo, per sapere al centesimo quanto costa la vita del proletariato industriale, la classe dal cui lavoro dipende l’intero sistema socio-economico, e quanta misera parte del prodotto resta in tasca al produttore, cioè al minatore e alla sua famiglia. E a conti fatti, l’intellettuale borghese Orwell prova un malcelato senso di vergogna per la consapevolezza che da quel popolo del sottosuolo dipende la vita di quelli come lui, che percorrono la superficie senza vedere:
«In un certo modo è umiliante guardare i minatori al lavoro. Cominci a dubitare momentaneamente del tuo status di “intellettuale”, di persona che nel complesso si considera superiore. Perché capisci, quando li guardi, che è solo perché i minatori sudano sangue che le persone superiori possono rimanere superiori. Io e voi, e il redattore del Times Literary Supplement, e i poetastri e l’arcivescovo di Canterbury e il Compagno X, autore del “Marxismo per l’infanzia”, tutti noi dobbiamo la relativa decenza delle nostre esistenze a quei poveracci che sgobbano sottoterra, anneriti fino agli occhi, con la gola piena di polvere di carbone, che spingono avanti le loro pale con braccia e addominali d’acciaio».

Ma Orwell è anche un grande scrittore e sa di poter fare una cosa: raccontare la discesa agli inferi di quegli uomini, che come goblin o nani mitologici trascorrono le loro giornate lavorative nelle viscere della terra. Un racconto che per la sua vividezza non solo mette alla prova i lettori claustrofobici, ma trasmette ansia e senso di soffocamento a chiunque. Si leggono quelle pagine accompagnati da un pensiero costante: “Lui era lì”. Così come aveva vissuto da nullatenente tra i marginali di Parigi e Londra; così come aveva affrontato l’esperienza del servizio coloniale e toccato con mano la realtà dell’imperialismo; allo stesso modo Eric Arthur Blair in arte George Orwell scende sottoterra, perché non gli basta un’interpretazione politica della realtà se non poggia sull’osservazione empirica ed empatica al tempo stesso. Prima di tutto vuole capire, sentire, respirare la stessa aria viziata e satura di polveri dei minatori, piegarsi e strisciare nei cunicoli delle miniere, per centinaia di metri, perfino per chilometri. Solo così può raccontare davvero e senza filtri la condizione della classe operaia nell’Inghilterra degli anni Trenta, aggiornando il lavoro di uno dei grandi padri del marxismo come Engels, e guardare la propria immagine tanto diversa riflettersi in quella dei minatori. Forte di questa esperienza, pochi anni dopo, potrà dare forma alla sua critica al grande Charles Dickens, erroneamente considerato un romanziere del proletariato urbano, e in realtà ancora intento a coltivare un’urbanissima e individualistica etica borghese, tenendo sullo sfondo la classe lavoratrice e mettendo al centro delle sue storie il riscatto del singolo.

Grazie all’osservazione partecipata Orwell è tanto consapevole che la differenza di classe «basta a rendere impossibile una reale intimità» quanto convinto che lì si annidi il problema. Se mescolarsi con i sottoproletari dei bassifondi è soltanto questione mimetica, ben più difficile è farsi accettare dalla classe operaia, che ha un senso di appartenenza e tratti distintivi molto marcati. Questo porta Orwell a considerare i problemi di relazione e comunicazione tra la “sua” gente e la classe operaia, nella clamorosa seconda parte del libro, quella che il suo editore non avrebbe voluto pubblicare, spaventato dall’impietoso ritratto di una tipologia umana e politica nel quale i lettori si sarebbero riconosciuti.
La critica che Orwell ha saputo portare ai socialisti britannici, che agivano e predicavano nella culla del marxismo, quell’Inghilterra capofila dell’industrializzazione dove sorgevano le fabbriche e i quartieri osservati da Marx ed Engels, è di una crudezza rara. Perché questo libro non parla soltanto di minatori, operai e disoccupati, ma anche dei borghesi che si limitano a votare “bene” senza mutare di un millimetro il proprio stile di vita e modo di pensare; nonché dei borghesi dallo stile di vita invece più alternativo e radicale, ma facilmente percepito come eccentrico e respingente dalla classe lavoratrice.
Il problema, dice pragmaticamente Orwell, è che «come nel caso della religione cristiana, i seguaci del socialismo sono la sua peggiore pubblicità». Bam!
Ad esempio Orwell considera nefasta l’identificazione tra l’ideale socialista e l’idea di progresso tecnologico-industriale infinito. Pur rimanendo estraneo a qualsiasi mito regressivo, auspica un approccio critico al ruolo della tecnologia e dell’industrializzazione nella società contemporanea e al loro impatto alienante sulla classe lavoratrice, la quale non può manco permettersi l’esaltazione romantica del passato cara a certa borghesia. Mito del progresso tecnologico e rimpianto del Medioevo sono le due facce borghesi della stessa medaglia: la distanza tra progressisti e reazionari rimane più corta di quella tra le classi sociali.
La percezione di questa distanza, a volte più culturale che materiale, intralcia l’alleanza possibile tra classe operaia e borghesia proletarizzata in tempi di crisi, che invece sarebbe la chiave di un possibile sbocco rivoluzionario. Piuttosto i borghesi progressisti si convincono che la propria superiorità politico-intellettuale li impegni a redimere i proletari dalla demagogia, dalla rassegnazione e dal cattivo gusto, come appunto in una favola morale dickensiana. Al contrario che nei romanzi però i proletari si rivelano sempre troppo ignoranti e indisciplinati agli occhi di chi vorrebbe illuminare loro la strada verso un mondo migliore, così la delusione spinge i borghesi “rossi” a concludere che i lavoratori non ce la possano fare ad acquisire l’autocoscienza politica e che vadano salvati loro malgrado. Per questo servirà un governo forte, che metta le cose in ordine e faccia ciò che è necessario col pugno di ferro. Nasce da qui il fascino che la borghesia di sinistra nutre per le figure autoritarie, già premessa dei peggiori scenari. Infatti in tempi di crisi economica, la frustrazione e lo snobismo della borghesia spossessata sfoceranno nella sua fascistizzazione:
«È abbastanza semplice immaginare una classe media fatta a pezzi e ridotta in miseria, che rimarrà però ancora fieramente avversa nei suoi sentimenti alla classe operaia: ossia diventerà un partito fascista già pronto all’uso».
Orwell questo lo vedeva succedere in Europa tra le due guerre mondiali. E chissà se oggi riconoscerebbe, mutatis mutandis, un’analoga tendenza in atto nella società occidentale dei nostri primi anni Venti.
«C’è qualcosa che possiamo fare?» si chiede. Il suggerimento è ancora quello di uno scrittore: scegliere nuove parole, rinunciare al gergo dottrinario della tribù “marxista”, tradurlo per i profani, smettere di predicare il sacro verbo. Parlare di socialismo senza parlare di socialismo, insomma, riscoprendo ciò che è stato dato talmente per scontato da essere dimenticato:
«L’unica cosa su cui possiamo allearci sono gli ideali sottintesi al socialismo: giustizia e libertà. Ma sarebbe esagerato definire questi ideali «sottintesi»: sono quasi completamente dimenticati. Sono stati sepolti sotto strati e strati di perbenismo dottrinario, di diatribe di partito, di “progressismo” mal digerito, fino a diventare un diamante nascosto da una montagna di letame. Il compito dei socialisti sarà quello di riportare in luce quel diamante».
Per farlo occorre che la sua gente abbandoni il senso di superiorità intellettuale e morale, provando a mettersi nei panni degli altri, consapevole che se «la povertà è povertà, che il tuo strumento di lavoro sia un piccone o una penna stilografica», allora ragionare alla pari con la classe lavoratrice fa la differenza per qualunque progetto di trasformazione sociale in senso egualitario. Se i proletari, come diceva Marx, non hanno altro da perdere che le loro catene, noi borghesi impoveriti e precarizzati dall’eterna crisi capitalistica, dice Orwell, «non abbiamo da perdere che il nostro buon accento».

Appena consegnato il manoscritto di questo libro all’editore, Orwell partì per la guerra di Spagna, a combattere i fascisti nelle file del POUM. Una volta tornato a casa, dopo essere stato ferito, raccontò dall’interno anche quella pagina di storia. Soltanto nel decennio seguente avrebbe composto la grande allegoria “zoologica” della rivoluzione bolscevica e la più celebre distopia nella storia della letteratura. Se c’è uno scrittore che, nonostante il poco tempo concessogli, ha saputo infilarsi nei meandri della sua epoca per raccontarli quello è Orwell. Il posto di primo piano che occupa nel pantheon laico della sinistra è suo di diritto.
Ma oltre a riverirlo bisognerebbe anche tornare a leggerlo questo autore. Questo libro è l’occasione buona per farlo e per meditare sul nostro presente, come accade con le opere migliori. Voltata l’ultima pagina, facilmente ci si ritroverà a considerare che se mai l’intellettualità di sinistra vorrà recuperare una qualche efficacia del proprio agire politico-culturale dovrà ritrovare la strada per Wigan Pier. Dovunque oggi essa sia.

Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)

