di Gioacchino Toni
 Attorno alla metà degli anni Dieci del nuovo millennio è emersa con forza l’importanza che nell’odierna economia globale sta assumendo il cosiddetto Platform Capitalism – analizzato pionieristicamente da studiosi come Nick Srnicek1 –, cioè quella particolare forma di business ruotante attorno al modello delle piattaforme web rivelatosi il paradigma organizzativo emergente dell’industria e del mercato grazie alla sua abilità nello sfruttare pienamente le potenzialità della cosiddetta quarta rivoluzione industriale.
Attorno alla metà degli anni Dieci del nuovo millennio è emersa con forza l’importanza che nell’odierna economia globale sta assumendo il cosiddetto Platform Capitalism – analizzato pionieristicamente da studiosi come Nick Srnicek1 –, cioè quella particolare forma di business ruotante attorno al modello delle piattaforme web rivelatosi il paradigma organizzativo emergente dell’industria e del mercato grazie alla sua abilità nello sfruttare pienamente le potenzialità della cosiddetta quarta rivoluzione industriale.
Se c’è un settore in cui emerge con chiarezza l’importanza assunta da tale modello questo è il comparto dei media ed è proprio a questo che si riferisce il volume di Luca Balestrieri, Le piattaforme mondo. L’egemonia dei nuovi signori dei media (Luiss University Press, 2021), in cui vengono descritte le trasformazioni culturali e industriali dei media che il “centro del mondo” – che, attenzione, significa certo Stati Uniti ma anche Cina – sta imponendo alle sue periferie.
In generale, quando si parala di “piattaforma” si fa riferimento a «uno spazio per transizioni o interazioni digitali che crea valore attraverso l’effetto network, il quale si manifesta tramite la produzione di esternalità positive» (p. 14). Visto che la creazione di valore deriva soprattutto dalla conoscenza dei clienti e del mercato, diventa fondamentale la capacità di estrazione e di interpretazione dei dati comportamentali dei consumatori.
Essendo la piattaforma a organizzare i flussi di informazione all’interno del network, la sua forza risiede proprio in questa sua capacità di connettere e ottimizzare gli scambi di informazioni tra gli elementi che coinvolge che prima erano invece disseminati lungo una filiera lineare. Si tratta pertanto di una forma organizzativa meglio capace di sfruttare le potenzialità offerte dall’intrecciarsi di intelligenza artificiale, cloud computing e connessioni ultraveloci e che, strada facendo, ha dato luogo a quelle che l’autore definisce come vere e proprie “piattaforme-mondo”:
ecosistemi che organizzano in rete produzione e consumi, sviluppano e gestiscono la tecnologia con cui governano i mercati e tendono a espandersi attraverso il controllo dei dati. La piattaforma diventa mondo, tende a dilatare sena limiti i suoi servizi e le opportunità che offre. È la versione dell’one stop shop sviluppata, con il massimo di rigore e coerenza, per le prime dalle grandi piattaforme cinesi. Una sorta di paese dei balocchi nel quale il consumatore, idealmente, non deve cercare altrove per soddisfare digitalmente ogni suo bisogno (p. 19).
Si sta parlando di colossi statunitensi come Alphabet (gruppo Google), Amazon, Facebook, Apple e Microsoft e cinesi come Baidu, Alibaba e Tencent. A un livello inferiore in questa gerarchia di potenza si collocano invece piattaforme come Netflix e Spotify in quanto impegnate in un segmento di mercato limitato, audiovisivo la prima e musicale la seconda. Per dare un’idea della potenza di fuoco di cui dispongono tali colossi si pensi che nel 2021 tra le dieci imprese a maggior capitalizzazione mondiale figuravano ben sette piattaforme-mondo.
Per comprendere come le piattaforme si siano evolute da semplici sistemi informatici nell’infrastruttura chiave dell’economia globale in grado di erodere le sovranità nazionali, sfruttando la capacità di ottenere ed elaborare dati, lo studioso ritiene sia necessario partire dalle “guerre dello streaming” per il controllo dell’industria audiovisiva statunitense che si sono scatenate negli anni Dieci del nuovo millennio. A una prima fase in cui le piattaforme S-VOD (sevizi video-on-demand richiedenti un abbonamento per una visione senza limiti dei contenuti) sferrano il loro attacco alla televisione multicanale uscendone vincitrici, succede una seconda fase in cui queste piattaforme si scontrano tra di loro per il dominio del mercato in una competizione giocata sul volume di dati raccolti e sull’ampiezza dei servizi che tali dati permettono di proporre in maniera profilata ai consumatori.
Per oltre un trentennio, a partire dagli anni Novanta del Novecento, il sistema della tv via cavo statunitense ha regnato sul sistema mondiale dei media grazie soprattutto alla sua indubbia capacità creativa (che ha portato a fare della serialità la narrazione privilegiata della contemporaneità e del suo immaginario) e all’aver messo in piedi un efficace sistema produttivo e di aggregazione di media company capace di integrare il comparto hollywoodiano tanto a livello creativo che organizzativo. Ne corso degli anni Dieci le piattaforme streaming hanno dunque saputo assimilare e prendere il controllo tanto della creatività seriale che della base produttiva sviluppata nel frattempo dal sistema della tv via cavo.
A risultare vincente, scrive Balestrieri, non è dunque il prodotto in sé (la serialità), che le piattaforme hanno trovato già strutturato dalle cable tv, ma il rapporto con il consumatore, che nello specifico significa la fruizione on demand e la valorizzazione della libertà di scelta. Quando compare Netflix, ad esempio, la cosiddetta complex tv2– la tv della complessità narrativa – era già un dato di fatto così come, almeno parzialmente, le sue innovative modalità produttive. Si potrebbe dire che Netflix arriva quando HBO ha già cambiato la serialità.
Esiste dunque una contiguità ideativa e realizzativa a livello di prodotto; ciò che le piattaforme on demand hanno innovato è la modalità di fruizione e la rapidità con cui il pubblico statunitense si è convertito a questa sembra essere derivata dalla possibilità di controllare autonomamente il tempo di consumo svincolandosi così dal flusso imposto dai palinsesti: «è lo stesso bisogno di differenziare e personalizzare il consumo audiovisivo che, due decenni prima, aveva determinato la rivoluzione creativa e la diversificazione produttiva della tv via cavo e che, negli stessi anni, aveva portato al boom prima dei videoregistratori e poi del Dvr» (pp. 27-28).
A risultare vincenti sono le piattaforme che rinunciano a richiedere il pagamento per ogni singolo atto di consumo – come avveniva nelle prime sperimentazioni on demand – e che propongono invece all’utente, tramite abbonamento, l’esperienza di consumare senza vincoli e senza limiti: «la bulimia di esperienze fictional, di universi narrativi e di immagini che ne deriva è l’atto fondante di un nuovo tipo di consumatore mediale» (p. 29). Nell’offrire allo spettatore immediatamente tutti gli episodi di una serie si sollecita un cambiamento radicale delle abitudini di fruizione allontanandolo ulteriormente dalle proposte delle tv a palinsesto tradizionali, broadcast o cavo/satellite.
Oltre alla possibilità di consumare un’intera serie nei tempi preferiti, il consumatore si trova a poter disporre di una sorta di luna park all’interno del quale può attingere liberamente vivendo un’esperienza di assoluta libertà nella scelta. Si tratta di un’offerta che ha fatto breccia sopratutto tra le generazioni più giovani, e non è forse un caso che gli stessi sistemi educativi, da qualche tempo, siano sempre più inclini a sostituire un’istruzione pianificata in maniera strutturata a “palinsesto”, con una proposta sempre più a “buffet”, ove lo studente vive la sensazione di poter scegliere liberamente tra una molteplicità di offerte formative sempre meno strutturate e bilanciate tra di loro.
Le piattaforme hanno vinto perché, sostiene lo studioso, sono state abili nel creare il consumatore a loro più funzionale.
La piattaforma non mette astrattamente in contatto i soggetti che vi partecipano, ma li plasma e li ridefinisce in funzione dell’ottimizzazione delle loro interdipendenze – in termini di valore per i partecipanti e, soprattutto, per la piattaforma stessa. L’innovazione investe il prodotto, il soggetto che lo offre e il consumatore, educato a scoprire e apprezzare un’esperienza di fruizione diversa. La piattaforma, insomma, è al contempo il legislatore e l’educatore del mondo nuovo che costruisce (pp. 66-67).
Essendo che le piattaforme estraggono valore dall’offerta di servizi regolati dalla profilazione e dall’elaborazione dei dati derivati dal consumatore, quest’ultimo deve essere educato alla fruizione del maggior numero di servizi possibile all’interno di uno spazio digitale unico e alfabetizzato celermente alle regole della piattaforma in maniera che le viva come del tutto naturali inducendolo a comportamenti automatici vissuti come spontanei.
Il consumatore deve essere progressivamente portato a ricercare all’interno di quello spazio il soddisfacimento di bisogni originariamente eterogenei, quali l’informazione e la creazione di comunità, l’esplorazione ludica e l’autoaffermazione, il contratto di vicinanza e lo sguardo sul mondo. I social propongono una user experience facile, immersiva, senza strappi: facilità e immersività apparentemente simili a quelle del flusso televisivo, ma in realtà con un rovesciamento del rapporto tra soggettività e flusso, perché la passività dello spettatore televisivo è trasfigurata in (apparente) protagonismo e l’esperienza sembra ruotare attorno a continue scelte del fruitore attivo (p. 69).
Al di là della percezione del consumatore, modi e forme della partecipazione attiva alla creazione dell’esperienza immersiva sono in buona parte diretti dalle strutture logico-tecnologiche della piattaforma; «quello che sembra un percorso di naturale espansione degli interessi e della socialità del singolo segue un tracciato di messa a valore dei dati estratti e analizzati nell’insieme dello spazio digitale della piattaforma» (pp. 69-70) che lavora incessantemente per ottenere una vera e propria bulimia di contatti e di consumo. Le piattaforme social, in particolare, educano il loro fruitore a una particolare centralità visuale che lo lusinga di essere lui l’oggetto della cultura visiva:
i selfie che intasano i social mostrano i fruitori al centro di spiagge, di montagne, di luoghi di socialità, a riprova che – mentre la televisioni parlava di altro, al più, poteva suggerire un’identificazione con altri, come nei reality – adesso le piattaforme parlano del fruitore stesso, del consumatore che si specchia nell’immagine di sé. Si ottiene così l’effetto network da cui la piattaforma estrae valore. Per questo, l’autoreferenzialità dell’immagine deve essere condivisa e il narcisismo deve diventare contenuto di comunicazione attraverso i like o i retweet (p. 72)
Balestrieri si sofferma particolarmente nell’evidenziare l’asimmetria di potere esistente tra le piattaforme-mondo e i sistemi mediali nazionali.
Il flusso televisivo, nel Novecento e nel passaggio al nuovo secolo, ha svolto una fondamentale funzione costitutiva della socialità e dei percorsi identitari, contribuendo a disegnarne le forme espressive e i valori comunicativi, sostituiti dalle ideologie nella mappatura dello spazio politico e generatrici di rappresentazioni del contemporaneo e del suo significato. Anche nella sua banalità quotidiana, e forse proprio grazie a questa, il flusso televisivo raccontava una grande storia di appartenenza e di identità. Adesso questa capacità di racconto si è logorata, e solo in occasioni eccezionali riesce a trovare nuova potenza emotiva e forza aggregante. La società segue in generale percorsi di soggettività plurime, sempre più estranei alla cultura di massa ereditata dal Novecento, di cui la televisione era elemento costitutivo (pp. 58-59).
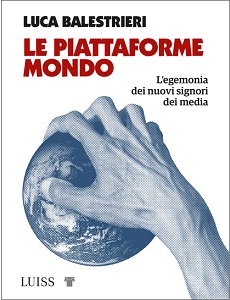 Per certi versi, sostiene lo studioso, l’indebolimento della tv broadcasting spodesta la televisione dal ruolo di cerniera e organizzatrice della creatività mediale che aveva assunto; «la crisi della televisione costituisce il segno più evidente della disarticolazione della centralità nazionali della cultura e della creatività» (p. 91). Dunque, il particolare processo di globalizzazione mediale imposto dalle piattaforme-mondo, secondo Balestrieri, pone una pietra tombale sulla «possibilità di esercitare, attraverso un autonomo sistema dei media, una consapevole, trasparente ed efficace gestione dello spazio in cui si forma i discorso pubblico e si producono dinamiche culturali che in una comunità creano identità (al plurale)» (p. 93).
Per certi versi, sostiene lo studioso, l’indebolimento della tv broadcasting spodesta la televisione dal ruolo di cerniera e organizzatrice della creatività mediale che aveva assunto; «la crisi della televisione costituisce il segno più evidente della disarticolazione della centralità nazionali della cultura e della creatività» (p. 91). Dunque, il particolare processo di globalizzazione mediale imposto dalle piattaforme-mondo, secondo Balestrieri, pone una pietra tombale sulla «possibilità di esercitare, attraverso un autonomo sistema dei media, una consapevole, trasparente ed efficace gestione dello spazio in cui si forma i discorso pubblico e si producono dinamiche culturali che in una comunità creano identità (al plurale)» (p. 93).
Se le realtà locali non sembrano davvero più in grado di dare forma alla cultura di massa creando o adattando contenuti pensati quasi esclusivamente in funzione di un consumo interno, soppiantate come sono dalle piattaforme-mondo capaci di assimilare tratti culturali locali per poi manipolarli in maniera da renderli appetibili al mercato mondiale, non sono mancati casi di “resistenza” locali che, per qualche tempo, hanno saputo anche oltrepassare i confini nazionali.
Balestrieri ricordata ad esempio la capacità in America Latina di dar vita a un prodotto originale come la telenovela capace di insinuarsi nel mercato internazionale; si pensi a come la telenovela brasiliana negli anni Sessanta abbia saputo trasfigurare in modalità melodrammatiche la quotidianità e il senso di appartenenza e di comunità all’interno di un contesto autoritario sapendo trasformarsi nel corso del decennio successivo al pari della società che stava faticosamente uscendo dalla dittatura.
Nei decenni finali del vecchio millennio e nell’inizio del nuovo permane una certa dialettica tra sistemi nazionali e circuiti internazionali, tra centro e periferie a riprova di ciò si pensi al successo del fenomeno “format” soprattutto negli anni Novanta: «formidabile sintesi di globalizzazione del prodotto audiovisivo e di persistenza del mercato nazionale: si prende un’idea che ha avuto successo da qualche parte nel mondo e la si traduce in un contenuto vicino alla cultura del pubblico di un altro Paese» (p. 107). Ebbene, continua lo studioso, le piattaforme operano in maniera inversa: trasformano contenuti locali in prodotti globali e lo fanno forti dell’incredibile potenza di fuoco economica di cui dispongono nell’operare investimenti.
L’era del trionfo delle piattaforme-mondo ridisegna l’universo mediale riconfigurando anche le modalità di globalizzazione sia a livello di organizzazione industriale delle filiere e dei consumi che delle ibridazioni cultuali. Alla centralità dei flussi internazionali di capitali e prodotti propria della prima fase del processo di globalizzazione si sovrappone l’internazionalizzazione dei servizi al consumatore e delle infrastrutture tecnologiche. Il servizio è venduto direttamente al consumatore di ogni angolo del pianeta «disintermediando le filiere che si articolano nei sistemi nazionali dei media. La raccolta delle risorse e le decisioni strategiche sul loro reimpiego passano di mano e saltano il livello locale, lasciando a quest’ultimo magari il ruolo subalterno di fucina creativa a comando. Benvenuti nella globalizzazione mediale 4.0» (p. 109).
Se è pur vero che l’offerta audiovisiva di colossi come Netflix (che nel 2021 vantava oltre 200 milioni di abbonamenti disseminati in ben 190 paesi) o come Amazon è in buona parte fatta di contenuti statunitensi, sarebbe errato secondo Balestrieri vedere in queste piattaforme una semplice prosecuzione del processo di americanizzazione culturale del mondo iniziato con Hollywood.
Nella fase attuale, nella quale l’internazionalizzazione riguarda i sevizi diretti all’utente, lo scopo di un soggetto che opera globalmente come Netflix o Google non è vendere prodotti statunitensi sugli altri mercati, ma vendere il proprio servizio, che può benissimo prevedere anche la valorizzazione dei prodotti locali. Le piattaforme non vogliono americanizzare il consumatore globale, ma creare una nuova specie di consumatore mediale, impegnato nell’ibridazione dei propri linguaggi, valori estetici, strutture narrative all’interno delle interazioni e transazioni governate dalle piattaforme stesse (p. 124).
Attenzione, avverte lo studioso, ciò non significa affermare che le multinazionali non hanno nazionalità; tutt’altro, rispetto alle piattaforme di inizio millennio, nelle odierne il «governo dello sviluppo industriale e dei flussi culturali è ancora più localizzato negli Stati Uniti» ma non si tratta più di un controllo di tipo novecentesco dei mercati contraddistinto da merci culturali vendute e investimenti per acquisire la proprietà dei media, bensì di un controllo delle piattaforme-mondo che «innovano i flussi culturali e creano i propri consumatori attraverso la vendita diretta di servizi, personalizzati sul profilo di fruizione dei singoli individui» (p. 125). Queste piattaforme non necessitano per forza di acquistare media; spesso è sufficiente svuotarli e riconfigurarli all’interno dei propri ecosistemi reindirizzando le catene di distribuzione economiche e culturali in direzione transazionale.
Gli Stati Uniti non sono soli nella creazione di piattaforme-mondo; ad essi si aggiunge la Cina, Paese che ha saputo sfruttare le economie di scopo offerte dalla datification. Si tenga presente, sostiene Balestrieri, che in Cina le piattaforme-mondo non hanno dovuto ingaggiare una battaglia interna nei confronti del vecchio mercato dei media; in buona parte lo hanno creato. Nel paese asiatico si può dire che il sistema dei media sia nato con la digitalizzazione e l’industria audiovisiva con le piattaforme. In Cina lo streaming è infatti giunto diffusamente alla popolazione prima ancora delle sale cinematografiche: nel 2010 si contavano nel paese di un miliardo e trecento milioni di persone poco più di seimila schermi in duemila sale concentrate nei grandi agglomerati urbani. Il cinema nelle sale è arrivato praticamente insieme alle piattaforme strizzando l’occhio a una popolazione giovane nativa digitale che nel primo decennio del nuovo millennio ha imparato a consumare audiovisivi soprattutto attraverso queste piattaforme.
La densità di servizi offerti dagli ecosistemi delle piattaforme-mondo cinesi si traduce anche in un accelerato sviluppo della base produttiva e delle industrie creative che alimentano questa totalizzante user experience. Senza l’ingombro d un robusto sistema dei media preesistente, le piattaforme hanno potuto costruire secondo le proprie esigenze le fabbriche dei contenuti e i bacini di professionalità necessari, sfruttando al massimo le sinergie offerte dalla crescente complessità e articolazione degli ecosistemi (p. 136).
In generale, statunitensi o cinesi che siano, le piattaforme-mondo vivono della conoscenza del consumatore in modo non solo da poter estendere la gamma di sevizi da offrirgli ma anche di poter anticipare e guidare le decisioni dell’utente sia nell’ambito del consumo/acquisto che nelle connessioni sociali. L’obiettivo è dunque quello di plasmare il consumatore.
In chiusura di volume, Balestrieri si concentra sul potere acquisito dalle piattaforme-mondo a proposito del controllo delle tecnologie che alimentano la quarta rivoluzione industriale. In un panorama in cui la capacità di incidere su economia, società e cultura di queste piattaforme sembrerebbe ormai essere sfuggita al controllo statale, quest’ultimo sembra del tutto intenzionato a rifare capolino dopo decenni di inerzia più o meno pianificata. Si pensi che Amazon fornisce servizi cloud a ben 6500 agenzie governative che vanno dal settore della difesa a quello dell’educazione fino ai tanti apparati governativi.
Le tecnologie che in misura significativa cadono sotto il controllo delle piattaforme-mondo costituiscono il nucleo essenziale della sovranità digitale e politico-istituzionale» (p. 163) e quando ciò si è “improvvisamente” palesato, il potere statuale è sembrato svegliarsi dal torpore con l’intenzione di imporre una rinegoziazione del livello di autonomia concedibile. Insomma, la questione geopolitica è sembrata voler riguadagnare il primato che ritiene le aspetti rispetto alla mera efficienza di mercato. Una delle conseguenze di questa volontà di riallineamento delle piattaforme alle esigenze geopolitiche sembra essere «la fine dell’ideologia della globalizzazione neutrale: le piattaforme sono americane o cinesi, al massimo le prime si vestono del ruolo di campioni dell’occidente, o campioni delle autodefinite tecno-democrazie contro le cosiddette tecno-autocrazie (p. 163).
Se in Cina, dopo un decennio di deregolamentazione che ha riguardato tanto l’ambito finanziario quanto quello delle piattaforme, lo Stato ha potuto ribadire la propria supremazia celermente, negli Stati Uniti, dopo diversi decenni di neoliberismo spinto, il confronto tra piattaforme e Stato appare più travagliato. Resta il fatto che dalla negoziazione anche aspra tra piattaforme-mondo, preoccupate a non perdere competitività sui mercati internazionali, e Stati, con annessi interessi geopolitici, sembrerebbe derivare la presa d’atto che interessi economici e sovranità possono andare di pari passo: i primi hanno necessità di accedere ai dati di cui è in possesso lo Stato (sanità, istruzione ecc.) mentre i secondi necessitano degli efficientissimi oligopoli tecnologici che consentono la sovranità digitale.
Su Carmilla – Serie completa Culture e pratiche della sorveglianza
