di Paolo Lago e Gioacchino Toni
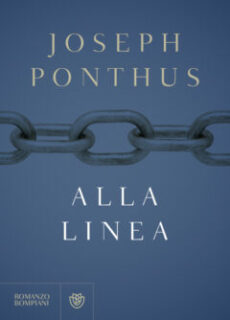 Joseph Ponthus, Alla linea. Fogli di fabbrica, trad. di Ileana Zagaglia, Bompiani, Milano 2022, pp. 256, € 17,00
Joseph Ponthus, Alla linea. Fogli di fabbrica, trad. di Ileana Zagaglia, Bompiani, Milano 2022, pp. 256, € 17,00
Giunge in questi giorni in libreria in traduzione italiana il libro di Joseph Ponthus, À la ligne. Feuillets d’usine (2019), opera che ha ottenuto alla sua uscita in Francia un importante successo di critica e lettori, capace di condividere, senza pietismo né autocelebrazione, uno spaccato di quel mondo operaio contemporaneo del settore agroalimentare composto soprattutto da interinali applicati alla catena di montaggio di cui si preferisce non parlare, quasi ci si vergognasse di ammetterne anche solo l’esistenza, per non turbare lo storytelling patinato che riduce il settore a packaging suadenti e mirabolanti sfide gourmet ai fornelli televisivi.
Joseph Ponthus, pseudonimo di Baptiste Cornet, nonostante le origini popolari riesce ad ottenere una borsa di studio che gli consente di costruirsi una solida formazione letteraria. Dopo aver lavorato come educatore a Nanterre, nella periferia parigina, si stabilisce con la moglie in Bretagna dove, non trovando occupazione nel suo settore, si trova a dover lavorare come interinale nell’industria agroalimentare per un anno nelle industrie conserviere del pesce e per due nei macelli.
Cosa significa entrare in una di queste industrie, soprattutto da interinale, lo spiega l’autore stesso in un’intervista rilasciata ad Émilien Bernard: «Non appena metti piede lì, la fabbrica è ovunque. Ti mangia il quotidiano. Mi ricorda il modo in cui i minatori si riferivano alla miniera, dicendo che era un “mangiatore di uomini”. La fabbrica è lo stesso. Gli uomini e le donne che ci lavorano pensano solo a questo: l’ora in cui ti sveglierai, l’ora della pausa, il prossimo arrivo. È una lotta perpetua contro il tempo»1.
In tale universo lavorativo, composto in buona parte da interinali, dichiara Ponthus nell’intervista, «sono riusciti ad atomizzare la coscienza della classe operaia. Oggi non ti definisci più come un lavoratore, o come un dipendente di una determinata azienda, ma in relazione alla tua postazione di lavoro, dove c’è concorrenza. Questo porta alla conclusione: non è più possibile alcuna lotta collettiva. […] È il trionfo del capitalismo nella sua forma più violenta. E poi, lavorando nell’agroalimentare, non hai l’orgoglio della produzione. In una fabbrica “normale” si parte da zero e si finisce con un prodotto finito. Nell’agroalimentare è il contrario, è decostruzione: prendi un prodotto intero, per esempio una mucca, e ti ritrovi con una bistecca. È impossibile essere orgogliosi di dare la morte»2.
L’universo di sfruttamento dell’agroalimentare bretone non è molto diverso da quello emiliano raccontato da Giovanni Iozzoli nel suo L’Alfasuin (Sensibili alle foglie, 2018)3, romanzo incentrato sullo sgretolamento di un sistema costretto a fare i conti con una generazione sfruttata e inascoltata di lavoratori, spesso di origine straniera, che di fronte a condizioni di vita e di lavoro insostenibili ha trovato il coraggio di ribellarsi. Se Iozzoli lo ha raccontato intrecciando le vicende di una dinastia imprenditoriale locale che ha raggiunto il successo nell’ambito del settore alimentare, di una famiglia malavitosa in cerca di costruirsi una rispettabilità pubblica e, soprattutto, di tanti lavoratori provenienti dai quattro angoli del mondo per lavorare e garantirsi una vita meno agra di quella vissuta in patria, assunti con contratti vergognosi, Ponthus lo ha fatto in prima persona, elencando, insieme ai gesti ripetitivi del lavoro alla catena di montaggio, lo stato d’animo con cui li esegue, la fatica ma anche le vie di fuga a cui ricorre per sopportare tutto ciò: sprazzi di autori latini, romanzieri, poeti e cantanti che il suo pensiero riesce ad inserire tra i brevi interstizi di tempo che ricava tra le operazioni che è chiamato a svolgere.
Al racconto autobiografico ricorre anche Alberto Prunetti nel suo 108 metri. The new working class hero (Laterza, 2018)4 ove, mescolando sapientemente espressioni popolari toscane e inglesi, momenti di ilarità e di amarezza o rabbia, racconta la sua personale esperienza di lavoro in terra inglese nell’ambito della ristorazione e dintorni. Quello tratteggiato da Prunetti è un mondo del lavoro infernale, derivato dalla deregolamentazione thatcheriana, abitato da datori di lavoro senza scrupoli e da patetici capireparto che per mantenere il gradino sociale raggiunto sono disposti ad infliggere qualsiasi tipo di angheria ai loro sottoposti. In tale inferno l’autore-protagonista trova modo di fraternizzare con un manipolo di appartenenti a quella feccia proletaria che l’establishment inglese eliminerebbe volentieri ma che preferisce sfruttare il più possibile, magari al riparo da occhi indiscreti. Una ciurma di disgraziati cresciuti nella deregulation imperante, soggetti atomizzati allo sbaraglio che non riescono nemmeno a riconoscersi come classe sociale e che si confrontano, quando possono, con le angherie subite soltanto con gesta sguaiate, isolate e senza futuro. Per raccontare le proprie vicissitudini di lavoratore migrante e per difendersi da esse, Prunetti alterna il racconto della quotidianità in terra inglese a sprazzi di memoria dell’orgoglio operaio della generazione del padre, lavoratore delle acciaierie di Piombino, e della sua adolescenza in un contesto in cui la collocazione di classe era ancora non solo evidente ma anche esibita e rivendicata con fierezza.
Anche Ponthus è alla ricerca di qualche espediente che gli consenta di sopportare meglio l’inferno quotidiano e lo trova nel ricorso a una scrittura in cui miscela tratti di autobiografia e diario quotidiano adottando uno stile narrativo in cui il romanzo si intreccia con la poesia e la semplice annotazione puntale dei gesti compiuti o a cui assiste quotidianamente dentro e fuori la fabbrica. Il ricorso ad una ritmica sincopata non è però mera riproposizione del ritmo di fabbrica subito bensì, come scrive Claudio Panella5, sembra voler riprodurre le modalità con cui «i pensieri al lavoro si dimenano cercando di sfuggirlo, di meglio sopportare il tempo che manca alla fine del turno». È lo stesso autore a motivare la scelta stilistica nell’intervista rilasciata ad Émilien Bernard: «Dalla mia prima settimana di lavoro ho iniziato a scrivere dei passaggi quando tornavo a casa, di pomeriggio o la sera, a seconda dei miei orari, quando non ero troppo stordito. Il mio obiettivo era scrivere in un modo simile a come funzionavano i miei pensieri quando ero al lavoro. In fabbrica ti trovi di fronte al problema della cadenza, cioè la produzione imposta dalla fabbrica stessa. […] Ma una volta che impari a effettuare il gesto per bene, a diventare tutt’uno con lo strumento o la macchina, diciamo che puoi farlo in quarantacinque secondi. Hai più o meno quindici secondi di “libertà”. Qui è dove hai tempo per pensare. E io pensavo ai libri, alle poesie, alle frasi che avrei scritto la sera quando sarei tornato a casa […] È qui che è nata e si è imposta la questione del ritmo letterario. Perché io volevo scrivere su questi quindici secondi di libertà. Se avessi scelto di adattarmi al ritmo regolare della fabbrica, un compito al minuto, allora avrei scritto in versi regolari, di tipo alessandrino. Ma il mio ritmo era diverso, poiché io lottavo contro la cadenza, con delle irregolarità, a volte cinque secondi, a volte dieci o quindici. Quindi potevo scrivere solo in versi liberi»6.
La scrittura di Ponthus si trasforma in lotta quotidiana per la libertà: «Ho scritto e ho rubato due ore alla mia quotidianità / e alla mia famiglia / Ore alla fabbrica / Testi e ore / Come tanti baci rubati / Come tanta felicità». La scrittura appare quindi anche come un mezzo per sfuggire agli spazi infernali ed opprimenti della fabbrica divenendo essa stessa uno spazio utopico, un luogo che però diviene reale nel momento in cui si scrivono le parole sulla carta o si battono sulla tastiera del computer. La scrittura è perciò anche tempo ed è quindi intrisa di una temporalità che diviene corpo e materia, spazio di libertà. Come scrive Roland Barthes, «la scrittura è precisamente questo compromesso tra un atto di libertà e un ricordo, è quella libertà piena di ricordi che non è libertà se non nell’attimo della scelta, ma già non più nella sua durata»7. Una «libertà piena di ricordi» si palesa ad esempio nel momento in cui il poeta si chiede «cosa ci faccio io qui?»: Non è il mio posto il mio lavoro la mia vita cosa ci faccio qui / con tutti i miei anni di studio quello che ho letto scritto o / capito sul senso del mondo». Ma nell’attimo in cui egli si rende conto che esistono vie di fuga, linee serpentine che lo possono condurre lontano dagli spazi imprigionanti della quotidianità, è proprio in quel momento che emerge lo spazio di libertà che si fa materia e tempo: «Lo devo all’amore / Lo devo alla mia forza / Lo devo alla mia vita». È nel momento in cui tutto sembra perduto che si scoprono inediti percorsi di resistenza. La scrittura è indubbiamente uno di questi ma anche tutte le letture fatte, le poesie scritte, le canzoni ascoltate (soprattutto quelle di Charles Trenet e Barbara) che si possono ripetere e canticchiare nell’inferno del tempo di fabbrica sono decisive ancore di salvezza. Ponthus ribadisce ogni attimo – all’interno del suo romanzo in forma di poemetto la cui scrittura scivola via come un flusso di sensazioni, ricordi, percezioni, impressioni – che in definitiva non perde mai la propria ricchezza interiore, il proprio «privilegio del pensare», per citare Pasolini. Come quest’ultimo scrive in alcune poesie de La religione del mio tempo in cui descrive i momenti più duri e poveri della sua vita, appena giunto a Roma, perduto in una misera casa delle borgate di Rebibbia, è la «coscienza» della sua «ricchezza» interiore a permettergli di andare avanti: i suoi studi, le sue letture e le sue scritture, la sua passione per l’arte e la letteratura. Nella povertà estrema e nella dura vita di ogni giorno, trascorsa in interminabili viaggi in autobus per raggiungere le scuole di periferia dove lavorava come insegnante, il poeta riusciva a trovare delle vere e proprie falde di resistenza nella sua ‘ricchezza’ personale. Ecco che, allora, per Ponthus, Charles Trenet si trasforma in «un immenso Charlot che rende / sopportabile l’inferno dei tempi moderni».
Nell’ottica di Ponthus, quello della fabbrica appare come un vero e proprio inferno, paragonabile alla trincea durante una guerra. Per descrivere le esperienze di lavoro nel settore agroalimentare e presso il mattatoio, dove doveva pulire il sangue dei maiali macellati, il poeta non esita a richiamare l’universo della guerra: «Pulitore di trincea / Pulitore di mattatoio / È quasi lo stesso / Mi sento come se fossi in guerra / I brandelli i pezzi l’equipaggiamento necessario il sangue / Il sangue il sangue il sangue il sangue», mentre gli stessi operai che si recano al lavoro appaiono quasi come soldati che si recano al fronte. Oltre ad evocare l’inferno della guerra, l’iterazione (in cui le parole «il sangue» sono ripetute ben cinque volte) che chiude il verso e che suona come un lugubre rintocco, richiama ancora una volta potentemente la sfera corporea: il corpo stesso del poeta, quasi come i corpi degli animali uccisi, subisce un graduale abbrutimento, una graduale coercizione verso l’assuefazione ai terribili ritmi lavorativi. Questi ultimi si trasformano in una nuova Odissea: se la fabbrica si trasforma in Mediterraneo, i «gamberetti» diventano «le mie sirene / i buccini i miei ciclopi / il guasto del nastro trasportatore solo un’altra tempesta». E allora «la produzione deve continuare / Sognando Itaca / Nonostante la merda». Alla fine del viaggio-inferno c’è pur sempre un’Itaca e il solo sognarla potrebbe rappresentare un sabotaggio a quella produzione incessante, al ritmo coercitivo e lavorativo della fabbrica perché è sempre e solo nell’ottica dei padroni, detentori del capitale, che la «produzione deve continuare». Tutte le citazioni inserite nell’incedere impetuoso della scrittura poetica, tutti i riferimenti alle canzoni, alla letteratura, alla poesia, all’arte sono piccoli sabotaggi che si insinuano nel ritmo della produzione. Anche la stessa scrittura diviene sabotaggio, diviene resistenza e, in definitiva, un vero e proprio strumento di libertà. Le parole poetiche sono perciò un momento di «silenzio del lavoro» perché rappresentano qualcosa di veramente antitetico ad esso.
Perché in definitiva, la fabbrica, come i templi greci, la prigione e le isole – come leggiamo in un momento iniziale del poemetto – appaiono come «Mondi chiusi / Dove si va solo per scelta / Deliberata / E da cui non si esce / Come dire /Non si lascia un santuario indenni / Non si lascia mai davvero la galera / Non si lascia un’isola senza un sospiro / Non si lascia la fabbrica senza guardare il cielo». Mondi chiusi che potrebbero assomigliare, perciò, alle eterotopie, cioè gli “spazi altri”, come sono descritti da Michel Foucault (citato tra l’altro da Ponthus in riferimento alla prigione). La fabbrica, come del resto la prigione, sarebbe comunque un’eterotopia che non apre alla libertà dell’immaginazione come, secondo, Foucault, ad esempio fa la nave, «eterotopia per eccellenza» nell’ottica dello studioso francese8. Sono spazi ‘altri’ consegnati alle dinamiche della disciplina e della coercizione per cui diventa importante ritagliarsi spazi utopici di libertà all’interno di essi. La scrittura, come abbiamo visto, è uno spazio utopico di libertà che, nell’opera di Ponthus, diviene ben reale: diviene resistenza e strumento di resistenza, un luogo di libertà che può accogliere in sé il corpo e la mente del poeta ma anche di altri, nuovi resistenti che, come lo stesso autore, riescono a sopravvivere grazie a personali vie di fuga dall’inferno della fabbrica.
Durante la settimana, al lavoro si parla poco tra colleghi, sia perché si indossano i tappi nelle orecchie che perché, tutto sommato, dichiara amaramente Ponthus, non c’è granché da dirsi a parte scambi di ordini e invettive. «Per una settimana sei formattato in una non-lingua, in modalità performativa […] Non parli. Durante la pausa fumi la tua sigaretta, bevi il tuo caffè e nient’altro. Dato che sei nell’industria della morte, di notte ti divora, hai gli incubi. […] Una cosa è certa: musi tagliati, mammelle affettate, queste cose non si possono raccontare nella lingua dei vivi, perché nessuno può capire. La lingua si ferma. Questa vita quotidiana passa attraverso gli occhi, le espressioni facciali del lavoratore, una mano che batte sulla spalla, ma non attraverso la voce. C’è solo la scrittura che può farlo»9.
Joseph Ponthus è scomparso nel febbraio dee 2021 a soli quarantadue anni. Nel ricordare questo «attivista, insegnante precario e operaio interinale, autore di À la ligne, un capolavoro di scrittura working class», scrive Alberto Prunetti: «La sua esistenza è stata breve, ma il suo tempo non è stato perduto, come in À la ligne si diverte a dire sfrontatamente a Monsieur Proust: «Cher Marcel, ho trovato quel che tu cercavi. Vieni in fabbrica. Te lo mostrerò io, il tempo perduto»10.
