
Milano, 29 dicembre 2022, manifestazione in solidarietà ad Alfredo Cospito.
Dopo decenni di «scioperi della fame» per modo di dire – all’acqua di rose, meramente simbolici, spesso solo mediatici, annunciati anche per questioni di dubbia rilevanza – non ci impressiona più sentire che una persona è in sciopero della fame. Almeno dalle nostre parti, il concetto è inflazionato, e una pessima informazione fa il resto.
La maggior parte di noi non si immagina com’è, un vero sciopero della fame.
E allora bisogna farlo capire.
Ecco un paio di esempi, due vicende accadute qui in Europa.
1. La storia e il corpo di Holger Meins

Holger Meins (1941 – 1974)
Holger Klaus Meins, militante della Rote Armee Fraktion, viene arrestato a Francoforte l’1 giugno 1972 e messo in isolamento totale nel carcere di Coblenza. Tutte le celle intorno alla sua sono vuote.
Nel gennaio 1973 Holger comincia il primo sciopero della fame. Uno sciopero collettivo, dichiarato da tutti i membri della RAF incarcerati e sospeso dopo cinque settimane.
Holger è trasferito nel carcere di Wittlich, dove nel maggio 1973 riprende lo sciopero. Già magro di suo, non mangiando deperisce a vista d’occhio. Dopo cinque settimane lo mettono in regime di alimentazione forzata: due volte al giorno i secondini gli infilano un tubo in gola, come si fa con le oche da foie gras, e gli pompano cibi liquidi nello stomaco.
L’alimentazione forzata è una pratica violenta, che induce nausea e senso di soffocamento, produce lacerazioni e infezioni nel cavo orale e nell’esofago, e per il frequente contatto tra sangue, muco e pus può causare malattie di vario genere. Non serve a salvarti, ma a prendere tempo. Assicura il protrarsi di una nuda vita, e intanto ti devasta più della fame.
Dopo altre due settimane, ancora una volta la RAF sospende lo sciopero.
Il 13 settembre 1974 parte il terzo sciopero, a cui aderisce una quarantina di detenute e detenuti e che durerà cinque mesi. Per Holger l’alimentazione forzata scatta dopo tre settimane. Gli danno appena quattrocento calorie al giorno, si scoprirà in seguito. Sufficienti solo a farlo vegetare. Il suo fisico è in grave dissesto, non più in grado di reggere né il digiuno né il tubo.
L’8 novembre Holger non ha più forze. Chiede di vedere il suo avvocato, Siegfried Haag. Quest’ultimo deve penare per essere ammesso nel carcere e visitare il suo assistito. Nel vederlo, rimane sconvolto: Holger è in condizioni terminali, uno scheletro con la pelle. Alto più di un metro e ottanta, pesa poco più di trentanove chili.
È un venerdì sera e non c’è nemmeno il medico del carcere, che si è preso il weekend libero. Haag telefona al magistrato competente per chiedere una visita medica urgente. Non la ottiene.
Holger si spegne poche ore dopo, all’alba di sabato 9 novembre, dopo 57 giorni di sciopero. Aveva appena compiuto 33 anni.
La foto del corpo sul tavolo autoptico – avvertenza: immagine orribile, insopportabile, che tocca persino l’olfatto – trapela e fa grande scalpore. Con la sua pubblicazione, lo sciopero della fame cessa di essere qualcosa di vago. Per un istante risulta evidente il cinismo delle autorità della Repubblica Federale Tedesca, che hanno permesso un simile esito.
Proprio quella foto spinge decine di persone ad arruolarsi nella RAF. Hans Joachim Klein, militante del gruppo Revolutionäre Zellen, la tiene nel portafogli e ogni tanto la guarda. «Per mantenere affilato il mio odio», dirà.
Anche sull’onda dell’emozione suscitata dal caso, nel 1975 l’Associazione Medica Mondiale dichiara che l’alimentazione forzata dei detenuti è affine alla tortura e la include tra le pratiche di cui un medico non deve farsi complice.
«Quando un detenuto rifiuta di nutrirsi ed è ritenuto dal medico in grado di formarsi un giudizio integro e razionale sulle conseguenze di tale rifiuto volontario, non deve essere nutrito artificialmente […] La decisione sulla capacità del detenuto di formarsi tale giudizio deve essere confermata da almeno un altro medico indipendente. Le conseguenze del rifiuto di nutrirsi devono essere spiegate dal medico al detenuto.»
Certo, si può aggirare l’ostacolo facendo dichiarare il detenuto incapace di intendere e di volere.
E in ogni caso, in mezzo mondo si continuerà a usare il tubo. Anche nel nostro occidente. Spesso «in difesa» dell’occidente medesimo e, come suol dirsi, dei «suoi valori». Come a Guantanamo.
2. La vicenda più celebre: Bobby Sands
Il più noto sciopero della fame della storia europea ha luogo nel 1981 nel carcere di Long Kesh – detto «The Maze», il dedalo – in Irlanda del Nord.
Tra marzo e giugno muoiono dieci militanti dell’IRA e dell’INLA.
Il primo a spegnersi è il ventisettenne Bobby Sands, che diverrà il più famoso martire legato a questa forma di lotta.

Belfast, 5 maggio 1981. Il funerale di Bobby Sands.
–
La storia della battaglia di Sands in carcere e della sua morte è raccontata con impressionante realismo nel film Hunger di Steve McQueen (2008).
Chi vuole capire cos’è uno sciopero della fame, guardi la foto del corpo di Holger Meins e l’interpretazione di Michael Fassbender in Hunger.
3. L’Italia, Alfredo Cospito e «la sinistra»
Anche nell’Italia di questi anni sono morti detenuti in sciopero della fame. I tre casi più recenti sono quelli di Salvatore “Doddore” Meloni (2017), Gabriele Milito (2018) e Carmelo Caminiti (2020). Tutti e tre deceduti nell’indifferenza quasi generale.
Grazie a una mobilitazione continua e capillare, del caso del compagno anarchico Alfredo Cospito si è invece riusciti a far parlare. Non abbastanza, ma più di quanto ci si poteva attendere.
Cospito è all’ottantesimo giorno di sciopero della fame. Del suo caso abbiamo già scritto a dicembre, e ne abbiamo più volte parlato in pubblico. L’ultima presentazione di Ufo 78 prima della pausa festiva, alla Biblioteca Classense di Ravenna, l’abbiamo cominciata leggendo quest’articolo di Adriano Sofri uscito sul Foglio. Testata che normalmente deprechiamo, ma l’articolo è perfetto, soprattutto il finale. È tuttora una delle cose più chiare e forti scritte su questa vicenda.
 Nei giorni scorsi un vasto gruppo di giuristi e intellettuali ha rivolto un appello al ministro della giustizia Carlo Nordio, chiedendo che Cospito sia tolto dal regime di detenzione 41bis. Da più parti abbiamo visto commentare: «Con ‘sto governo di fascisti, figurarsi…»
Nei giorni scorsi un vasto gruppo di giuristi e intellettuali ha rivolto un appello al ministro della giustizia Carlo Nordio, chiedendo che Cospito sia tolto dal regime di detenzione 41bis. Da più parti abbiamo visto commentare: «Con ‘sto governo di fascisti, figurarsi…»
Solo che ad appioppare a Cospito il 41bis, e a difendere pubblicamente la scelta, è stato il ministro della giustizia del governo Draghi, Marta Cartabia. E i primi allarmi su una possibile estensione del 41bis dai boss mafiosi ai detenuti politici e in generale ai dissenzienti risalgono ai tempi del governo Gentiloni, il cui guardasigilli era Andrea Orlando del PD.
Chi non conosce la storia della repressione poliziesca e giudiziaria in Italia tende a peccare di «recentismo» – o «presentismo» che dir si voglia – e a pensare che la controparte sia solo questo governo, cioè la destra dichiarata.
In realtà la vicenda Cospito è il culmine di un lungo processo che ha visto più spesso protagonista l’altra destra, quella che è stata al governo più volte e più a lungo, quella che si fa chiamare «la sinistra»: dirigenti e opinionisti del Partito Democratico e di sue formazioni-satellite; firme e firmette del partito-giornale Repubblica e di altre testate liberal-de-noantri; procuratori e giudici aderenti a Magistratura Democratica, e in generale – qui prendiamo in prestito il titolo di un romanzo di Luca Rastello – «i buoni».
È stata «la sinistra» a innescare le peggiori recrudescenze autoritarie e repressive. È nel mondo dei «buoni» che si è gonfiato a mo’ di blob un purulento mischione di rimasugli stalinisti, mentalità “manettara”, apologia delle «regole», feticismo della «legalità» come valore in sé, adesione al There Is No Alternative neoliberale ecc.
 Ricostruire i processi che hanno reso egemone “a sinistra” una simile subcultura è ben più di quanto possiamo fare in quest’articolo.
Ricostruire i processi che hanno reso egemone “a sinistra” una simile subcultura è ben più di quanto possiamo fare in quest’articolo.
Bisognerebbe risalire agli anni Settanta, alla stagione dell’Emergenza e delle leggi speciali, alla linea del «rigore» durante il sequestro Moro.
Poi si dovrebbe smontare un certo legalitarismo statolatrico che ha sfruttato i simboli dell’antimafia per diventare incontestabile e poter invadere sempre più ambiti.
Dopodiché andrebbe spiegato il ruolo che ebbero Mani Pulite e subito a seguire l’«antiberlusconismo», strumentale postura usata per imporre il «menopeggismo» che ci ha devastati.
Lungo questa linea andrebbero collocati concetti-slogan quali «degrado», «decoro» e «sicurezza», magistralmente sviscerati da Wolf Bukowski nel suo La buona educazione degli oppressi (Alegre, 2019).
Si arriverebbe infine alla gestione dell’emergenza pandemica, che “a sinistra” – anche in quella che suol dirsi «radicale» – è il grande tabù.
Oltre quarant’anni di devolution ideologica. Ricostruirli è al di sopra delle nostre forze. Noi possiamo solo mettere la pulce nell’orecchio a chi fa ricerca storica. E fare esempi.
4. «I buoni» e la repressione: il caso Torino
Non è stato forse un «buono» tra i più celebri e incontestabili a creare un «pool anti-No Tav» dentro la Procura di Torino?
Tale «pool», come già raccontavamo in Un viaggio che non promettiamo breve (Einaudi, 2016), ha condotto esperimenti giuridico-mediatici a tutto campo, a partire da un’estensione ad libitum del concetto di «terrorismo» e da un uso piuttosto disinibito delle imputazioni per reati associativi.
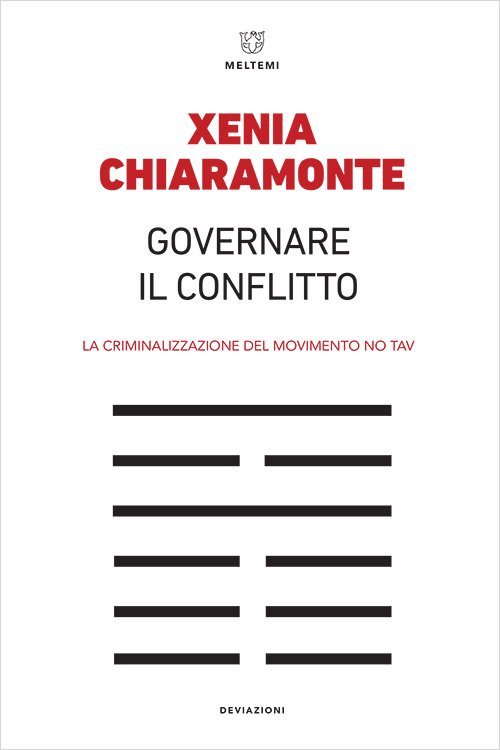
Il libro di Xenia Chiaramonte Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No Tav (Meltemi, 2019)
Esperimenti grazie a cui, come spiegato da Xenia Chiaramonte, ha preso forma non solo un repertorio di strategie di criminalizzazione ed escamotages vari, ma anche un nuovo modello «neopositivistico», un vero e proprio «diritto penale di lotta», basato sulla profilazione del nemico politico e addirittura culturale.
In pochi anni la “democratica” Torino è diventata la capitale morale della repressione, con grande soddisfazione ed entusiasmo del PD e del suo mondo. Si pensi ai toni con cui l’oggi ex-deputato Stefano Esposito acclamava ogni carica di celere, ogni arresto, ogni condanna in tribunale. Ci è subito venuto in mente lui, ma non era certo il solo.
La guerra al movimento No Tav e, in subordine, ai centri sociali cittadini ha fatto scuola e suggerito modi di affrontare o prevenire altre insorgenze.
È stata la Procura di Torino a rinverdire l’istituto della sorveglianza speciale – ultima discendente del confino fascista, con cui ha molti elementi in comune – per soggetti «socialmente pericolosi». Oggi quello strumento è usato per colpire le nuove lotte su ambiente e clima. Pochi giorni fa è stata chiesta la sorveglianza speciale per Simone Ficicchia, 20 anni, di Voghera, attivista di Ultima Generazione.
È stata sempre la Procura di Torino a chiedere la riqualificazione del reato risalente al 2006 per cui Cospito stava già scontando la pena: aver piazzato un ordigno a basso potenziale di fronte alla Scuola Allievi Carabineri di Fossano (CN). Il reato è così trasmigrato dall’articolo 422 all’articolo 285 del codice penale: non più tentata strage contro «la pubblica incolumità», ma contro «la sicurezza dello stato», benché non ci siano stati morti né feriti né contusi.
La differenza è quella che passa tra vent’anni di galera e la galera per sempre, cioè l’ergastolo «ostativo», ufficialmente incostituzionale eppure ancora tra noi e difeso – proprio come il 41 bis – da molti «buoni».
Gli stessi che dello sciopero di Cospito, e della sua possibile sorte, hanno già ampiamente dimostrato di fregarsene.
5. Il «macchinario» vs. il corpo di Alfredo
Alfredo Cospito regge ancora perché, a differenza di Holger Meins e Bobby Sands, aveva in partenza un fisico robusto, ma ha già perso trentasei chili ed è in una situazione forse non disperata ma certo molto grave.
Come ha scritto Adriano Sofri nell’articolo già segnalato,
«Cospito poteva tornare a essere una persona solo decidendo di destinare il proprio corpo a una morte non dilazionata secondo la regola del fine-pena-mai. Il suo è uno sciopero della fame duro, che l’ha già portato in una condizione allarmante. In apparenza, due oltranzismi si fronteggiano: il rincaro della “giustizia”, che è anonimo o è come se lo fosse, è un macchinario, assicurato dell’irresponsabilità personale, e la volontà di andare “fino in fondo” del detenuto. Tutti vedono, non possono non vedere, che non c’è niente di simmetrico nelle due oltranze.»
Di fronte al macchinario, Cospito ha solo il proprio corpo.
Noi però non vorremmo vedere quel corpo in una foto come quella scattata a Wittlich.
Noi vogliamo che Alfredo viva.
Non vogliamo un martire, ma la fine del 41 bis e una nuova consapevolezza su giustizia e carcere in Italia.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)