di Diego Gabutti
 Non ricordo più chi venne prima, se Bartleby o Wakefield. Forse Wakefield, nel quale m’ero imbattuto bazzicando le bancarelle di Piazza Carlo Alberto, nel centro di Torino, sotto le grandi arcate progettate da Guarino Guarini. Alle spalle l’antico parlamento sabaudo, di fronte la Biblioteca Nazionale con la sua soleggiata facciata neoclassica.
Non ricordo più chi venne prima, se Bartleby o Wakefield. Forse Wakefield, nel quale m’ero imbattuto bazzicando le bancarelle di Piazza Carlo Alberto, nel centro di Torino, sotto le grandi arcate progettate da Guarino Guarini. Alle spalle l’antico parlamento sabaudo, di fronte la Biblioteca Nazionale con la sua soleggiata facciata neoclassica.
“Wakefield” venne prima di “Bartleby” anche quanto a data d’apparizione. Nathaniel Hawthorne lo pubblicò nel 1835 (nel 1937 fu uno dei “Twice-Told Tales”, i racconti narrati due volte) mentre Herman Melville pubblicò “Bartleby, the Scrivener. A Story of Wall Street nel 1853, due anni dopo Moby Dick”, diciotto anni dopo “Wakefield”. Quando io lo lessi per la prima volta doveva essere il 1966, o forse il 1967, poco prima (o poco dopo) che da Palazzo Campana, sede delle facoltà umanistiche, affacciato sulla stessa piazza delle bancarelle, cominciassero a rullare i tamburi del movimento studentesco e delle occupazioni.
Abitavo poco lontano e, da quando avevo dieci anni, passavo di lì regolarmente, dapprima due o tre volte la settimana, poi ogni giorno, puntuale come Carosello. All’inizio facevo incetta di vecchi Urania, di vecchi Gialli Mondadori; poi di tutto quel che c’era, da Hawthorne e Melville alle farse del Signor Bonaventura scritte da Sergio Tofano, dai fumetti di Flash Gordon disegnati da Dan Barry (bisognerà parlarne, prima o poi) a Proust (che però mi decisi a leggere soltanto molti anni dopo, pentendomi di non averlo fatto prima). Dice Charles Simic, grande poeta serbo-americano: «Ho letto di tutto, da Platone a Mickey Spillane». Vale anche per me. E un po’ per tutti gli adolescenti dell’epoca; e se non per tutti, almeno per molti, e di sicuro per i coetanei che conoscevo e frequentavo io, a scuola e fuori (più fuori che a scuola, a scuola ci andavo poco, e di malavoglia). In giro per libri usati dopo un po’ tutti conoscevano tutti. Un cenno del capo, un caffè.
Trovato un libro, lo sfogliavo, e talvolta leggevo per intero, seduto al tavolino di qualche bar. Cappuccini. Mandrake, La fiera letteraria. Caramelle. Una brioche. Fumavo già come un dannato.
Di Wakefield e della sua enigmatica epopea fui subito un fan. Assai meno chiacchierato di Bartleby> – che col suo inespugnabile «preferisco di no» ha ispirato saggisti e romanzieri diventando malgré lui un cliché abusato dagli intellò di scarso impegno e d’ancor più scarso ingegno, e pertanto tutti giù a citare Beckett, Kafka, Il pasto nudo, Bergman, Antonioni, Magritte – Wakefield merita altrettanta attenzione, se non di più.
«In qualche vecchia rivista o giornale», scrive Hawthorne, «ricordo d’avere letto la storia, riferita come vera, di un uomo, cui daremo il nome di Wakefield, il quale abbandonò per lungo tempo sua moglie. Questo fatto, così astrattamente enunciato, non è particolarmente insolito, e senza un’opportuna descrizione delle circostanze, non può essere giudicato crudele o insensato. Non di meno, anche se non il più grave, questo è forse il più strano caso registrato d’inadempienza dei doveri coniugali, nonché un singolare esempio tra quanti se ne possono trovare in tutti gli annali delle umane stravaganze. La coppia abitava a Londra, e l’uomo, con il pretesto di partire per un viaggio, prese alloggio in una strada vicina alla sua casa e lì, all’insaputa della moglie e degli amici, e senza un’ombra di motivo per questo volontario esilio, visse per più di vent’anni».
Wakefield ama il mistero. Gli piace far credere alla moglie d’avere segreti affari da sbrigare fuori città e, per il gusto di stupirla, di tanto in tanto s’assenta da casa, all’inizio forse soltanto per poche ore, poi per un giorno pieno, due giorni, tre, quattro, una settimana.
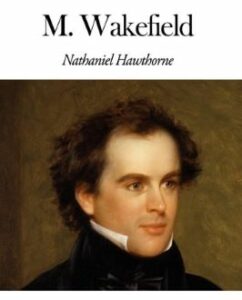 «Immaginiamo Wakefield mentre si congeda dalla moglie», continua Hawthorne. «È il crepuscolo di una sera d’ottobre, e lui indossa uno sbiadito cappotto, un cappello coperto di tela cerata, stivali alti, tiene un ombrello in una mano e una valigetta nell’altra. Ha informato sua moglie che deve prendere la diligenza della sera per la campagna. Lei vorrebbe informarsi sulla durata del viaggio, sul suo scopo e sulla probabile data del ritorno, ma rispettando la sua innocua passione per il mistero, si limita a interrogarlo con uno sguardo. Lui le dice di non aspettarlo con certezza al ritorno della diligenza e di non preoccuparsi se mai dovesse trattenersi fuori casa per tre o quattro giorni, ma di attenderlo in ogni caso per venerdì sera all’ora di cena. Si può pensare che nemmeno lo stesso Wakefield abbia ancora idea di ciò che accadrà. Le porge la mano, lei gli dà la sua, e si scambiano un bacio distratto come avviene dopo dieci anni di matrimonio, poi il signor Wakefield, un uomo di mezza età, se ne va, già quasi deciso a sconcertare la sua buona moglie con un’intera settimana d’assenza. Dopo che la porta si è chiusa alle sue spalle, lei si accorge che viene leggermente scostata, e attraverso lo spiraglio le appare il volto del marito, che le sorride e un attimo dopo scompare alla sua vista».
«Immaginiamo Wakefield mentre si congeda dalla moglie», continua Hawthorne. «È il crepuscolo di una sera d’ottobre, e lui indossa uno sbiadito cappotto, un cappello coperto di tela cerata, stivali alti, tiene un ombrello in una mano e una valigetta nell’altra. Ha informato sua moglie che deve prendere la diligenza della sera per la campagna. Lei vorrebbe informarsi sulla durata del viaggio, sul suo scopo e sulla probabile data del ritorno, ma rispettando la sua innocua passione per il mistero, si limita a interrogarlo con uno sguardo. Lui le dice di non aspettarlo con certezza al ritorno della diligenza e di non preoccuparsi se mai dovesse trattenersi fuori casa per tre o quattro giorni, ma di attenderlo in ogni caso per venerdì sera all’ora di cena. Si può pensare che nemmeno lo stesso Wakefield abbia ancora idea di ciò che accadrà. Le porge la mano, lei gli dà la sua, e si scambiano un bacio distratto come avviene dopo dieci anni di matrimonio, poi il signor Wakefield, un uomo di mezza età, se ne va, già quasi deciso a sconcertare la sua buona moglie con un’intera settimana d’assenza. Dopo che la porta si è chiusa alle sue spalle, lei si accorge che viene leggermente scostata, e attraverso lo spiraglio le appare il volto del marito, che le sorride e un attimo dopo scompare alla sua vista».
Alla fine, per averlo evidentemente fissato troppo a lungo, l’abisso ricambia il suo sguardo, e adesso eccolo lì, povero Wakefield, fuori al freddo, nel buio, trasformato in «fuorilegge dell’universo».
E Bartleby, intanto? Spalle all’ufficio, lo sguardo perso in qualche iperspazio oltre la finestra, la decisione di non fare niente di quel che gli viene chiesto, una dieta stretta di biscotti allo zenzero, «innocuo e passivo», Bartleby è con piena evidenza una variazione sul tema delle «umane stravaganze». Un semblable, un avatar di Wakefield. Sono fatti della stessa sostanza: l’amor vacui, o fascinazione del vuoto.
Bartleby è di New York, Wakefield un londinese, ma abitano sostanzialmente la stessa città, come Batman e Superman (Gotham City e Metropolis, le città dove operano separatamente i due supereroi, sono entrambe New York en travesti). Nichilista originario, primo della specie e protagonista di Delitto e castigo, Rodion Romanovič Raskol’nikov potrebbe essere un loro concittadino (e San Pietroburgo un’altra manifestazione della stessa «città premeditata» abitata da fantasmi metropolitani senza pace) se soltanto il giovane assassino non scrivesse libelli su Napoleone Übermensch, e non parlasse troppo.
Wakefield, per quanto ne indoviniamo, non parla con nessuno. Per dire cosa, poi? Stabilire un qualunque contatto umano potrebbe spingerlo a fuggire anche da questa sua seconda incomprensibile vita verso una terza e poi una quarta, all’infinito, col rischio d’aumentare la distanza tra sé e la sua vita originaria fino a smarrirne il senso e la memoria, esponendosi così «al terribile rischio di perdere il proprio posto per sempre». Quanto a Bartleby, «spiaggiato» come una balena (strano che Melville non ci abbia pensato) in un anonimo ufficio di Wall Street, una zona di New York che «ogni notte si spopola», di lui conosciamo una frase sola, eternamente ripetuta.
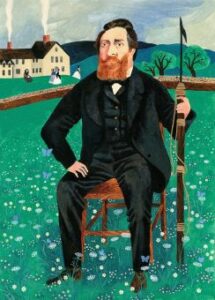 «Ricordai» – scrive Melville – «che Bartleby non parlava mai se non per rispondere; che sebbene avesse a volte considerevole tempo a sua disposizione, tuttavia non l’avevo mai visto leggere nulla, nemmeno un giornale; che trascorreva lunghi periodi di tempo presso la sua finestra dietro il paravento, a contemplare un desolato muro di mattoni. Non si recava mai in alcun refettorio o trattoria, e il suo volto pallido rivelava chiaramente che non beveva birra e neppure tè o caffè. Non mi risultava che andasse mai in nessun posto, non usciva mai a fare una passeggiata; si era sempre rifiutato di dirmi chi fosse, di dove venisse, se avesse parenti nel mondo; sebbene così magro e pallido, non si lamentava mai. Soprattutto ricordavo quella sua inconscia aria di pallida – come potrei dire? – di pallida alterigia, o meglio quell’austero riserbo, che lo circondava e con il quale era effettivamente riuscito a imporsi, obbligandomi a tollerare le sue eccentricità, tanto che ormai temevo di chiedergli di compiere il più insignificante lavoro, anche quando capivo dalla sua lunga immobilità che in quel momento, dietro il paravento, egli doveva essersi perduto in una di quelle sue fantasticherie,» lo sguardo sempre fisso sul «muro cieco» oltre la finestra.
«Ricordai» – scrive Melville – «che Bartleby non parlava mai se non per rispondere; che sebbene avesse a volte considerevole tempo a sua disposizione, tuttavia non l’avevo mai visto leggere nulla, nemmeno un giornale; che trascorreva lunghi periodi di tempo presso la sua finestra dietro il paravento, a contemplare un desolato muro di mattoni. Non si recava mai in alcun refettorio o trattoria, e il suo volto pallido rivelava chiaramente che non beveva birra e neppure tè o caffè. Non mi risultava che andasse mai in nessun posto, non usciva mai a fare una passeggiata; si era sempre rifiutato di dirmi chi fosse, di dove venisse, se avesse parenti nel mondo; sebbene così magro e pallido, non si lamentava mai. Soprattutto ricordavo quella sua inconscia aria di pallida – come potrei dire? – di pallida alterigia, o meglio quell’austero riserbo, che lo circondava e con il quale era effettivamente riuscito a imporsi, obbligandomi a tollerare le sue eccentricità, tanto che ormai temevo di chiedergli di compiere il più insignificante lavoro, anche quando capivo dalla sua lunga immobilità che in quel momento, dietro il paravento, egli doveva essersi perduto in una di quelle sue fantasticherie,» lo sguardo sempre fisso sul «muro cieco» oltre la finestra.
Bartleby preferiva di no.
Wakefield non era meno tormentato e storto d’anima.
Amico e per un po’ anche vicino di casa di Hawthorne, Melville conosceva bene l’opera dell’autore della Lettera Scarlatta. E Wakefield, tra tutti i personaggi di Hawthorne, doveva essergli apparso come una rivelazione, più dei fauni di marmo o delle bambine di neve. Melville – che aveva lanciato il Capitano Achab sulla pista del Leviatano: «Morte al mostro, morte a Moby Dick! Che Iddio dia la caccia a tutti noi, se non la diamo noi a Moby Dick fino alla morte!» – aveva un debole evidente per gli ossessi, e Wakefield era un perfetto esemplare della categoria. Con Bartleby, l’autore di Moby Dick intese certamente elevare a Wakefield un monumento. Indecifrabile quasi quanto il personaggio cui rendeva omaggio, era naturalmente un misterioso monumento.
Più che la statua equestre di Carlo Alberto di Savoia posta al centro della piazza delle bancarelle (dove avevo trovato la mia copia dei Racconti narrati due volte, nell’edizione Vallecchi del 1950, l’unica all’epoca in circolazione) il monumento eretto da Melville a Wakefield ricordava piuttosto il singolare monumento che Nikolaj Vasil’evič Gogol’ aveva eretto allo sventurato assessore di collegio Platon Kuz’mic Kovalëv: un Naso ribelle, in fuga dal corpo.
Perché è di fuggiaschi, naturalmente, che stiamo parlando.
Di fuggiaschi, e d’imperscrutabilità.
Come Wakefield, in fuga dal focolare domestico, che poi scruta di lontano, celato a ogni sguardo, anche Bartleby è un fuggiasco, però in piena vista. Se Bartleby è, come credo, il Naso di Wakefield, egli manifesta (diciamo così) la stessa sinusite. Qualcosa che lo soffoca, come qualcosa soffoca Wakefield. A una prima riflessione sembrerebbe che siano gli obblighi sociali a pesare come incubi sulle vite di questi oscuri eroi metafisici: Bartleby che rinuncia alla sua attività di copista e si vieta ogni proposito, Wakefield che si perde in una fantasia come in un bosco stregato. Dire che sono stati gli «obblighi sociali» (due parole al vento) a cacciarli in quell’angolo dal quale non sanno o non vogliono uscire è ribadire il gran mistero. Attenzione, però: se dire «obblighi sociali» è come dire niente, «dire niente» è un modo per affermare l’inconoscibile. Nel mondo di Bartleby e Wakefield, tutto si confonde, ogni cosa s’imbroglia. Qui chi è in fuga rimane immobile, come un ciclista in surplace, pronto a schizzar via, come i topi messicani dei cartoni animati.
Soffocati, in ogni modo.
Prima di tutto il panico, l’affanno.
 Soffocati come Charles Bronson e Steve McQueen nella Grande fuga di John Sturges (uno dei pochi film «semplicemente perfetti» degli anni sessanta) erano soffocati dal filo spinato che delimitava il lager nazista. Dal sentirsi soffocati a diventare icone immortali dell’evasione il passo è breve. Solženicyn, in Arcipelago Gulag, chiama queste icone «fuggiaschi convinti, uomini che sanno a cosa vanno incontro». Prendete «Georgij Tenno, al quale, negl’intervalli tra due evasioni non riuscite, i detenuti dicevano: “Perché non te ne stai un po’ fermo? Che bisogno hai di scappare? Cosa ci trovi nella libertà, specie al giorno d’oggi?” Tenno si stupiva. “Come cosa ci trovo? Ventiquattr’ore nella taiga senza catene! La libertà, ci trovo!”»
Soffocati come Charles Bronson e Steve McQueen nella Grande fuga di John Sturges (uno dei pochi film «semplicemente perfetti» degli anni sessanta) erano soffocati dal filo spinato che delimitava il lager nazista. Dal sentirsi soffocati a diventare icone immortali dell’evasione il passo è breve. Solženicyn, in Arcipelago Gulag, chiama queste icone «fuggiaschi convinti, uomini che sanno a cosa vanno incontro». Prendete «Georgij Tenno, al quale, negl’intervalli tra due evasioni non riuscite, i detenuti dicevano: “Perché non te ne stai un po’ fermo? Che bisogno hai di scappare? Cosa ci trovi nella libertà, specie al giorno d’oggi?” Tenno si stupiva. “Come cosa ci trovo? Ventiquattr’ore nella taiga senza catene! La libertà, ci trovo!”»
Può darsi, allora, che anche Bartleby e Wakefield, come Tenno in Arcipelago Gulag, si siano avventurati nella taiga: un bugigattolo a Wall Street, una falsa identità a pochi passi da casa, il primo indecifrabile, il secondo invisibile. «Niente catene», naturalmente, è dire troppo. Anche la taiga, a suo modo, è un lager, sia pure dall’orizzonte sgombro. Ma troppo sgombro: nessuno con cui parlare, le notti gelide, il silenzio, la fame, «el magun» (come diceva Alberto Sordi vigile urbano in Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo di Mauro Bolognini, Anno del Signore 1956).
Be’, tiriamo le fila.
Prima (o dopo) mi capitò di leggere Wakefield e solo dopo (o prima) Bartleby lo scrivano, quest’ultimo in un’edizione sciccosa, un libro da nababbi: Billy Budd e altri racconti, nella collana dei Millenni, Einaudi chic. Chissà dove, in uno scaffale in alto, fuori mano, devo averlo ancora, sempre che non l’abbia prestato a qualcuno trenta o quarant’anni fa. Libri così erano le avventure che capitavano ai lettori compulsivi in fuga ontologica (cioè in caccia di ciò che è reale) nella taiga di Piazza Carlo Alberto.
C’erano altre botteghe di libri usati in giro per la città. Per esempio Corso Siccardi, un vialetto alberato a lato di Via Cernaia, sulla strada per la stazione di Porta Susa. C’era soprattutto la Casa del Libro (ma per tutti l’«Ebreo») nella Galleria Subalpina, un «passage» severo e signorile, anzi elitario, al centro una fioriera, che congiungeva Piazza Carlo Alberto e Piazza Castello. Però nulla di paragonabile alle bancarelle di Piazza Carlo Alberto, che alla fine dei settanta sarebbero state trasferite sotto i portici di Via Po, due o tre isolati più in là, perdendo per strada un po’ della loro magia», come si dice con espressione orribile ma veritiera (o meglio «oggettiva», come si cominciava a dire, con espressione più orribile ancora, nelle assemblee studentesche). Anche Corso Siccardi è stato smantellato. Niente più bancarelle: panchine. C’era un’edicola: sparita anche quella. Quanto all’«Ebreo», nessuno lo chiama più così, e in vetrina ci sono sempre meno libri e sempre più stampe, monete, cartoline.
Erano tempi strani.
In giro per libri usati un ragazzino poteva scoprire Bartleby e Wakefield senza cercarli e senza averne mai saputo niente prima. Per bandiera un grande ignoramus, poche lire in tasca, e ci si poteva imbattere in queste star della grande letteratura come si trova una sorpresa nell’uovo di Pasqua. Per bancarellari e consumatori all’ingrosso di libri usati la seconda metà degli anni sessanta è stata un’epoca senza eguali. Furono i libri, soprattutto usati, per il loro basso costo e la loro vasta circolazione, a provocare l’evento clou del decennio: il Sessantotto, con rispetto parlando.
Gli studenti in tumulto, prima che motivati dall’ideologia e dalle congiunture politiche, erano sotto incantesimo letterario, come Madame Bovary e Don Chisciotte. Ogni libro letto o sfogliato era un invito all’avventura: giganti da abbattere, fanciulle da salvare. Erano finestre di Magritte aperte su universi paralleli. Alcuni di questi inconoscibili, nebbiosi, tipo gli uffici legali di Wall Street, o le strade londinesi percorse da Wakefield in stretto incognito, dove sembravano brillare altre stelle nel cielo sopra di noi e palpitare altre leggi morali dentro di noi. Fumetti, libri usati, Linus, i primi tascabili: fu questo il vento che gonfiò le vele dei movimenti giovanili, presto messi in caricatura dalle passioni politiche.
E Wakefield, che «aveva sfidato l’ordine del mondo»? Wakefield scopre che «gli individui sono così ben adattati a un sistema, e i sistemi l’uno all’altro, e a tutto un insieme, che un uomo, se si fa da parte per un solo momento» può finire in un’altra dimensione, nella «zona fantasma» dove i tribunali di Krypton, per citare di nuovo Superman, confinavano i criminali (al confronto, il 41 bis è Parigi in primavera). Fortunatamente, alla fine della storia, Wakefield ritrova la strada di casa, smarrita decenni prima.
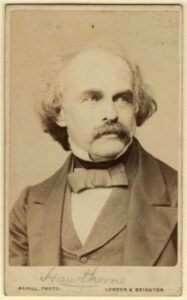 «Sale i gradini con passo pesante» – scrive Hawthorne – «perché vent’anni gli hanno rattrappito le gambe, da quando li ha scesi l’ultima volta, anche se lui non se ne rende conto. Fermati, Wakefield! Se vuoi proprio andare nella sola dimora che ti è rimasta, calati piuttosto tua tomba! Ma la porta si apre, e mentre lui ne varca la soglia diamo un ultimo sguardo di commiato al suo volto e riconosciamo quel furbesco sorriso che aveva anticipato l’innocente burla che egli ha continuato a giocare ai danni della moglie. Come ha imbrogliato quella povera donna! Be’, auguriamo a Wakefield una buona notte di riposo!»
«Sale i gradini con passo pesante» – scrive Hawthorne – «perché vent’anni gli hanno rattrappito le gambe, da quando li ha scesi l’ultima volta, anche se lui non se ne rende conto. Fermati, Wakefield! Se vuoi proprio andare nella sola dimora che ti è rimasta, calati piuttosto tua tomba! Ma la porta si apre, e mentre lui ne varca la soglia diamo un ultimo sguardo di commiato al suo volto e riconosciamo quel furbesco sorriso che aveva anticipato l’innocente burla che egli ha continuato a giocare ai danni della moglie. Come ha imbrogliato quella povera donna! Be’, auguriamo a Wakefield una buona notte di riposo!»
E Bartleby? Che fine fa lo scrivano? Muore. O meglio chiude gli occhi, stremato, consunto, e «dorme, con i re e i consiglieri», come mormora il suo principale, mentre qualche velo del suo passato pare squarciarsi.
«Eppure» – conclude Melville – «a questo punto sono incerto se divulgare l’eco di una diceria che giunse al mio orecchio alcuni mesi dopo la morte dello scrivano. Su quali basi poggiasse non sono mai riuscito ad accertare; quindi, non sono in grado di dire quanto ci sia di vero. Ne farò qui un breve cenno: Bartleby era un impiegato subalterno nell’ufficio delle lettere smarrite a Washington, dal quale era stato all’improvviso licenziato per un cambiamento nell’amministrazione. Quando penso a questa diceria, a fatica riesco a esprimere le emozioni che mi pervadono. Lettere smarrite, lettere morte! Non suona come “uomini morti”? Pensate a un uomo incline alla disperazione: esiste un lavoro più adatto ad accentuarla che maneggiare lettere morte e metterle in ordine per darle alle fiamme? Ogni anno ne vengono bruciate a carrettate. Qualche volta il pallido impiegato estrae dalla busta un anello e il dito al quale era destinato forse imputridisce nella tomba. Spunta la banconota inviata in un moto di pronta carità e colui che ne avrebbe tratto sollievo non mangia né soffre più la fame. Parole di speranza per quanti morirono disperati, o di perdono per coloro che morirono nello sconforto; buone nuove per coloro che morirono soffocati da sventure inconsolabili. Apportatrici di vita, queste lettere», scrive Melville «rovinano verso la morte».
Sia da Wakefield che da Bartleby sono stati tratti dei film (cercateli su Wikipedia, o meglio ancora su IMBD, l’Internet Movie Database). Intanto che scrivevo questo capitolo, li ho scaricati, ma ancora non ho avuto cuore di vederli. Bartleby, diretto e interpretato da Maurice Ronet nel 1978, è ambientato a Parigi, nonché recitato in abiti moderni. Anche Wakefield (Robin Swicord, 2016) è in abiti moderni. Un giorno o l’altro, tempo avanzandomi, forse li guarderò.
Intanto, evocato Raskol’nikov, l’Ur-nichilista, che ha fatto da modello a delinquenti pallidi e mostri morali, anche lui in fuga nella taiga della nascente cultura pop, mi torna in mente un altro fuggiasco convinto: Joe Doppelberg, protagonista di What Mad Universe, il cult fantascientifico di Fredric Brown. È il 1948, e Joe Doppelberg, giovanissimo nerd, sogna un mondo in cui è Salvador Dalí a popolare di mostri alieni e ragazze in minigonna le copertine delle riviste di fantascienza. Fellini avrebbe voluto cavarne un film. Ne girò di più strani. Nessuno, però, sarebbe stato più estraniante.
O Doppelberg! O umanità!
