di Diego Gabutti
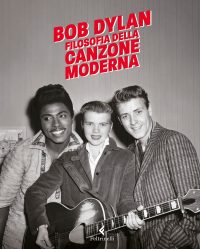 Bob Dylan, Filosofia della canzone moderna, Feltrinelli, Milano 2022, pp. 352, 39,00 euro, eBook 16,99 euro
Bob Dylan, Filosofia della canzone moderna, Feltrinelli, Milano 2022, pp. 352, 39,00 euro, eBook 16,99 euro
Premio Nobel per la letteratura nel 2016, Premio Pulitzer nel 2008, Bob Dylan è il campione di quel particolare genere letterario che, come le canzonette di cui esplora enigmi e meraviglie nella sua Filosofia della canzone moderna, «parla all’orecchio e non all’occhio».
È una letteratura moderna e post, che non va giudicata da quel che dice ma da come lo dice, da chi lo dice – e dove lo dice, e quando. Non è fissata una volta per sempre sulla carta né incisa una volta per tutte su una frittella di vinile o su un’impalpabile traccia mp3. Un autore, come fa lo stesso Dylan con i suoi vecchi hit, può decidere di rivisitare le sue composizioni più leggendarie, da “Maggie’s Farm” a “Like a Rolling Stone”, fino a renderle irriconoscibili. Versioni ritenute perfette di canzoni classiche possono essere riverniciate dalle cover, come ha fatto sempre Dylan con gli evergreen di Frank Sinatra (da Young at Heart a On a Little Street in Singapore, in uno dei suoi ultimi album, Fallen Angels, del 2016) e come hanno fatto con i suoi hit innumerevoli musicisti e band. E mica soltanto Ricky Nelson, i Byrds, Jimi Hendrix, Johnny Cash, Elvis Presley, Manfred Mann, The Band e Brian Ferry, ma anche De Gregori, i Nomadi, De Andrè, i Dik Dik, gli Articolo 31 e persino Adriano Pappalardo, Bobby Solo, Don Backy, Ricky Gianco. Dylan riconfigura, con le sue canzoni, l’intera scena musicale, da un punto cardinale all’altro, come poi dirà Robbie Robertson, il leader della Band, il gruppo con il quale Dylan incide nel 1967 i Basement Tapes, 100 incisioni senza eguali, l’equivalente rock’n’roll della Recherche proustiana.
Brada – senza mordacchia né fissa dimora, «no direction home» – la canzonetta è stata la colonna sonora del Novecento, da un capo all’altro. Prima, nella storia universale, non era mai successo niente di paragonabile. Salvo forse Omero, quando cantò la guerra dei dieci anni sotto le mura d’Ilio accompagnandosi con la lira e il tamburello, mai nessuno aveva messo la storia in musica, giorno per giorno, come nel secolo breve.
Oltre che uno di questi menestrelli, autore e interprete di canzoni immortali, Dylan è anche l’archivista di questo immane repertorio musicale, come dimostrano questo libro, il primo dopo Chronicles, del 2005, e la sua passione per le cover (che nel 1970, quando fece uscire Self Portrait, il suo primo album di canzonette per lo più altrui, destò scandalo tra i fan). Filosofia della canzone moderna è il catalogo ragionato degli Zip-A-Dee-Doo-Dah del Novecento. Ogni scheda è un’orecchia nelle pagine delle guerre mondiali, della guerra fredda, dei rari periodi di pace. Mancano le canzoni fuori gara, che non hanno bisogno d’essere richiamate alla memoria, o d’essere spiegate: le canzoni di Dylan, di Lennon-McCartney. Ma per il resto c’è dentro l’essenziale: il pop, il country, il folk, il rock’n’roll. Ogni scheda è un pezzo di bravura: una cover per l’occhio e non per l’orecchio.
C’è Volare di Domenico Modugno, per esempio, «una canzone che s’avvicina, sfreccia, continua per la sua strada procedendo a piena velocità, si schianta nel sole, rimbalza sulle stelle, esala in una nuvola di fumo come un sogno impossibile e va a esplodere dritta nel Paese delle meraviglie. È singolare e resta sospesa a mezz’aria». Modugno: «Già il suono del suo nome crea la sua propria canzone. […] È una seduzione in lingua italiana che comincia con una piccola, sognante introduzione pianistica seguita dalla voce di Domenico avvolta dall’organo prima che il ben noto inciso del titolo faccia irruzione». Cantare oh oh. / Volare oh oh oh. Se la canti, «passi rombando come una cometa, sei in fuga verso le stelle. Sarai magari pazzo ma non sei un imbecille».
C’è Blue Moon nella straordinaria versione di Dean Martin (ma al confronto, la versione di Dylan in Self Portrait non sfigura). Blue Moon: «Il suo fascino sta nel suo mistero. È una melodia che sembra uscita da Debussy. Dal nulla, una forma ti appare davanti. Ti volti, la luna ha cambiato colore, e adesso è d’oro. Quand’è stata l’ultima volta che hai visto una luna dorata? È una canzone che non ha senso, la bellezza sta nella melodia». Cantate da Dino, «le canzoni – anche Blue Moon – iniziano e dopo il ritornello vanno alla deriva, interrotte da barzellette e battute. “A Frank non piacciono quelli che parlano durante gli spettacoli. A me non importa se parlate durante il mio spettacolo. Per quello che mi riguarda potete anche giocare a bowling”. Dino è divertente, tenero, e sbronzo». «Frank», naturalmente, è Frank Sinatra. Di lui «è stato detto», scrive Dylan, «che era un teppista che quando cantava si trasformava in poeta».
Strangers in the Night: «Vagabondi e anticonformisti, oggetti di affetto reciproco, rapiti l’uno dall’altro e stretti in un’alleanza da loro stessi creata, ignari di tutte le età dell’uomo, l’età dell’oro, l’età elettronica, l’età dell’angoscia, l’età del jazz». E «Frank», che la cantò, era «qui per raccontare una storia diversa, il suo piumaggio diverso da quello degli altri uccelli». Un fatto incredibile: «La classifica delle prime cento canzoni, pubblicata il 2 luglio 1966 su “Billboard”, era dominata da quella piccola pop song. Pazzesco: nel bel mezzo dell’invasione britannica, Strangers in the Night dell’uomo venuto da Hoboken batteva Paperback Writer dei Beatles e Paint It Black degli Stones. Frank doveva far vedere a tutti chi era il padrone, anche se Strangers era una canzone che odiava e regolarmente liquidava come “un pezzo di merda”. Del resto, non dimentichiamo che Howlin’ Wolf una volta disse la stessa cosa della sua prima chitarra elettrica e che i fratelli Chess misero quelle parole a caratteri cubitali su una delle copertine dei loro album».
Ci sono le canzoni western, come El Paso e Jesse James, quest’ultima un classico pezzo folk americano inciso cent’anni fa da Harry McClintock (attore e poeta, nonché vicesceriffo a San Francisco e attivista sindacale nei ranghi degli IWW, gl’Industrial Workers of the World). Jesse James è stata rilanciata in tempi recenti da Bruce Springsteen: Jesse James era un ragazzo / che uccise molti uomini. / Rapinò il treno di Glendale./Rubava ai ricchi e dava ai poveri. «Ai tempi in cui Jesse s’aggirava per le campagne», scrive Dylan, «essere un fuorilegge era pericoloso. Voleva dire che qualunque cittadino poteva spararti legalmente, ucciderti a bruciapelo e riscuotere la taglia. Un fuorilegge doveva rendersi irriconoscibile, imparare a nascondersi in pieno giorno perché chiunque poteva sparargli, per strada. In effetti, è quello che accadde a Jesse James». Una storia, quella dei fuorilegge prodighi, che «si è estesa fino agli anni trenta con Pretty Boy Floyd, Bonnie e Clyde, la banda di Ma Barker. In quei giorni, se la tua faccia era esposta in un manifesto che diceva Wanted o in un ufficio postale, chiunque poteva spararti. Bisognava stare molto attenti». Fuorilegge e galeotti popolano anche le canzoni di Dylan: l’album John Wesley Harding, e poi (citandone solo alcune) Hurricane, Romance in Durango, George Jackson e la colonna sonora di Pat Garrett & Billy the Kid, il western di Sam Peckinpah, del 1973, dove Dylan figura anche come attore nella parte di Alias, uno dei bandidos di Fort Sumner.
 C’è qualcosa del fuorilegge, qualcosa di borderline in ogni icona rock. Prendete Elvis Presley, che «quando ha inciso Blue Moon of Kentucky ha fatto quello che aveva già fatto con Mystery Train. L’ha truccata come un motore. Ha preso canzoni dal ritmo moderato come Blue Moon of Kentucky, Mystery Train e perfino Good Rockin’ Tonight e le ha ridotte all’osso per poi accelerarle. Che è la ragione per cui è stato chiamato “il cantante a propulsione nucleare”. L’energia nucleare stava venendo di moda ed Elvis navigava sulla cresta dell’onda». C’è qualcosa del fuorilegge, nei rockers e negli eroi americani. E qualcosa, anche, che c’entra con l’ingordigia, l’avidità, con la brama di ricchezze: «Vorrei avere cinque centesimi per ogni canzone che conosco e che parla di denaro, da Sarah Vaughan che canta di penny che cadono dal cielo a Buddy Guy che grida il suo blues per un biglietto da cento dollari. Se ti piace il verde delle banconote, Ray Charles ha una canzone e i New Lost City Ramblers ne hanno un’altra. Berry Gordy ha costruito la Motown sul denaro, i Louvin Brothers volevano contanti sull’unghia e Diddy sapeva che era tutta una questione di centoni. Charlie Rich cantava Easy Money, Eddy Money cantava Million Dollar Girl e Johnny Cash poteva cantare qualunque cosa».
C’è qualcosa del fuorilegge, qualcosa di borderline in ogni icona rock. Prendete Elvis Presley, che «quando ha inciso Blue Moon of Kentucky ha fatto quello che aveva già fatto con Mystery Train. L’ha truccata come un motore. Ha preso canzoni dal ritmo moderato come Blue Moon of Kentucky, Mystery Train e perfino Good Rockin’ Tonight e le ha ridotte all’osso per poi accelerarle. Che è la ragione per cui è stato chiamato “il cantante a propulsione nucleare”. L’energia nucleare stava venendo di moda ed Elvis navigava sulla cresta dell’onda». C’è qualcosa del fuorilegge, nei rockers e negli eroi americani. E qualcosa, anche, che c’entra con l’ingordigia, l’avidità, con la brama di ricchezze: «Vorrei avere cinque centesimi per ogni canzone che conosco e che parla di denaro, da Sarah Vaughan che canta di penny che cadono dal cielo a Buddy Guy che grida il suo blues per un biglietto da cento dollari. Se ti piace il verde delle banconote, Ray Charles ha una canzone e i New Lost City Ramblers ne hanno un’altra. Berry Gordy ha costruito la Motown sul denaro, i Louvin Brothers volevano contanti sull’unghia e Diddy sapeva che era tutta una questione di centoni. Charlie Rich cantava Easy Money, Eddy Money cantava Million Dollar Girl e Johnny Cash poteva cantare qualunque cosa».
C’è una speciale, impassibile filosofia pratica nelle canzonette, spiega Dylan quando canta e quando scrive o parla di musica pop: «Dischi di musica soul, come lo hillbilly, il blues, il calipso, Cajun, polka, salsa e altre forme di musica indigena, contengono spesso la stessa saggezza che le classi superiori ricevono all’università. La cosiddetta “scuola della strada” è una cosa che esiste davvero e non serve soltanto a imparare a stare alla larga da arraffoni e ciarlatani». Qualcosa s’impara sempre da quel che s’ascolta con lo smartphone o che si canticchia, pensierosi, sotto la doccia: «Mentre i laureati della Ivy League parlano d’amore in una sfilza di quartine soffuse di qualità astratte e attributi impalpabili, la gente – che abiti a Trinidad o ad Atlanta – canta dei vantaggi di avere per moglie una donna poco attraente e delle altre pure e semplici verità della vita».
Schede, appunti, note a margine, riletture (e rifischiettature) tra accademia e poesia, da Perry Como a Jerry Garcia, dai Clash a Ricky Nelson, dai Who ai Platters, da Bobby Darin a Vic Damone, da Bing Crosby a Roy Orbison… ma in Filosofia della canzone moderna (che è il libro d’un Nobel, e si vede) non c’è in ballo una sola Musa, quella della musica. C’è dentro tutto il pop: cinema, fumetti, serie tv, mode, droghe, beat generation, buoni e cattivi maestri. Dylan spazia da Mezzogiorno di fuoco a Mack The Knife dell’Opera da tre soldi, da Nick Mano Fredda a Leigh Brackett, sceneggiatrice del Grande sonno e di Rio Bravo, oltre che grande scrittrice di fantascienza (La danzatrice di Ganimede, La spada di Rhiannon). Tutto si tiene, tutto s’intreccia, e il mistero è che, da quest’amalgama riccamente illustrato di pulp, film e canzonette, non salta fuori una pagina chic della cultura ma una mappa fedele – zero bellurie, nessuna caramellosità – della condizione umana.
