di Emilio Quadrelli
 “Scienza operaia” e “piano del capitale”
“Scienza operaia” e “piano del capitale”
Lenin identificò, senza mezze misure, il riformismo come forza del tutto interna al capitale e, pertanto, come forma politica completamente ascrivibile all’ambito della inimicizia. Questo cardine della teoria leniniana anima per intero le pagine de “La classe” anzi, per molti versi, il giornale sviluppa e porta sino alle sue logiche conseguenze la teoria leniniana. La battaglia contro il riformismo e gli istituti del movimento operaio ufficiale non solo albeggiano pressoché in ogni articolo del giornale, ma il riformismo è osservato non tanto come linea politica che annacqua le lotte e le fa regredire ma come linea politica tutta interna al piano del capitale . Esattamente in questo passaggio si situa gran parte della ricchezza prima teorica e analitica e poi organizzativa del giornale. Il riformismo è osservato e identificato come progetto e strategia tutta interna al capitale, come suo centrale modello di sviluppo e principale governo della forza lavoro.
Se Lenin aveva identificato il riformismo come la borghesia dentro il movimento operaio, l’operaismo de “La classe” identifica il riformismo come parte costitutiva e costituente del piano del capitale , tutto questo sulla scia di quanto messo a punto nel lavorio teorico delle esperienze precedenti ma, soprattutto, grazie anche alle esperienze poste in atto dalle lotte operaie in aperta rottura con partito e sindacato. Qualche anno dopo, avendo a mente il ruolo del PCI e del sindacato nelle vicende degli anni settanta, tutto ciò potrà sembrare come la scoperta dell’acqua calda ma, negli anni sessanta, questo è un passaggio teorico di grandissima portata poiché, per la prima volta, ascrive il riformismo alla strategia materiale del capitale1. Mentre i gruppi critici, ma ortodossi, pongono l’accento sul revisionismo del movimento operaio ufficiale, “La classe” e tutte le aree teoriche e politiche a questa contigua focalizzano l’attenzione proprio sul riformismo; per gli ortodossi, infatti, la colpa del movimento operaio ufficiale è quella di aver abbandonato la dottrina e aver introdotto una nuova liturgia poco attenta al verbo presente nei testi sacri. A partire da questi presupposti, pertanto, il riformismo diventerebbe solo la conseguenza fenomenologica di una revisione ideologica e non una pratica del tutto interna al piano del capitale. In ciò che “La classe” elabora vi è, invece, un decisivo passaggio qualitativo dentro la ritraduzione di Lenin. Una ritraduzione che va sicuramente oltre Lenin poiché sviluppa un’analisi del riformismo a partire dai processi materiali interni al ciclo di accumulazione capitalista. Il merito enorme de “La classe”, e dell’operaismo in generale, o almeno di questo operaismo, è quello di aver letto il riformismo dentro la fabbrica e averlo osservato come motore principale del processo produttivo e del suo sviluppo.
 “La classe” va oltre Lenin perché il capitale è andato oltre la forma fenomenica conosciuta da Lenin il quale, per forza di cose, non poteva certo fare i conti con l’epopea dello stato–piano2 e di tutto ciò che questo ha comportato. La critica di Lenin al riformismo è una critica tutta politica nel senso che a incarnare il riformismo sono quegli strati, la cosiddetta aristocrazia operaia, che dentro il sistema capitalista hanno trovato una sistemazione sostanzialmente confortevole poiché possono usufruire di una quota del surplus di profitto che il proprio imperialismo rastrella in giro per il mondo. In questo senso il riformismo può essere considerato come una tattica del capitale non una strategia ovvero una alleanza tra classi che condividono alcuni interessi in comune e, soprattutto, hanno il medesimo nemico: lo spettro comunista. In questa alleanza, tuttavia, i ruoli rimangono ben distinti.
“La classe” va oltre Lenin perché il capitale è andato oltre la forma fenomenica conosciuta da Lenin il quale, per forza di cose, non poteva certo fare i conti con l’epopea dello stato–piano2 e di tutto ciò che questo ha comportato. La critica di Lenin al riformismo è una critica tutta politica nel senso che a incarnare il riformismo sono quegli strati, la cosiddetta aristocrazia operaia, che dentro il sistema capitalista hanno trovato una sistemazione sostanzialmente confortevole poiché possono usufruire di una quota del surplus di profitto che il proprio imperialismo rastrella in giro per il mondo. In questo senso il riformismo può essere considerato come una tattica del capitale non una strategia ovvero una alleanza tra classi che condividono alcuni interessi in comune e, soprattutto, hanno il medesimo nemico: lo spettro comunista. In questa alleanza, tuttavia, i ruoli rimangono ben distinti.
Diverso, invece, il ruolo che il riformismo inizia a ricoprire nel nuovo ciclo di accumulazione: qui il riformismo si fa strategia del capitale poiché sua preoccupazione essenziale è il governo della forza lavoro e la totale compatibilità di questa con il ciclo produttivo. Con ciò il sindacato e gli istituti del movimento operaio diventano, da mediatori della forza lavoro, gestori e controllori di questa, ma non solo: gli istituti del movimento operaio ufficiale diventano parte integrante del piano. Se l’aristocrazia operaia di Lenin era quella forza deputata, di fronte all’attacco operaio, a puntellare il sistema capitalista, oggi questa, che più sensatamente inizierà a essere individuata come destra operaia, è chiamata a gestire il piano dell’accumulazione e lo scontro con questa, per tanto non potrà che essere una battaglia all’ultimo sangue perché in palio vi è la sopravvivenza o meno del capitalismo e non per caso, le lotte operaie, troveranno davanti a sé, ancora prima che padroni e polizia, gli istituti del movimento operaio ufficiale.
Quando, negli anni settanta, il riformismo svolgerà appieno il ruolo di nuova polizia, non farà altro che completare, entrando a pieno titolo negli apparati della statualità, quel percorso iniziato negli anni sessanta che lo vedeva tutto interno alla materialità del piano del capitale. Questo passaggio è centrale nell’elaborazione de “La classe” e non si tratta certo di cosa di poco conto ma, per molti versi, si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana. È vero Lenin, sin dalla pubblicazione del Che fare? aveva individuato nell’economicismo la politica borghese dentro la classe operaia ma in ciò che viene messo a registro adesso vi è qualcosa di diverso. Qui non si tratta più di leggere una politica borghese che viene portata dentro la classe per limitarne prima e annichilire poi le sue prospettive politiche rivoluzionarie ma di una lettura, tutta materialistica, delle trasformazioni intervenute dentro al capitale. La critica de “La classe” agli istituti del movimento operaio ufficiale ha ben poco di “ideologico” e/o di “politico” ma affonda le sue radici dentro i processi materiali del capitalismo. Parafrasando Marx si può dire che è una critica che non nasce nel cielo delle idee bensì dentro gli inferi della fabbrica. Ma questo cosa significa? Perché ciò rappresenta sia una svolta che manda in frantumi tutto il politicismo proprio del PCI e dei suoi critici e, per altro verso, riporta Lenin dentro la classe operaia? Perché in questo passaggio riaffiora prepotentemente l’attualità della rivoluzione? Non sono certo domande di poco conto alle quali occorre cercare di offrire qualche risposta.
Intanto, per prima cosa, significa riprendere tra le mani la teoria marxiana in quanto critica dell’economia politica. Il punto di partenza della teoria marxiana, il suo cantiere elaborativo è l’inferno di Manchester, non il mondo celestiale della politica ma il sordido rumore delle macchine capitaliste. Quell’inferno, che sembra essere circoscritto alla sola Manchester, segnerà tutto il mondo a seguire. Ciò che Marx osserva, attorniato dallo scetticismo dei più, è il processo materiale che in quel luogo si sta evolvendo e che darà il la al mercato mondiale. Questo è il punto più alto dello sviluppo e questo segnerà, piegandolo a sé, i destini del mondo. Ma Marx non si limita a ciò poiché, insieme all’economia politica, cosa che lo accomunerebbe ai tanti economisti dell’epoca, focalizza lo sguardo sul soggetto deputato a rivestire i panni della critica alla economia politica.
Contro la scienza degli economisti Marx mette a punto la scienza operaia. Questa è la scienza delle lotte ed è una cultura che affonda le sue radici dentro la costituzione materiale che il ciclo dell’accumulazione impone. Il giornale “La classe” si colloca esattamente dentro questa scia dove non gli equilibri di governo, non le schermaglie parlamentari e tanto meno le percentuali elettorali e le rappresentanze effimere che stabiliscono, hanno importanza ma le lotte, la quantità e la qualità di forza che queste sono in grado esercitare. Centrale è il punto di vista operaio e non un punto di vista dal sapore sociologico come piace registrare ai cani da guardia della borghesia, ma il punto di vista politico degli operai, quello, cioè, che si manifesta solo dentro le lotte autonome e qui, allora, vi è per intero la ritraduzione di Lenin da parte de “La classe”. Sulle lotte, di fabbrica e di strada, Lenin aveva costruito il partito dell’insurrezione, sulle lotte di fabbrica del presente e il loro riversarsi nei quartieri proletari va costruita l’organizzazione operaia. Ma non si pone, allora, nuovamente l’attualità della rivoluzione e non occorre forse comprendere in che modo questa attualità si presenta? Questo è ciò che sta al centro e al cuore dell’esperienza de “La classe”.
 Certo questo non è la scoperta di qualche intellettuale, non è la teoria messa a punto da un ceto politico particolarmente arguto bensì la sintesi concettuale di ciò che una prassi di massa ha ormai evidenziato. Le avanguardie, il ceto politico–intellettuale non si inventano nulla ma decodificano, sostanziano e rielaborano ciò che la lotta di massa ha già, e non più solo come tendenza, posto in atto. La crisi del PCI e del sindacato in fabbrica non è altro che l’espressione fenomenica della lotta operaia. Ai rappresentanti del lavoro salariato gli operai contrappongono il rifiuto del lavoro salariato. Questo fa saltare il banco del riformismo. “La classe” si limita a registrare prima e a rilanciare poi, attraverso una attenta elaborazione teorica, ciò che dalle masse è stato conquistato. È sicuramente un Lenin inaspettato e anomalo quello che prende forma dalle pagine di questo giornale, ma è anche l’unico Lenin possibile: è di nuovo l’attualità della rivoluzione, la riscoperta e la riappropriazione del tempo della rivoluzione contro i ritmi e i tempi del capitale.
Certo questo non è la scoperta di qualche intellettuale, non è la teoria messa a punto da un ceto politico particolarmente arguto bensì la sintesi concettuale di ciò che una prassi di massa ha ormai evidenziato. Le avanguardie, il ceto politico–intellettuale non si inventano nulla ma decodificano, sostanziano e rielaborano ciò che la lotta di massa ha già, e non più solo come tendenza, posto in atto. La crisi del PCI e del sindacato in fabbrica non è altro che l’espressione fenomenica della lotta operaia. Ai rappresentanti del lavoro salariato gli operai contrappongono il rifiuto del lavoro salariato. Questo fa saltare il banco del riformismo. “La classe” si limita a registrare prima e a rilanciare poi, attraverso una attenta elaborazione teorica, ciò che dalle masse è stato conquistato. È sicuramente un Lenin inaspettato e anomalo quello che prende forma dalle pagine di questo giornale, ma è anche l’unico Lenin possibile: è di nuovo l’attualità della rivoluzione, la riscoperta e la riappropriazione del tempo della rivoluzione contro i ritmi e i tempi del capitale.
Il tempo operaio è il tempo non declinato sulla produzione ma sulla lotta; è il tempo della soggettività di classe contrapposto al tempo oggettivista della produzione. Il sabotaggio si contrappone ai ritmi produttivi, lo sciopero a gatto selvaggio è il modo migliore per ottenere il massimo dalla lotta con il minimo sforzo e bloccare la produzione impiegando, volta per volta, modesti plotoni operai; una rivisitazione, a conti fatti, della guerra del deserto all’interno della macchina capitalista3.
Lo sciopero improvviso di un solo comparto della fabbrica, che blocca, però, per intero il ciclo di assemblaggio della merce, equivale a quelle mille punture di insetto attraverso le quali un piccolo esercito guerrigliero è in grado di piegare e far implodere anche il più poderoso degli eserciti statuali. Allo stesso tempo l’agguato ai capi, lo spazzare via i reparti con improvvisati cortei mascherati e illegali è un modo per liberare e appropriarsi di pezzi di territorio dentro la fabbrica negando a spie, ruffiani e crumiri un qualunque diritto di cittadinanza. Questa è la guerra che ormai si va delineando dentro la fabbrica e che sancisce l’esistenza di un dualismo di potere.
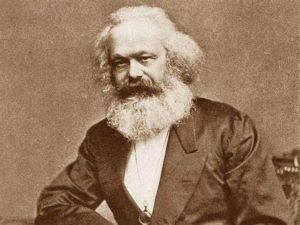 Dualismo di potere, appunto, non lotta sindacale ancorché particolarmente aspra, scontro tutto politico non economico o economicista come, con fare saccente, lo definiscono le varie anime della ortodossia comunista allineandosi in tutto e per tutto al PCI. Gli operai non liberano la fabbrica, non si impossessano della produzione ma, sabotando il lavoro, si riappropriano del tempo, ma liberare il tempo dalla produzione non era stata una delle principali indicazioni di Marx sin dal periodo dei Manoscritti?4. Questo il perimetro della guerra che si va delineano tra classe operaia e comando capitalista, non il mito neo-resistenziale tutto declinato nell’immaginario del passato, ma la guerra dentro il presente incarnato dalla fabbrica fordista ed è esattamente qui che Lenin va ritradotto e attualizzato. Ma il riappropriarsi della teoria leniniana non si limita a ciò. Torniamo quindi a Lenin, a osservarne le peculiarità e la sua nuova traduzione che le lotte operaie impongono.
Dualismo di potere, appunto, non lotta sindacale ancorché particolarmente aspra, scontro tutto politico non economico o economicista come, con fare saccente, lo definiscono le varie anime della ortodossia comunista allineandosi in tutto e per tutto al PCI. Gli operai non liberano la fabbrica, non si impossessano della produzione ma, sabotando il lavoro, si riappropriano del tempo, ma liberare il tempo dalla produzione non era stata una delle principali indicazioni di Marx sin dal periodo dei Manoscritti?4. Questo il perimetro della guerra che si va delineano tra classe operaia e comando capitalista, non il mito neo-resistenziale tutto declinato nell’immaginario del passato, ma la guerra dentro il presente incarnato dalla fabbrica fordista ed è esattamente qui che Lenin va ritradotto e attualizzato. Ma il riappropriarsi della teoria leniniana non si limita a ciò. Torniamo quindi a Lenin, a osservarne le peculiarità e la sua nuova traduzione che le lotte operaie impongono.
Al centro della sua teoria politica vi è la relazione indissolubile tra politica e guerra5, tanto che non è certo un caso che Clausewitz sia uno degli autori da lui maggiormente studiati, la cui conseguenza pratica immediata è la relazione indissolubile tra legalità e illegalità. Due aspetti che non possono che essere costantemente complementari. Mentre per la socialdemocrazia occidentale legalità e illegalità rimandano a momenti e a contesti del tutto incommensurabili per Lenin, che comprende sino in fondo come la guerra sia compresa nella politica, legalità e illegalità sono due aspetti sempre attuali e presenti. Centrale nel conflitto di classe è comunque e sempre la questione della forza.
Ma la forza, aspetto centrale della modernità, è diventata monopolio dello stato6. Solo lo stato è legittimato a detenerla e usarla ma lo stato è quella macchina burocratica e militare deputata a esercitare e garantire una dominazione di classe, la forza, quindi, non può che essere appannaggio della borghesia mentre la forza operaia non può che darsi come forza illegittima ed esprimersi solo attraverso l’illegalità. Dentro lo stato borghese la classe operaia deve essere forzatamente disarmata, ma una classe disarmata non può esercitare alcuna forza, non occorre il rasoio di Occam per comprenderlo.
 Su ciò Lenin è estremamente chiaro e, in piena coerenza, considera l’armamento operaio aspetto permanente dell’organizzazione rivoluzionaria. Non si tratta di una particolare propensione di Lenin per il militarismo, ma dello scontato riconoscimento che così come non vi è movimento rivoluzionario senza teoria rivoluzionaria, non vi è organizzazione operaia senza forza operaia.
Su ciò Lenin è estremamente chiaro e, in piena coerenza, considera l’armamento operaio aspetto permanente dell’organizzazione rivoluzionaria. Non si tratta di una particolare propensione di Lenin per il militarismo, ma dello scontato riconoscimento che così come non vi è movimento rivoluzionario senza teoria rivoluzionaria, non vi è organizzazione operaia senza forza operaia.
Per Lenin, e non per caso abbiamo ricordato il debito da lui contratto con Clausewitz, il militare è sempre compreso nel politico, ne è aspetto costitutivo e costituente il quale non subentra al posto del politico e non ne è neppure l’aspetto anomalo e indesiderato bensì un suo tratto ineludibile, ma se ciò è vero, e lo è, ne vanno tratte le ovvie conseguenze.
In un contesto in cui la forza è sottoposta a regime di monopolio o si rinuncia al conflitto o ci si adopera per edificare la propria forza. Certo la forza non può che essere costantemente posta sotto il controllo del politico e modellarsi alle fasi del conflitto, ma deve esistere sempre, essere sempre presente e, per le obiettive caratteristiche che incarna, godere anche di un certo grado di autonomia. La presenza di un apparato militare è una costante della teoria politica leniniana che solo la deriva socialdemocratica e riformista a cui è approdato il movimento operaio ufficiale in occidente ha posto prima tra parentesi e poi in archivio.
Il dibattito sulla forza entra prepotentemente nel dibattito de “La classe” e con ciò l’esperienza di questo giornale compie un salto politico non secondario rispetto a tutto ciò che è venuto prima. Lo compie perché al centro della sua iniziativa, a differenza di gran parte di quanto l’ha preceduto, costante è la questione dell’organizzazione complessiva degli operai in funzione dello scontro con lo stato. Certo, col senno di poi, si potranno anche fare mille obiezioni ai tentativi messi in atto da “La classe”, ma ciò che dobbiamo tenere costantemente a mente è il periodo in cui questi tentativi si danno e il vuoto politico in cui questa sperimentazione si dà. Dobbiamo infatti avere ben a mente che questa generazione di operai e comunisti alle spalle non ha alcuna esperienza tranne il mito resistenziale mutuato velocemente in democraticismo e parlamentarismo opportunista e imbelle. La stessa radicalità operaia manifestatasi nel ’607 e nel ’628 si è trovata di fronte il muro del partito e del sindacato che l’hanno tacciata di estremismo, teppismo e persino fascismo. Dietro di sé questa generazione operaia e comunista non ha alcuna tradizione dalla quale attingere. Ma ritorniamo a occuparci della questione della forza.
Le lotte operaie stanno ponendo, ogni giorno che passa, all’attenzione dei comunisti la questione della forza e “La classe” ha indubbiamente il merito di non eludere il problema ma di affrontarlo di petto. Lo fa, occorre riconoscerlo, anche con una certa ingenuità, ma questo più che essere il frutto di limiti e incapacità è la triste testimonianza di come tutta una generazione di operai e comunisti si sia trovata, e non certo per colpa propria, del tutto impreparata ad affrontare passaggi centrali del conflitto di classe. Proprio questi limiti testimoniano l’infausto ruolo giocato per anni dal movimento operaio ufficiale che si era speso non poco per imporre che la questione della forza dovesse essere considerata ormai del tutto estranea alle esigenze della classe operaia soprattutto come strumento offensivo. È vero l’uso della forza non è ipotesi del tutto estranea al movimento operaio ufficiale, ma lo è nella sua accezione difensiva tutta ripiegata in chiave antifascista e anti golpista. Qui si aprono una serie di questioni che meritano di essere trattate senza fretta.
Intanto, anche seguendo il filo del discorso dei riformisti, viene da chiedersi come sia concretamente possibile fare ricorso alla forza se questa forza non esiste. In che modo, cioè, la classe operaia potrebbe, in caso di golpe fascista o svolta apertamente autoritaria, armarsi e combattere se alle sue spalle non vi è alcun apparato militare minimamente attivo e preparato, ma non solo. O gli operai nascono, per patrimonio genetico, militarmente già formati, oppure asserire che di fronte alla minaccia fascista e golpista si combatterà è solo una boutade o, aspetto tipico dell’opportunismo, passare repentinamente dal legalitarismo all’avventurismo tout court con tutte le ricadute del caso.
Immaginiamo, anche solo per un momento, che di fronte a un golpe vengano distribuite le armi agli operai ora, ammesso e non concesso che queste armi da qualche parte esistano, pensiamo a un qualunque operaio che all’improvviso si ritrovi tra le mani un mitra, cosa ne fa? Immaginiamolo alle prese con il tiro a raffica, è pensabile che sia in grado di farlo con un minimo di dimestichezza? Non occorre dare una risposta. Una simile ipotesi non può che condurre al massacro cosa che, del resto, è proprio dell’opportunismo che precipita velocemente nell’avventurismo.
Qui occorre rilevare la reiterazione di un vizio originario del movimento operaio e comunista italiano e più in generale occidentale, un vizio che possiamo tranquillamente far risalire, per quanto concerne l’Italia, almeno al biennio rosso prima e alla vittoria del fascismo dopo. Di fronte all’offensiva operaia seguita alla guerra e alla tendenza insurrezionale che questa si portava dietro, nessuna delle forze politiche della sinistra, all’epoca ancora legate al PSI e che successivamente daranno vita al PCd’I, si pose minimamente sul terreno della guerra civile e, invece di organizzare l’attacco alla macchina statuale, non riuscirono ad andare oltre la gestione della fabbrica capitalista9.
Nel momento in cui si era reso necessario passare dalle armi della critica alla critica con le armi nessuno si mostrò minimamente preparato e tanto meno intenzionato a farlo. La questione militare, che per Lenin era sempre stata aspetto ineludibile dell’agire di partito, era del tutto estranea anche tra coloro che si professavano interni al marxismo rivoluzionario. Non diversamente da quelli tedeschi, i rivoluzionari italiani si mostravano quanto mai distanti da Lenin poiché la guerra, andando al sodo, continuava a essere considerata come momento anomalo della politica e non suo aspetto costituente, un errore concettuale tipico di tutto il socialismo europeo. Su questi presupposti è ovvio che nessuno si mostrasse non solo pronto alla battaglia, ma che non fosse neppure in grado di raccogliere le tensioni insurrezionali provenienti dalla lotta operaia. Se c’è un momento in cui il distacco della presunta avanguardia dalle masse assume tratti al limite del grottesco è esattamente questo. Se possibile le cose andarono ancora peggio di fronte all’incalzare del fascismo.
Non si può certo dire, come tutte le esperienze degli Arditi del popolo10 sono lì a testimoniare, che non vi fu resistenza di massa al fascismo, ma fu una resistenza che non trovò alcuna sponda politica e del resto, come ricorda nelle sue memorie Bruno Fortichiari11, responsabile del settore militare del PCd’I, l’arsenale del partito nel 1922 contava tre revolver, mentre il suo apparato militare era formato da qualche gruppo di giovanotti che si cimentava in scampagnate tra le montagne.
Tutto ciò a palese dimostrazione di come, indipendentemente dalle dichiarazioni di principio, nel nostro paese i tratti del partito dell’insurrezione difficilmente riuscivano a andare oltre i perimetri della carta stampata e delle frasi fatte, insomma tutto chiacchiere e stemma di partito. Questo lo scenario di fondo al quale, però, si aggiungono anche altri elementi i quali, se possibile, peggiorano ancor più la situazione e finiscono con il fare tabula rasa intorno a qualunque ipotesi insurrezionale. Se, nella tradizione del movimento operaio ufficiale, il ricorso alla forza era stato un enunciato al quale non era mai stato data concretezza, l’assunzione della guerra di posizione come sola e unica cornice politica possibile in un paese a capitalismo avanzato12, pone una pietra tombale sul marxiano passaggio dalle armi della critica alla critica con le armi. Assumere la dimensione della guerra di posizione non significa solo mettere da parte la rivoluzione, ma riconoscere per intero la democrazia borghese e parlamentare come cornice politica della classe operaia e, sulla scia di ciò, per il movimento operaio ufficiale, il ricorso alla forza diventa legittimo solo di fronte a un atto illegittimo della borghesia. La forza, il che ha qualcosa di paradossale, può e deve essere utilizzata solo per ripristinare la legalità borghese nel caso questa, o alcune sue frange, si adoperassero per sopprimerla. La forza è legittima solo in funzione antifascista.
(3 – continua)
