di Francisco Soriano
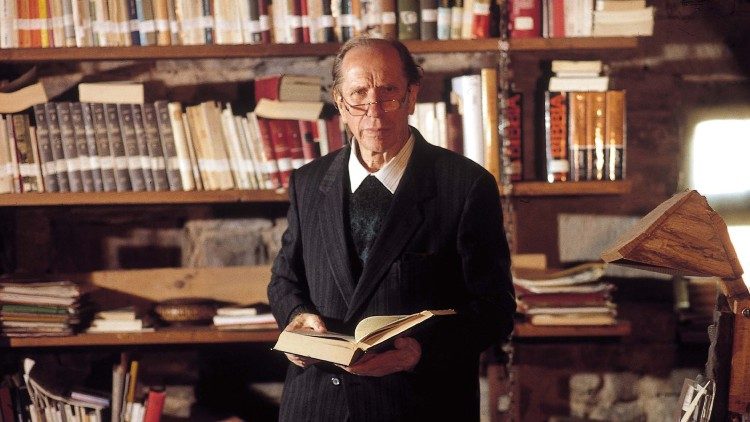 Nel primo capitolo dell’autobiografia di David Maria Turoldo, La mia vita per gli amici: vocazione e resistenza, il poeta così afferma: Credo che nessuno possa rispondere a una domanda simile: dire di sé chi sia. Se lo sapesse, sarebbe la fine. Non è con questo che non ne riconosca la legittimità; dico solo che è una domanda che non può avere una risposta esauriente e persuasiva, tanto meno se espressa dall’interrogato. È un problema che rimanda alla storia, per quanto anche la storia sia lo spazio della profezia imperfetta, cioè della profezia incompiuta. Quel giorno che si adempisse perfettamente la profezia, segnerebbe la fine della storia. Così è di ogni vita: quel giorno che uno sapesse dire chi è, la sua storia sarebbe compiuta.
Nel primo capitolo dell’autobiografia di David Maria Turoldo, La mia vita per gli amici: vocazione e resistenza, il poeta così afferma: Credo che nessuno possa rispondere a una domanda simile: dire di sé chi sia. Se lo sapesse, sarebbe la fine. Non è con questo che non ne riconosca la legittimità; dico solo che è una domanda che non può avere una risposta esauriente e persuasiva, tanto meno se espressa dall’interrogato. È un problema che rimanda alla storia, per quanto anche la storia sia lo spazio della profezia imperfetta, cioè della profezia incompiuta. Quel giorno che si adempisse perfettamente la profezia, segnerebbe la fine della storia. Così è di ogni vita: quel giorno che uno sapesse dire chi è, la sua storia sarebbe compiuta.
Il merito principale di questo irraggiungibile poeta è la capacità di interloquire con il lettore e destabilizzarne ogni possibile convinzione. David Maria Turoldo ha progettato un metodo, come in Odisseas Elitis quello del dunque, che attraversa lo spirito umano in spazi e mondi invalicabili, talvolta distopici, altre volte cristallini come nel paesaggio di una primavera assolata. La profezia è termine di significato intenso. Soprattutto nella ricerca del fine e del dove: la nostra umanità da sempre cerca affannosamente una risposta plausibile fino alla costruzione di un riferimento divino presente in tutte le religioni, in particolar modo quelle dotate di un libro sacro, in cui tutte le conseguenze delle vicende umane vengono ricondotte a un disegno, verso il quale tende uno sforzo spesso inconciliabile con la ragione, che consiste nella interpretazione o manifestazione di una profezia. L’incompiuto e l’irrisolto sono in questo autore linfa vitale e, forse, la deduzione della profezia-non-profezia consiste proprio nell’impossibilità di definire i contorni e il senso del nostro esistere.
Per Turoldo l’Io è irriducibile a qualsivoglia definizione, sfugge alle categorie, non può essere sottoposto a cristallizzazione: in questa visione in cui si esalta la persona emergono tratti di una teoria libertaria senza precedenti, perché l’impossibilità della codificazione dell’individuo è territorio caro a chi lo ritiene sacro nel suo essere pensante e nel suo corpo, in cui tutto trova conferma e sintesi. Turoldo afferma che è sempre parziale e inadeguato il giudizio o l’immagine degli altri, quanto inadeguato e insufficiente è il giudizio che di volta in volta noi, come singoli, rivolgiamo a noi stessi.
La visione positiva e immanente dell’idea che il fondo inesplorato e inesplorabile è la sorgente principale del cantare del poeta ci lascia chiaramente comprendere quanto incisiva nella concezione poetica di Turoldo sia questa intuizione. Si scopre a questo punto un Turoldo polemico, che afferma il suo Io non nei termini di un Io grammaticale come invece è quello diffuso nella poesia italiana a lui contemporanea, ma di un Io storico, cioè protagonista del proprio tempo, civile, politico, impegnato, sociale, combattivo, carico del suo bene e del suo male, carico di grazia e di peccato, che dispera e spera insieme, che benedice e maledice. Il procedimento che segue nei suoi scritti si evolve per contrapposizioni estreme, sospensioni e negazioni: è pratica stilistica propria del poeta, che svolge una intensa e complessa attività retorica nella sua poesia e nella sua prosa, straordinariamente sconvolgente e sorprendente perché si insinua nell’intimo di ognuno di noi concretandosi in valori irrinunciabili. Questo Io che è sempre in lotta, dice il poeta, che non vive di rimpianti, non è un Eden perduto, bensì da raggiungere.
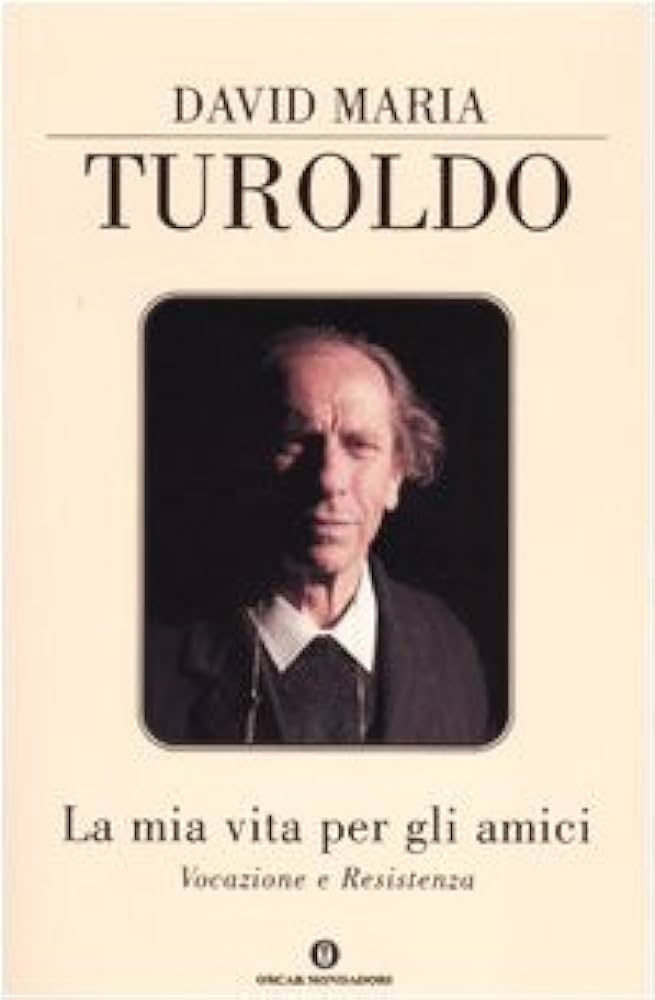 Turoldo pone a se stesso quesiti semplici ma irrisolvibili: da dove vengo, di chi sono figlio, da quale terra provengo, quale terra mi porto dentro, per quali vie mi sono avventurato per il mondo. Le risposte sono date solo nell’incompiuta profezia, procedendo per negazioni e scrutando dal precipizio che ci conduce nel vuoto-nulla dove l’unico approdo rimangono le parole, la poesia, il canto. Non è un caso che Turoldo fosse un frate, un mistico più che un religioso, un povero e mai un’istituzione, un soffio sul dorso della mano e non una torre d’avorio.
Turoldo pone a se stesso quesiti semplici ma irrisolvibili: da dove vengo, di chi sono figlio, da quale terra provengo, quale terra mi porto dentro, per quali vie mi sono avventurato per il mondo. Le risposte sono date solo nell’incompiuta profezia, procedendo per negazioni e scrutando dal precipizio che ci conduce nel vuoto-nulla dove l’unico approdo rimangono le parole, la poesia, il canto. Non è un caso che Turoldo fosse un frate, un mistico più che un religioso, un povero e mai un’istituzione, un soffio sul dorso della mano e non una torre d’avorio.
Uno scaricatore del porto di Dio, amava definirsi, conciliando la fatica dell’umile-ultimo al servizio del prossimo, una immagine che lo conduceva al cuore della sua poesia, il sublime atto di amore di ciò che è inusitato nel bene e nel male. E in questa direzione, commovente, drammaticamente terreno, così affermava: È come se, impossessatasi della chiave di lettura, mi si spii dalla cella dell’anima. Perché questa è la mia abitazione – o è stata una delle mie dimore più lunghe – l’abitazione del Male, la frequentazione della mia miseria. Quanto manca David Maria Turoldo nei nostri giorni, nel nostro quotidiano, nella nostra angusta vita, è facilmente percepibile. Oggi, grazie agli strumenti che con i suoi scritti il poeta ci pone come punti di riflessione, possiamo dedurre quanto il peccato è generatore primo della nostra esistenza, segnando la frattura ontologica dell’esistenza con l’Essere. Momento irrinunciabile nella poetica di Turoldo e nella sua architettura teorica di un pensiero assolutamente originale e fondante alcuni valori della civiltà occidentale. Turoldo rappresenta uno dei massimi pensatori del Novecento italiano ed europeo, scopre l’originarietà del male e disserta sulla sua positiva quanto rigenerante forza negli esseri umani. Così, nella ricerca che compie attraversando meandri impercettibili alla moltitudine, percepisce[sente] che il concetto di peccato non può essere banalmente ricondotto a semplice evento di tipo moralistico, bensì è momento di angoscia, strappo metafisico, disperazione.
Il peccato come fonte unica del gemere e del cantare mi riconduce ancora una volta a Odisseas Elitis, che usava con la stessa carica riflessiva e tragica la parola fonte, la quale trasformava il male, la tortura, la lapidazione in parole d’amore e di perdono. Per questo spesso rifletto sulla inconciliabilità della vendetta in chi ha sedimentato dentro il suo corpo, le sue cellule, nel proprio Io pulsante, la pietas e la carità come pregiudiziali all’incontro, alla scoperta del volto dell’altro. Turoldo ricorda che in tempi di guerra gli sarebbe piaciuto accedere con più facilità a documenti di difficile consultazione, pensando di laurearsi sul concetto di confessione nei romanzi di Dostoevskij, per dire quanto il bisogno di gridare il proprio peccato, l’angoscia del peccato, è il segno strutturale e fisiologico della condizione umana; per dire quanto la necessità di superarlo e di liberarci sia insopprimibile alla stessa natura dell’uomo, e nello stesso tempo quanto sia rivelazione di un dramma mai risolto, e neppure solubile con le forze umane.
Pensava, il poeta, all’avvilito costume della confessione cattolica, lui frate di una chiesa in cui non riconosceva il potere degli uomini che discorrevano in nome di un Dio: a quell’appressarsi del penitente allo sportello di un confessionale, come un affacciarsi dell’uomo alla grata dell’Infinito, dove riversare il carico della sua miseria. Era di là della grata che mi si apriva il porto di Dio; e io come scaricatore appunto di quel porto.
Turoldo esce fuori dal Tempio. Smaschera, deduce, argomenta, canta versi di intima dolcezza, affronta ogni male che ci conduca alla scoperta dell’altro, del nemico, dell’amico, che si specchia fra luci rigogliose di un mattino appena cominciato e le tenebre di una notte che avvolge senza rendere una sola speranza. La sua poesia mi disorienta. Mi attraversa e mi lacera. Conquista ogni spazio abitato nel mio corpo, mi getta sconsolato nell’irrisolto, nell’inappagato, nel mondo altro, nella poesia. Lode a padre Turoldo, ora e per sempre nei secoli a venire:
Voglio chiederti una cosa:
per te, Signore.
Per me non è necessario che ti spieghi:
sento la tua gloria (e la tua
rabbia, il tuo sdegno)
oltre le infinite delusioni:
tu non puoi non amarmi,
ti sono necessario.
Questo chiedo.
Che ti liberi
Dai devoti di ogni religione!
