di Franco Pezzini
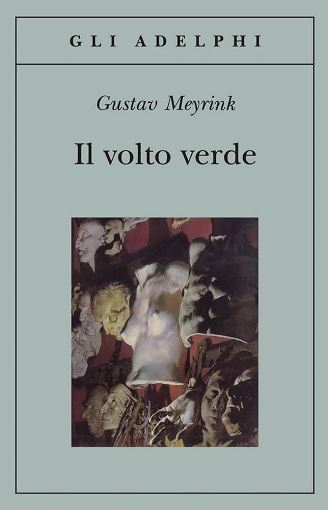 (Per le parti precedenti, cfr. qui)
(Per le parti precedenti, cfr. qui)
Pipistrelli, succhiatempo e volti verdi (1916)
Non esiste – spiega Meyrink – un unico modo per ricercare la conoscenza: e tutta la vita non è altro che “domande formate” ogni volta diverse e risposte che ognuno comprende in modo differente, per poter seguire la strada del proprio cuore. A fronte di un alfabeto ebraico di sole consonanti, ognuno deve trovare le vocali segrete, che schiudono un senso destinato a lui solo – altrimenti la parola viva si sclerotizzerebbe in un dogma morto.
Nessuna sorpresa dunque se la produzione di Meyrink guarderà ad agenzie sapienziali diverse e in modo molto libero: lo stesso sincretismo in fondo molto sfumato che nel Golem ammanta l’affannosa ricerca di un sé superiore, recupera con misura gli antichi spunti – tanto vivi a inizio Novecento in un intero orizzonte di riflessioni teo/antroposofiche – su una sophia perennis di universale verità al di là delle singole tradizioni religiose, e che pervaderà le opere successive. Grazie a una perizia narrativa non comune in questo genere di opere, e che riconduce a coerenza impianti simbolici estremamente variegati e senza cesure tra Occidente e Oriente, Meyrink si colloca così nella stessa tradizione dell’amico Kubin, su una lunga tradizione di poeti visionari (da Dante a Jakob Böhme, a William Blake, a Hoffmann…): e la sua scrittura offre una strana vita propria, un’esistenza vibrante a cose altrimenti morte e rigide – come il golem, in fondo.
Tale lavoro sul suo primo grande lavoro finirà con il trovare seguito nella successiva produzione di racconti – in realtà sempre meno – e soprattutto di romanzi di Meyrink.
Per quanto riguarda i racconti, va ricordata la raccolta Pipistrelli, più precisamente Fledermäuse. Sieben Geschichten (Kurt Wolff, Lipsia 1916), che incontrerà l’attenzione di Jung e accorpa ad alcuni testi dal “Simplicissimus” altri nuovi. Dalla rivista viene in particolare La visita di Johann Hermann Obereit nel Paese delle Succhiatempo (J. H. Obereits Besuch bei den Zeit-Egeln, “Simplicissimus”, 47, 1916): vi scopriamo come i desideri vani degli uomini popolino la realtà di larve vampiresche, e solo chi riesca a estirparli conosce una rinascita spirituale e può porre l’epitaffio “Vivo” sulla propria tomba (come in effetti Meyrink farà).
 Mentre, per i testi nuovi inseriti nella raccolta, la straniante novelette Meister Leonhard (Meister Leonhard), rielabora l’elemento autobiografico del difficile rapporto con la madre – descritta come oppressiva, agitata e superficiale, con “un irrequieto volo a zig zag da pipistrello” –, uccisa accidentalmente dal figlio, che lei ha interrotto mentre sta consumando un atto carnale con la serva Sabine poi risultata sua sorella. Da confidenza dolente gravida di colpa (lo scrittore non ha ucciso sua madre, ma forse qui spurga simili vaghe fantasie) e di rincrescimento (la mancanza di dialogo col padre, di cui pure intuisce il valore), il testo diventa così altro. La lotta contro l’insensatezza nel segno di quella sorta di svastica templare che è la croce di Satana – “quattro gambe umane in corsa, piegate ad angolo retto all’altezza delle ginocchia” – racconta dunque la storia tortuosa di un percorso verso una coscienza superiore, tra richiami ai Templari e al Bafometto, a un satanismo/luciferismo d’antan e a Meister Eckart.
Mentre, per i testi nuovi inseriti nella raccolta, la straniante novelette Meister Leonhard (Meister Leonhard), rielabora l’elemento autobiografico del difficile rapporto con la madre – descritta come oppressiva, agitata e superficiale, con “un irrequieto volo a zig zag da pipistrello” –, uccisa accidentalmente dal figlio, che lei ha interrotto mentre sta consumando un atto carnale con la serva Sabine poi risultata sua sorella. Da confidenza dolente gravida di colpa (lo scrittore non ha ucciso sua madre, ma forse qui spurga simili vaghe fantasie) e di rincrescimento (la mancanza di dialogo col padre, di cui pure intuisce il valore), il testo diventa così altro. La lotta contro l’insensatezza nel segno di quella sorta di svastica templare che è la croce di Satana – “quattro gambe umane in corsa, piegate ad angolo retto all’altezza delle ginocchia” – racconta dunque la storia tortuosa di un percorso verso una coscienza superiore, tra richiami ai Templari e al Bafometto, a un satanismo/luciferismo d’antan e a Meister Eckart.
Sempre nella raccolta, un’altra novelette nuova dai toni apocalittici congrui all’epoca, I quattro fratelli della luna (Die vier Mondbrüder: Eine Urkunde), ripropone in chiave onirica, tra incubo e grottesco, il tema della fine del genere umano, richiamando tra l’altro l’amicizia e la stima per Alfred Kubin di Meyrink – come peraltro qui si chiama il narrante stesso, cameriere personale del conte di Chazal, poi del magister Peter Wirtzigh. Interessante l’apparire nella storia, fitta di richiami alla luna e alle macchine, di una maschera espressionista alla Hoffmann poi presente anche in altre opere meyrinkiane, il cadaverico dottor Sacrobosco Haselmayer, ospite del conte il 21 luglio di ogni anno. La chiave allucinatoria dell’insieme fa esplodere ogni certezza identitaria sul narrante.
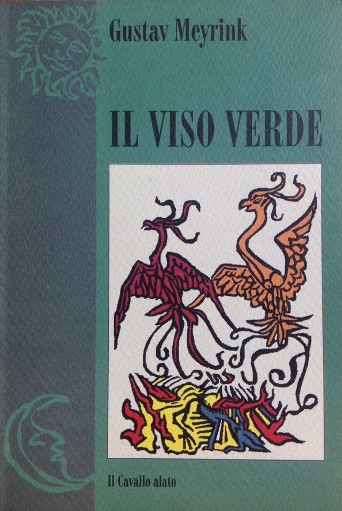 Per i romanzi, dello stesso anno di Pipistrelli è Il volto verde (Das grüne Gesicht. Ein Roman, Kurt Wolff, Lipsia 1916; attingo qui all’edizione Adelphi, 2012), che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi L’Ebreo errante. Un romanzo strano, chiaramente espressionistico che interesserà Jung; un romanzo molto più esoterico del Golem, anche se si tratta di intendersi sull’aggettivo. Di nuovo, troviamo una riflessione sull’interiorità e l’urgenza di recuperare un senso vero alla vita, quindi soprattutto filosofico e mistico in una Storia giunta alla crisi. Certo rispetto al romanzo precedente l’approccio per il lettore è meno agevole e fluido, come a forzarlo a uno sforzo di comprensione su una materia ostica. Anzi, la dimensione esoterica finisce col riguardare anzitutto la forma: in tutta la prima parte il lettore vaga alle prese con strani incontri, eventi bizzarri, maschere grottesche e veggenti più o meno improbabili. Poi lentamente i fili si stringono e la storia prende forma. Sembra esoterica anche la struttura, quattordici capitoli (sette e poi sette, numero simbolicamente rilevante per rosacroce e cabalisti, e divisi da una profonda cesura) con una visione finale.
Per i romanzi, dello stesso anno di Pipistrelli è Il volto verde (Das grüne Gesicht. Ein Roman, Kurt Wolff, Lipsia 1916; attingo qui all’edizione Adelphi, 2012), che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi L’Ebreo errante. Un romanzo strano, chiaramente espressionistico che interesserà Jung; un romanzo molto più esoterico del Golem, anche se si tratta di intendersi sull’aggettivo. Di nuovo, troviamo una riflessione sull’interiorità e l’urgenza di recuperare un senso vero alla vita, quindi soprattutto filosofico e mistico in una Storia giunta alla crisi. Certo rispetto al romanzo precedente l’approccio per il lettore è meno agevole e fluido, come a forzarlo a uno sforzo di comprensione su una materia ostica. Anzi, la dimensione esoterica finisce col riguardare anzitutto la forma: in tutta la prima parte il lettore vaga alle prese con strani incontri, eventi bizzarri, maschere grottesche e veggenti più o meno improbabili. Poi lentamente i fili si stringono e la storia prende forma. Sembra esoterica anche la struttura, quattordici capitoli (sette e poi sette, numero simbolicamente rilevante per rosacroce e cabalisti, e divisi da una profonda cesura) con una visione finale.
Nel momento in cui, verso il 1915, Meyrink è alla ricerca di un nuovo orientamento, e si rivolge deliberatamente alle dottrine esoteriche orientali, è chiaro che gli elementi grotteschi debbono a poco a poco scomparire dalle sue opere letterarie.
Certo, nei suoi romanzi degli Anni Venti, Das grüne Gesicht e Walpurgisnacht, troviamo dei personaggi, dei motivi e persino una sorta di intermezzi grotteschi che ostacolano lo svolgersi dell’azione e irritano o divertono il lettore […] [Helga Abret-Brauner, Grottesco e fantastico nei racconti di Meyrink, in AA. VV., Meyrink scrittore e iniziato, Basaia, Roma 1983],
mentre nell’ultima parte della sua produzione il grottesco scomparirà.
Sul piano letterario Il volto verde è una creazione curiosa (viene persino da domandarsi se alcuni personaggi e magari episodi non siano recuperati dal primo impianto del Golem, con il proliferare di bozzetti poi stralciati per migliorare struttura e coesione), ma i bassifondi di Amsterdam – in particolare della zona ebraica – sono evocati in modo molto felice e i personaggi efficacemente descritti. L’azione non vi ha troppa importanza, ed è portata avanti non tanto da meccanismi di trama quanto dalle dinamiche tra personaggi.
Creando personaggi doppi e personaggi complementari, che spesso simboleggiano contemporaneamente il successo o la sconfitta, i diversi stadi sulla via dello sviluppo esoterico, crea un vasto scenario, colorito e plastico, in cui si stacca con tanto maggior chiarezza l’evoluzione dell’ “eroe” Fortunat Hauberrisser. [Joseph Strelka, “La faccia verde”, in AA. VV., Meyrink scrittore e iniziato, cit.]
 E per seguire il filo dei simboli occorrerà sgranare episodio dopo episodio. Prepariamoci a un vagare febbrile, a tratti ciondolante.
E per seguire il filo dei simboli occorrerà sgranare episodio dopo episodio. Prepariamoci a un vagare febbrile, a tratti ciondolante.
Come detto, stavolta la storia si ambienta non a Prega ma ad Amsterdam, dove uno straniero visita in Jodenbreestraat – la “via larga ebraica” insediamento di molti transfughi ebrei dalla penisola iberica, e dove visse anche Spinoza – la “Bottega delle Meraviglie” di tal Chidher Grün. Un negozio pieno di oggetti bizzarri, sostanzialmente di accessori per prestidigitazione: teschi di cartapesta che sputano cartigli con profezie, cartoline erotiche, icone di suocere con labbra chiuse da lucchetti, manette, libri dei sogni egizi, scarafaggi finti, garanzie di qualche successo sociale come “‘il terrore dello scompartimento’ (un sistema infallibile per allacciare relazioni stabili durante i viaggi in treno, a uso dei commessi viaggiatori) consistente in zanne di lupo da fissarsi sotto i baffi”… e molto altro.
Nel locale, l’elegante viaggiatore austriaco nota un figuro dai tratti balcanici intento a leggere un giornale, ma anche una commessa propria connazionale, una graziosa signorina bionda. Questa riesce a vendergli il gioco di prestigio chiamato “I turaccioli volanti” e tenta di spiegargli il trucco, ma vengono interrotti dall’irrompere di “un gigantesco zulù dalla barba nera e crespa e le labbra tumide” con un chiassoso impermeabile a scacchi e una lancia in mano. Introdotto costui – che apprenderemo chiamarsi Usibepu, lavora al circo Carrè e al suo paese è uno stregone – e buttato fuori un tipo che lo segue lanciando sputi, la spiegazione sui turaccioli riprende, ma il visitatore dubita di riuscire a imparare e ripetere la manipolazione. Emerge invece che Usibepu conta di tornare in patria con una buona quantità di trucchi nuovi per far colpo sui compatrioti, e il figuro dall’aria balcanica – il signor Zitter Arpád di Bratislava – gli sta appunto insegnando una serie di giochi di prestigio alquanto macabri.
Insomma trucchi, e non solo: in uno scaffale il visitatore nota una serie di volumi dal taglio dorato siglati da titoli come Storia della società corale accademica di Bonn e La cura delle emorroidi nell’antichità classica, ma che all’interno racchiudono la birichina “Biblioteca di Sodoma e Gomorra, Raccolta di scritti per scapoli impenitenti”. Mentre un vecchio ebreo in caffettano appare intento a scrivere nel retro, da un orologio a muro spunta al posto del cucù un busto femminile discinto che canta una canzonetta sconcia…
Stranito da quell’ Hellzapoppin’, lo straniero se ne andrebbe se non si sentisse oppresso da una tale astenia da piombare a sedere, meditando sull’insensatezza delle cose: ecco di nuovo come Pernath un antieroe modernista, con una dimensione interiore difficile, demotivato a vivere e un po’ depresso. Sospetta anzi che esista qualche patologia causata da “quel senso di morte che spira da tutte le cose create dall’uomo, siano esse belle o brutte”: il suo amico barone Pfeill sostiene che questo sia l’effetto tossico dei quadri appesi – ciò che spiegherebbe lo stato di sofferta tristezza tradito dalle immagini dei santi cristiani a fronte della serenità delle statue del Buddha. Lo straniero ha una posizione profondamente scettica verso le proposte di società e civiltà, e oltretutto nella “Bottega” il bisbiglio tra il figuro balcanico e Usibepu sta cullandolo facendolo assopire. Anche se poi si risveglia con “la sensazione di aver ricevuto una sconvolgente quantità di rivelazioni”, di cui trattiene come precipitato un’unica frase:
Raggiungere il sorriso eterno è più difficile che scovare fra le migliaia di tombe su questa terra il teschio portato sulle spalle in una precedente vita; l’uomo dovrà aver pianto tutte le sue vecchie lacrime prima di poter osservare il mondo con occhi nuovi, sorridendo.
Ancora nel sonno – ma convinto di essere sveglio – vagheggia così di costringere le cose a rivelargli il loro vero significato; ritiene di aver scoperto che “tutto si morde la coda, come dice il [suo] amico Pfeill” e in assenza di insegnamenti più saggi fantastica di ritirarsi nel deserto come il Battista a nutrirsi di cavallette e miele selvatico. Ma una voce (plausibilmente sempre nel sogno) lo irride: fa tante fantasie e poi è così scemo da pagare in argento uno stupido giochino come quello dei turaccioli? Non distingue una bottega delle meraviglie dal mondo reale e non intuisce “che nei libri della vita c’è qualcosa di diverso da ciò che è stampato sul dorso? Lei dovrebbe chiamarsi Grün, non io” (nel senso di Grün come “verde” ma anche come “ancora inesperto, immaturo”). A parlargli è il vecchio ebreo proprietario del negozio, con una benda nera sulla fronte, occhi profondissimi e un colore del volto tendente al verde oliva e con riflessi bronzei: “così doveva essere la pelle degli uomini preistorici, che si diceva avesse il colore dell’oro verde scuro”. E infatti gli confida di essere sulla terra dai giorni dell’apparire della luna: ha visto uomini che erano scimmie, e in fondo lo sono ancora e guardano in basso. Continuano a scoprire ulteriori dimensioni dell’infinitamente piccolo, ma così si può continuare indefinitamente senza risultati.
Io sono colui che affissa lo sguardo al basso e all’alto; il pianto l’ho scordato, ma non ho ancora imparato a sorridere. Il diluvio universale ha inumidito i miei piedi, ma non ho mai conosciuto nessuno che avesse motivo di sorridere; può anche darsi che non l’abbia notato, e che passandogli accanto abbia tirato dritto.
Ora è un mare di sangue a lambirmi i piedi, e proprio adesso dovrebbe presentarsi uno a cui è dato sorridere? Non credo proprio. È più probabile che dal fuoco sgorghi l’acqua.
Comunque quel volto gli toglie il respiro, e tornerà come un’ossessione lungo tutto il romanzo.
Lo straniero acquista ancora un teschio di cartapesta che sputa dalle mandibole rotolini di carta con profezie, e se lo fa spedire a casa, prima di uscire frastornato. Apprendiamo qui che si chiama Fortunat Hauberrisser ed è un ingegnere (Fortunat è il nome – purtroppo beffardo, a fronte della triste vicenda che lo attende – del figlio di Gustav).
 Ripensiamo al discorso di questa sorta di Ebreo errante. Quando il romanzo appare l’Europa è in guerra, e lui ha raccontato “Ora è un mare di sangue a lambirmi i piedi”; ma nel secondo capitolo che adesso inizia veniamo informati che la guerra è finita “generando conflitti politici interni sempre più aspri”. In sostanza si tratta di un’ucronia, con un’ideale fenditura tra il conflitto reale che pesa sulla vicenda, cioè la Prima Guerra mondiale, e la pace virtuale di un affannato, immaginario dopoguerra, che comunque conduce lì stranieri di ogni nazionalità, per permetterne un insediamento duraturo o anche solo transitorio. L’esodo riguarda però più i benestanti, afflitti dalla pressione fiscale nei propri paesi, che gli strati poveri della popolazione: le entrate di uno spazzacamino o di un macellaio sono in questa situazione molto superiori allo stipendio di un professore universitario, portando gli intellettuali alla dispersione e riempiendo i vecchi alberghi olandesi in un clima di totale incertezza. Come vedremo, a dispetto delle sferzate ai borghesi preoccupati dal soldo, Meyrink talora vi si avvicina pericolosamente.
Ripensiamo al discorso di questa sorta di Ebreo errante. Quando il romanzo appare l’Europa è in guerra, e lui ha raccontato “Ora è un mare di sangue a lambirmi i piedi”; ma nel secondo capitolo che adesso inizia veniamo informati che la guerra è finita “generando conflitti politici interni sempre più aspri”. In sostanza si tratta di un’ucronia, con un’ideale fenditura tra il conflitto reale che pesa sulla vicenda, cioè la Prima Guerra mondiale, e la pace virtuale di un affannato, immaginario dopoguerra, che comunque conduce lì stranieri di ogni nazionalità, per permetterne un insediamento duraturo o anche solo transitorio. L’esodo riguarda però più i benestanti, afflitti dalla pressione fiscale nei propri paesi, che gli strati poveri della popolazione: le entrate di uno spazzacamino o di un macellaio sono in questa situazione molto superiori allo stipendio di un professore universitario, portando gli intellettuali alla dispersione e riempiendo i vecchi alberghi olandesi in un clima di totale incertezza. Come vedremo, a dispetto delle sferzate ai borghesi preoccupati dal soldo, Meyrink talora vi si avvicina pericolosamente.
Nel caffè “De vergulde Turk”, labirintico e fumoso, una signora attende stizzita il barone Pfeill senza rendersi conto che è già arrivato in un altro angolo del locale, assieme all’amico ingegner Hauberrisser: la signora intende vendergli biglietti per una festa in maschera e il barone prende la faccenda – e l’agitazione di lei – con ironia lieve. No, gli bastano quattro biglietti, non cinque: e la dama (la classica professionista della carità ferma in superficie) se ne va innervosita.
Senza notare che è arrivata una bambina, nipote del calzolaio Klinkherbogk, portando una busta e avvertendo il barone che si è sbagliato e ha pagato mille fiorini invece di dieci: Pfeill le lascia benevolo la cifra in più e la congeda nella commozione del calzolaio. Non volendo toccare l’episodio per delicatezza, Hauberrisser gli chiede se conosca la leggenda dell’Ebreo errante, il leggendario calzolaio di Gerusalemme che avendo impedito il riposo a Gesù diretto al Golgota, si trova costretto a vagare fino al suo ritorno. 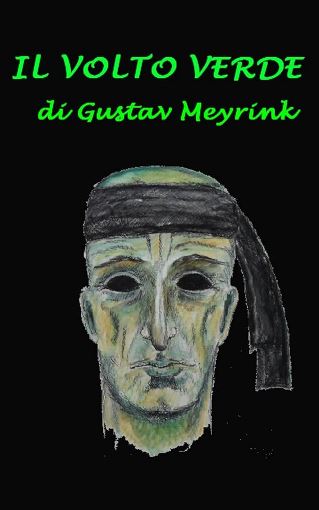 Pfeill riferisce all’amico varie storie sul tema (compresa la tradizione che lo chiama Chidher, il Verde, guarda caso come il proprietario della “Bottega delle Meraviglie”), commentando la stranezza che subito prima gli fosse tornato alla memoria un certo ritratto visto a Leida molto tempo addietro. E descrive un volto di carnagione olivastra che l’ha perseguitato a lungo, persino nei sogni: un volto che ora inquieta l’amico perché pare descrivere proprio l’uomo dalla faccia verde incontrato. L’amico gli chiede cosa pensi degli ebrei, e il barone risponde che
Pfeill riferisce all’amico varie storie sul tema (compresa la tradizione che lo chiama Chidher, il Verde, guarda caso come il proprietario della “Bottega delle Meraviglie”), commentando la stranezza che subito prima gli fosse tornato alla memoria un certo ritratto visto a Leida molto tempo addietro. E descrive un volto di carnagione olivastra che l’ha perseguitato a lungo, persino nei sogni: un volto che ora inquieta l’amico perché pare descrivere proprio l’uomo dalla faccia verde incontrato. L’amico gli chiede cosa pensi degli ebrei, e il barone risponde che
“[…] Per lo più sono corvi senza penne […] Ma di tanto in tanto fra loro compaiono delle aquile, questo è certo. Per esempio Spinoza”.
“Dunque non sei antisemita”.
“Neanche per sogno. Se non altro perché non ho alcuna stima dei cristiani. […]”.
Gli ebrei esagerano troppo, i cristiani sono troppo superficiali – almeno secondo il barone. Lo scambio è particolarmente interessante a fronte delle accuse a Meyrink dei nazionalisti antisemiti.
Allontanatosi il barone, Hauberrisser tenta di darsi ragione delle strane coincidenze inanellatesi, ma la spiegazione telepatica non basta. Può trattarsi di coincidenze, e del resto, “se gli uomini che si somigliano avessero anche un destino simile?”, legato a forma del corpo e lineamenti del viso, come la vita pare confermargli. Anche l’astrologia non basta a spiegare, deve trattarsi di ben altri “pianeti che circolano nel sangue, intorno al cuore”… ma solo ora Hauberrisser nota un certo tipo vestito di bianco, con panama e monocolo. E riconosce il “professor” Zitter Arpád della “Bottega delle Meraviglie”, ora senza baffi e con capelli diversamente acconciati per chissà quali loschi traffici. Hauberrisser finge dunque di non averlo riconosciuto, neanche quando il tipo gli si presenta improbabilmente come un conte polacco, simula antichi rapporti con la famiglia di lui e racconta una serie di clamorose panzane – alle quali l’ingegnere non abbocca, mostrando scarso interesse. Poi il tipo affetta disprezzo verso gruppi di ebrei chassidim, inizia a pontificare sull’esplosione dell’isteria religiosa e di idee messianiche persino in Africa, dove sarebbe comparso un “Elia nero” operatore di miracoli… e a Mosca ha conosciuto anche un capo zulù che opera la magia grazie a un feticcio. Ora ha saputo che si trova in Olanda e lavora in un circo… ma l’ingegnere lo molla e se ne va.
 In realtà Hauberrisser è stato preso da una violenta agitazione. Camminando, si imbatte nel circo cui è aggregato Usibepu (ovviamente è lui il presunto operatore di magie del conte polacco), ma rinuncia a fermarvisi.
In realtà Hauberrisser è stato preso da una violenta agitazione. Camminando, si imbatte nel circo cui è aggregato Usibepu (ovviamente è lui il presunto operatore di magie del conte polacco), ma rinuncia a fermarvisi.
C’era nell’aria qualcosa di imponderabile, di informe, che sferzava i suoi nervi – quella stessa ansia enigmatica e velenosa che in alcuni momenti, ancor prima di partire per l’Olanda, lo aveva oppresso con forza tale da spingerlo suo malgrado ad accarezzare il pensiero del suicidio [come Pernath, ricordiamo].
Quale poteva essere l’origine di questa ricaduta?
E finisce con l’associarla all’inquietudine dei fanatici religiosi, per avendo motivazioni diverse. L’aveva avvertita già molto prima della guerra, ma era riuscito a reprimerla con lavoro e svaghi. Più tardi l’aveva interpretata come un presentimento del sanguinoso conflitto. Ma ora tornava quasi come disperazione – e un po’ tutti gli parlavano di simili emozioni. Abbastanza impressionante leggere oggi queste pagine, in paesi psicologicamente depressi come il nostro e nel confronto tra demotivazione sociale e agenzie predatorie (di cui il trasformista cialtrone Arpád è una buona rilettura letteraria). Non è neppure troppo strano che al termine della guerra la pace interiore non sia affatto tornata.
La causa era molto più profonda.
Spettri – giganteschi, informi e riconoscibili solo dalle terrificanti devastazioni che producevano –, spettri evocati all’apposito tavolo da vecchi avidi e ambiziosi durante riunioni segrete, avevano fatto milioni di vittime acquietandosi poi per qualche tempo, almeno in apparenza. Ma ora il più terribile di tutti i fantasmi, da lungo ormai in attesa, risvegliato dai miasmi di una civiltà finta, in decomposizione, sollevava appieno il suo capo di Medusa dall’abisso, e scherniva l’umanità dicendole che era stata soltanto una ruota della tortura quella che essa aveva fatto girare – e avrebbe continuato a far girare per sempre, pur conoscendone le conseguenze – nella speranza illusoria di ottenere la libertà per le generazioni a venire.
 Torniamo così idealmente all’immaginario del racconto Il gioco dei grilli e in realtà di parecchi testi anche non meyrinkiani sui presunti influssi occulti dietro la prima guerra mondiale. Ma idealmente si prepara anche il clima del successivo romanzo La notte di Valpurga.
Torniamo così idealmente all’immaginario del racconto Il gioco dei grilli e in realtà di parecchi testi anche non meyrinkiani sui presunti influssi occulti dietro la prima guerra mondiale. Ma idealmente si prepara anche il clima del successivo romanzo La notte di Valpurga.
Nelle ultime settimane Hauberrisser pareva aver superato il disgusto nei confronti della vita vagheggiandone una da eremita urbano, ma ora riaffiora il vecchio disagio. Le facce intorno non sono quelle di chi vuole divertirsi e rilassarsi, ma presentano solchi e rughe con segni di sradicamento, come i volti nelle raffigurazioni di sfrenate danze di appestati medioevali o stormi d’uccelli in preda al panico, in un abbrutimento eccitato e degradante. Mentre ruggiti e odori acri dal circo gli ricordano l’antica immagine di un’orsa incatenata in un serraglio ambulante, che ancora si pente di non aver riscattato. Forse a gridare vendetta fino al Giudizio Universale saranno gli spettri degli infiniti animali torturati dagli uomini. Ma in fondo, si domanda, lui ha mai compiuto un’azione di qualche rilevanza? Ha studiato e costruito macchine poi arrugginite (qui si può pensare al tema della macchina in I quattro fratelli della luna), dando il proprio contenuto alla generale inutilità…
È il tramonto, e l’ingegnere si fa condurre fuori Amsterdam con una vettura fin troppo lenta: arriva a vedere la campagna, i canali, mulini e pascoli, lasciando che l’inquietudine trascolori in malinconia. Mentre calano le ombre, ha la sensazione che la sua testa sia una prigione in cui è rinchiuso lui stesso: poi torna agli abitati, si fa lasciare dalla vettura e prosegue a piedi verso il suo appartamento, lungo canali maleodoranti fitti di chiatte immobili, tra gente che si raccoglie per la sera e porte che odorano di pesce e sudore, nell’opprimente desolazione dei porti olandesi (grande la suggestione pittorica di queste pagine). Per un attimo desidera di abbandonare quell’Amsterdam tanto cupa e triste per tornare a città più luminose a lui familiari, ma il senso tossico di decadenza e degrado di quelle soffoca la nostalgia.
Imbocca poi vie eleganti dove prostitute e protettori si sono ora insediati, e portieri in livrea al piano terra, mentre finestre aperte a rimorchiare clienti nei piani alti lasciano un sapore di squallore e di morte. Entra infine in un locale a metà tra il varietà volgare e il ristorante, popolato da canzonettisti e comici grotteschi e da un pubblico spiacevole. Trovando posto a un tavolo con quattro madame borghesi piuttosto stagionate: si sente additato dalla gente intorno e non capisce, tanto stordito dagli assurdi numeri dello spettacolo da ritrovarsi alla fine quasi solo nella sala. Dove fervono il traffico degli inservienti per cambiare l’aria nello spazio chiuso – con un enorme ventilatore e spruzzi di profumo – e i preparativi per l’arrivo di un altro pubblico molto più elegante, che ora riempie tutto il locale.
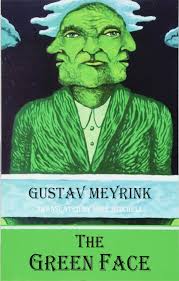 Hauberrisser si trova di nuovo al tavolo con quattro signore, ora un’anziana e tre giovani e belle russe. Intorno è il tipo di pubblico raffinato, né fatuo né profondo, che i filistei di ogni nazionalità invidiano e odiano: e a un tratto sul palco, illuminata da minuscole lampadine, appare la scritta “La Force d’Imagination!”. Uno spettacolo straniante non descritto, ma lasciato alluso, sconvolge il Nostro, che esce dal locale con un senso di orrore, “l’indistinta, soffocante paura dell’ignoto a lui da tempo familiare: l’improvvisa consapevolezza dell’inarrestabile degrado dell’umanità” (cosa ha fatto l’intrattenitore, davanti a tutti?). La scena che contrappone ai filistei un pubblico più raffinato e in fondo putrido può leggersi come sintomatica di un’avversione che conduce Meyrink più vicino allo spirito borghese da lui tanto sferzato, in una contraddizione almeno apparente ma comprensibile conoscendo la sua vita e i suoi tormenti interiori. Anche certi suoi commenti aciduli verso Thomas Mann, pure diviso tra arte e valori borghesi – e con cui dunque, in teoria, una maggiore sintonia sarebbe stata possibile – dà conto di contraddizioni mai composte, probabilmente per le amarezze di un’esistenza. Mentre – si è osservato – la visione apocalittica del Volto verde potrebbe in fondo proiettarsi nello scenario de La montagna incantata.
Hauberrisser si trova di nuovo al tavolo con quattro signore, ora un’anziana e tre giovani e belle russe. Intorno è il tipo di pubblico raffinato, né fatuo né profondo, che i filistei di ogni nazionalità invidiano e odiano: e a un tratto sul palco, illuminata da minuscole lampadine, appare la scritta “La Force d’Imagination!”. Uno spettacolo straniante non descritto, ma lasciato alluso, sconvolge il Nostro, che esce dal locale con un senso di orrore, “l’indistinta, soffocante paura dell’ignoto a lui da tempo familiare: l’improvvisa consapevolezza dell’inarrestabile degrado dell’umanità” (cosa ha fatto l’intrattenitore, davanti a tutti?). La scena che contrappone ai filistei un pubblico più raffinato e in fondo putrido può leggersi come sintomatica di un’avversione che conduce Meyrink più vicino allo spirito borghese da lui tanto sferzato, in una contraddizione almeno apparente ma comprensibile conoscendo la sua vita e i suoi tormenti interiori. Anche certi suoi commenti aciduli verso Thomas Mann, pure diviso tra arte e valori borghesi – e con cui dunque, in teoria, una maggiore sintonia sarebbe stata possibile – dà conto di contraddizioni mai composte, probabilmente per le amarezze di un’esistenza. Mentre – si è osservato – la visione apocalittica del Volto verde potrebbe in fondo proiettarsi nello scenario de La montagna incantata.
Ma quando il Nostro gira un angolo si trova davanti alla serranda abbassata della “Bottega delle Meraviglie”, in un edificio che pare un enorme teschio umano. Torna a casa domandandosi se la visione dell’uomo dal volto verde sia stata un sogno – tanto più che nel ricordo ricostruisce elementi paradossali, come il fatto che il vecchio ebreo sembrasse non posare i piedi per terra e risultare trasparente. Comincia a dubitare dei propri sensi, e vagheggia che nello spazio “ogni avvenimento che si sia verificato una volta esiste in eterno come immagine conservata nella luce”. Insomma ci sarebbe la possibilità di far rivivere il passato… e prende ad avere l’impressione che lo spettro del vecchio ebreo gli cammini accanto.
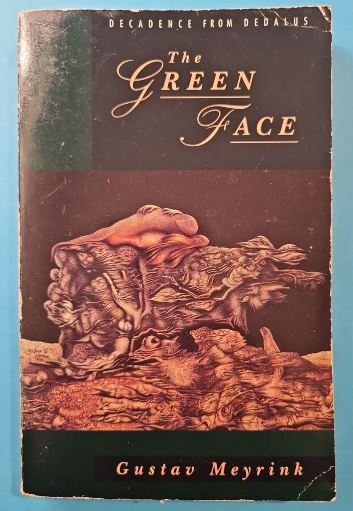 Raggiunge casa, dove è arrivato il pacchetto con il teschio di cartapesta e si corica, ma viene destato da un rumore che finisce con l’imputare a quel giochino nella scatola. Gli è caduto sul viso un rotolo “di carta fitto di caratteri sbiaditi”. Si riaddormenta, rivedendo in sogno le figure grottesche che ha incontrato negli ultimi giorni.
Raggiunge casa, dove è arrivato il pacchetto con il teschio di cartapesta e si corica, ma viene destato da un rumore che finisce con l’imputare a quel giochino nella scatola. Gli è caduto sul viso un rotolo “di carta fitto di caratteri sbiaditi”. Si riaddormenta, rivedendo in sogno le figure grottesche che ha incontrato negli ultimi giorni.
Intanto il barone va a visitare nella sua casa sontuosa l’amico ebreo dottor Sephardi (il cognome parlante richiama i sefarditi, gli ebrei della penisola iberica che, come Spinoza, avrebbero avuto un ruolo importante ad Amsterdam). Non lo vede da anni, e vorrebbe confrontare con lui alcuni ricordi sul quadro dell’Ebreo errante di cui ha parlato con Hauberrisser. Scopre allora che stranamente, dopo anni, Sephardi l’aveva cercato proprio quel giorno: e lo trova in compagnia della bellissima signorina Eva van Druysen, figlia di un amico del padre. Ancora più surrealmente, la signorina è giunta lì da Anversa per confrontarsi con Sephardi proprio sul dipinto in questione, presuntamente esposto a Leida nella collezione Oudheden: peccato che, andando sul posto, abbiano appreso che quel quadro non c’era mai stato… Perché le interessa tanto? Il fatto è che il defunto padre era ossessionato da un’apparizione che gli occupava la mente, era convinto che fosse “vicino il tempo in cui all’umanità sarebbero stati strappati gli ultimi punti d’appoggio, e una tempesta spirituale avrebbe spazzato via qualsiasi cosa che mano d’uomo avesse mai costruito”. Si salverà solo – diceva – chi avesse visto “dentro di sé il volto verde bronzeo del Precursore, dell’Uomo primordiale, di colui che mai assaporerà la morte”. Che non è uno spettro, ma anche se si presentasse così, in realtà è l’unico uomo sulla terra che non può essere definito tale. La sua benda nera in fronte nasconderebbe il simbolo della vita eterna, invece che mostrarlo come Caino: “Non posso dirti se sia Dio; non lo capiresti”. Passati gli anni, allo scoppiare della guerra la giovane aveva pensato che la tempesta spirituale evocata dal padre si riferisse a quell’evento: no, spiega Sephardi, la guerra ha solo diviso l’umanità in due fronti che non possono più capirsi, chi ha visto l’inferno e chi la riduce a inchiostro da stampa – e il dottore ammette di trovarsi tra questi ultimi. In effetti la giovane pensa che il padre si riferisse al non-poter-vivere-e-non-poter-morire che affligge ora il mondo (una suggestione, per inciso, che pare emergere in tutte le epoche di forte ridefinizione del mondo: si pensi solo alla Ballata del vecchio marinaio di Coleridge, 1798, con la sinistra partita a dadi tra Morte e Vita-in-Morte).
 Parlando col dottore è dunque emerso il discorso del famoso ritratto che pare non esistere, a dispetto della memoria del barone – che per questo è venuto dal dottore, davvero gliel’aveva descritto anni prima? Veniva forse da un suo sogno? un tempo quell’immagine lo perseguitava… il dottore sospetta che il volto fosse emerso a Pfeill in stato ipnotico, a rivelargli quella “seconda vita, eterna” vissuta solo nel sonno profondo e dimenticata da svegli. La “rinascita” di cui parlano i mistici cristiani gli pare un risveglio dell’Io in un regno indipendente dai sensi esterni.
Parlando col dottore è dunque emerso il discorso del famoso ritratto che pare non esistere, a dispetto della memoria del barone – che per questo è venuto dal dottore, davvero gliel’aveva descritto anni prima? Veniva forse da un suo sogno? un tempo quell’immagine lo perseguitava… il dottore sospetta che il volto fosse emerso a Pfeill in stato ipnotico, a rivelargli quella “seconda vita, eterna” vissuta solo nel sonno profondo e dimenticata da svegli. La “rinascita” di cui parlano i mistici cristiani gli pare un risveglio dell’Io in un regno indipendente dai sensi esterni.
Si noti che il volto verde richiamato ossessivamente nel romanzo vi risulta un simbolo esoterico
straordinariamente diversificato: essa possiede un aspetto positivo ed un aspetto negativo che è esaminato, compreso e spiegato in modi estremamente differenti dai diversi personaggi del romanzo in funzione della loro origine e del loro grado di evoluzione interiore, senza che, tuttavia, tali spiegazioni si escludano l’una con l’altra. Piuttosto, a volte si completano, ed altre testimoniano anche della tendenza sincretica di un atteggiamento esoterico.
[…] la faccia non appare soltanto ad Hauberrisser. Essa agisce piuttosto come un campione di valore supremo, infallibile, la cui apparizione (e non-apparizione), mutevole per stile ed intensità, può fornire al lettore chiavi sicure sullo stato e la natura dello sviluppo interiore di tutti i personaggi. [Joseph Strelka, “La faccia verde”, cit.]
Classico del resto dell’esoterismo non è solo un atteggiamento di tipo sincretico ma un procedere per aggregazione astorica di dati, fattispecie “simili” eccetera. D’altronde occorrerebbe considerare l’ipotesi che l’accumulo di significati differenti del simbolo usato da Meyrink rispondesse anche a una logica narrativa, letteraria, di suggestione ricorrente e appunto ossessiva, ipnotica: l’enfasi sul romanzo esoterico qui non è senza basi, ma occorre non dimenticare che comunque si tratta di un romanzo.
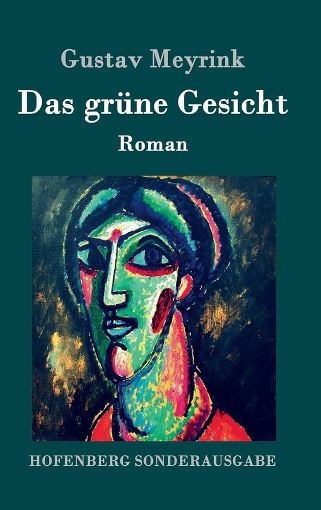 A proposito di mistici cristiani, Sephardi annuncia che lui e la signorina quella sera andranno a una riunione di un gruppo confessionista, nello Zee Dyk (ora non più quartiere di malavita ma di tranquilli artigiani: c’è solo una bettola malfamata, la “Prins van Oranje”, e dovremo entrarvi). L’invito arriva da un vecchio eccentrico collezionista di farfalle, tale Jan Swammerdam, che crede di essere il re Salomone (il nome si ispira a quello di un famoso naturalista di Amsterdam). La zia della ragazza, signorina de Bourignon, dama di carità del convento delle beghine – l’ennesima beghina ridicola della produzione di Meyrink –, va da lui tutti i giorni. Pfeill si stupisce che Swammerdam sia ancora vivo, racconta di averlo frequentato da ragazzino quando catturava rettili, anfibi e insetti – guadagnandosi l’ingresso in una società entomologica – e il poverissimo Swammerdam era più abile di lui nella caccia. Il vecchio aveva la fissazione di poter catturare un certo tipo di scarabeo stercorario verde, e i ragazzini si divertivano a seminare falsi indizi con sterco di pecora: ma un giorno, il falso non aveva impedito che lui trovasse davvero l’insetto. La moglie morta gli era apparsa nel sonno assicurandogli che l’avrebbe trovato… e alla commozione di lui, i monelli si erano sentiti in colpa.
A proposito di mistici cristiani, Sephardi annuncia che lui e la signorina quella sera andranno a una riunione di un gruppo confessionista, nello Zee Dyk (ora non più quartiere di malavita ma di tranquilli artigiani: c’è solo una bettola malfamata, la “Prins van Oranje”, e dovremo entrarvi). L’invito arriva da un vecchio eccentrico collezionista di farfalle, tale Jan Swammerdam, che crede di essere il re Salomone (il nome si ispira a quello di un famoso naturalista di Amsterdam). La zia della ragazza, signorina de Bourignon, dama di carità del convento delle beghine – l’ennesima beghina ridicola della produzione di Meyrink –, va da lui tutti i giorni. Pfeill si stupisce che Swammerdam sia ancora vivo, racconta di averlo frequentato da ragazzino quando catturava rettili, anfibi e insetti – guadagnandosi l’ingresso in una società entomologica – e il poverissimo Swammerdam era più abile di lui nella caccia. Il vecchio aveva la fissazione di poter catturare un certo tipo di scarabeo stercorario verde, e i ragazzini si divertivano a seminare falsi indizi con sterco di pecora: ma un giorno, il falso non aveva impedito che lui trovasse davvero l’insetto. La moglie morta gli era apparsa nel sonno assicurandogli che l’avrebbe trovato… e alla commozione di lui, i monelli si erano sentiti in colpa.
La scena successiva vede il dottor Sephardi ed Eva van Druysen raggiungere la “nuova Gerusalemme” dei devoti, dove la zia di lei li saluta come re Baldassarre ed Eva. Ci sono Jan Swammerdam (“re Salomone”) e la sorella (“Sulamith”), il vicino di casa Lazarus Eidotter (“Simone il crocifero”, un vecchio ebreo russo), la signorina Mary Faatz dell’Esercito della Salvezza (“Maria Maddalena”), un giovane commesso butterato della drogheria di sotto (“Ezechiele”) – mentre la zia si presenta come “Gabriella, la forma femminile dell’arcangelo Gabriele”. Relativizzando le amenità devote della consorella, Swammerdam racconta che in quella casa c’è un vero profeta, il calzolaio Anselm Klinkherbogk (detto a sua volta, scopriremo più tardi, “Abram”); rimarca che non sono spiritisti – le cui idee Meyrink disprezza –, ma assorbono la forza dei nomi spirituali che recano, e presentano (tutti, meno Lazarus Eidotter) sorta di stimmate che la signorina van Druysen richiama all’isteria, ma lui spiega come di tipo non patologico. Poi Swammerdam presenta il caso di Klinkherbogk, e come un evento mistico gli abbia donato la “Parola Interiore” (che palesa la verità in una lingua misteriosa): Sephardi è scettico su simili profezie del subconscio, ma poi ripensa alla storia dell’insetto verde e tace. Nel clima sovraeccitato emergono notizie e siparietti improbabili – Eidotter resuscitato da “Abram”, ma forse aveva solo perso i sensi; “Ezechiele” che cade in trance profetizzando per il Logos, ma in realtà sembrano crisi di abbrutimento per la vita che conduce… ed Eva si rende conto della fatica di un’anima nell’ambito di una classe sociale non privilegiata. Come osserva la zia, “Melchiorre” è il barone Pfeill che aveva mandato soldi tramite la nipotina del calzolaio, e il re dei Mori “Gaspare” (che si rivelerà Usibepu) non è lontano; ma la nipotina ora annuncia che devono andare di sopra, dove “il nonno sta vivendo la seconda nascita”.
 Segue un dialogo mistico molto profondo di Eva con Swammerdam, che la invita a interpellare il proprio spirito, l’intervento altrui è fuorviante. La meta è vedere se stessi con gli occhi di Dio, liberi da logiche di prove e punizioni, in vista di un progetto di guarigione interiore. Ma per giungere più rapidamente alla grande meta, occorre ordinare alla propria più intima essenza di guidare senza soste per la via più breve. Eva chiede cosa succederebbe se lei volesse a un certo punto tornare indietro da quel percorso mistico, e lui la esorta a non far troppi giuramenti, a non prendersi troppi impegni solenni. Del resto i voti, spiega lui, possono essere stati presi in una vita precedente o persino nel sonno profondo. Ed Eva medita che “Ogni lamentela riguardo alla presunta ingiustizia del destino doveva ammutolire di fronte al pensiero che ciascuno percorreva soltanto la strada che si era scelto”.
Segue un dialogo mistico molto profondo di Eva con Swammerdam, che la invita a interpellare il proprio spirito, l’intervento altrui è fuorviante. La meta è vedere se stessi con gli occhi di Dio, liberi da logiche di prove e punizioni, in vista di un progetto di guarigione interiore. Ma per giungere più rapidamente alla grande meta, occorre ordinare alla propria più intima essenza di guidare senza soste per la via più breve. Eva chiede cosa succederebbe se lei volesse a un certo punto tornare indietro da quel percorso mistico, e lui la esorta a non far troppi giuramenti, a non prendersi troppi impegni solenni. Del resto i voti, spiega lui, possono essere stati presi in una vita precedente o persino nel sonno profondo. Ed Eva medita che “Ogni lamentela riguardo alla presunta ingiustizia del destino doveva ammutolire di fronte al pensiero che ciascuno percorreva soltanto la strada che si era scelto”.
Swammerdam la invita comunque a non preoccuparsi se non trovasse alcun senso nelle attività del loro gruppo: a volte un sentiero scende verso il basso ma è la via più breve per salire, a volte “la febbre della guarigione spirituale assume l’aspetto di una diabolica putrefazione”. E anche il mischione di Antico e Nuovo Testamento dei loro nomi spirituali non è senza senso, in quanto cammino da Adamo a Cristo… Per capire queste scene, va detto che Meyrink considera il fanatismo religioso come parallelo al materialismo, e paragona le due posizioni a Scilla e Cariddi; ma mantiene la cifra della complessità lasciando il problematico, sensibile e profondo Swammerdam in compagnia di figuri ridicoli o tragici (come il veggente Klinkherbogk, un Laponder meno profondo e sopra le righe alla deriva di trance pericolose, dove Meyrink critica esperienze pneumatiche d’epoca). Nei fatti, i nomi spirituali proclamati con troppa disinvoltura dalla zia di Eva, finiranno con il rivelare una propria mistica fatalità… A quanto pare, per questo gruppo surreale Meyrink si ispira al circolo mistico di Darmstadt ispirato dall’opera del calzolaio Jacob Böhme (1575-1624) e del cantante lirico, direttore d’orchestra massone Johann Baptist Krebs (noto con gli pseudonimi Johann Baptist Kerning e JM Gneiding, 1774-1851), il cui esercizi di yoga praticati da Meyrink per anni gli avrebbero alla fine recato danni fisici.
Davanti alla porta della soffitta la caricaturale signorina de Bourignon si bea del sorgere nel padre “Adam” dell’uomo spirituale proprio in quel solstizio d’estate: il calzolaio ha infatti sentito piangere dentro di sé, sintomo di “seconda nascita”. Klinkherbogk siede al tavolo da lavoro, davanti alla boccia di vetro da artigiano, e le persone affluite – compresi Eva e Sephardi – lo osservano: il profeta fissa il globo di vetro, poi cita alcune parole bibliche dall’episodio di Sodoma e infine emette una profezia calamitosa, triste anche verso se stesso, prima di ricadere in estasi.
 Intanto nella losca osteria “Prins van Oranje”, dove sta la sformata cameriera Antje, detta (in onta a ogni preoccupazione di body shaming) la “scrofa del porto”, cinque figuri si sono riuniti a un tavolo. C’è il padrone, ex-timoniere; lo zulù Usibepu; un agente di varietà “gobbo e con dita simili a zampe di ragno, lunghe e orribili”; il losco professor Zitter Arpád, con abiti adatti al locale; un “indiano” in smoking bianco, figlio di un proprietario terriero dalle colonie, che vive lì ed è sveglio solo di notte per giocare e bere, perdendo sempre di più. Fino a mezzanotte sono costretti dalle dinamiche tra loro a giocare onestamente (del resto l’“indiano” è troppo ingenuo per barare, e lo zulù conosce troppo poco i segreti della magia bianca), ma a quel punto l’attenzione cala e i due extraeuropei vengono rapidamente depredati.
Intanto nella losca osteria “Prins van Oranje”, dove sta la sformata cameriera Antje, detta (in onta a ogni preoccupazione di body shaming) la “scrofa del porto”, cinque figuri si sono riuniti a un tavolo. C’è il padrone, ex-timoniere; lo zulù Usibepu; un agente di varietà “gobbo e con dita simili a zampe di ragno, lunghe e orribili”; il losco professor Zitter Arpád, con abiti adatti al locale; un “indiano” in smoking bianco, figlio di un proprietario terriero dalle colonie, che vive lì ed è sveglio solo di notte per giocare e bere, perdendo sempre di più. Fino a mezzanotte sono costretti dalle dinamiche tra loro a giocare onestamente (del resto l’“indiano” è troppo ingenuo per barare, e lo zulù conosce troppo poco i segreti della magia bianca), ma a quel punto l’attenzione cala e i due extraeuropei vengono rapidamente depredati.
Ma Arpád vuole soprattutto carpire a Usibepu il segreto della camminata sui carboni ardenti, oltre a guardare con interesse la notizia che il calzolaio Klinkherbogk si sia fatto cambiare all’osteria un biglietto da mille fiorini. Reso euforico dall’alcool, dalla cena e dalla presenza della cameriera, Usibepu rischia d’essere accoltellato dai marinai gelosi di Antje. Circa i carboni ardenti, sfidato dal professore, dà prova delle proprie capacità: scivola in una grottesca trance, si mette nudo a danzare, poi impallidisce e si piazza immobile sui tizzoni – da cui alla fine esce illeso.
A quel punto “Maria Maddalena” viene a convocare l’africano per la riunione del gruppo religioso dal calzolaio. Zitter Arpád allunga le orecchie (è il tipo dei mille fiorini) e cerca di porre domande a Usibepu, affettando conoscenze di cultura africana che tuttavia quello demolisce. Lui non è iniziato alla magia Obeah T’changa, spiega, ma è un grande stregone Vidû T’changa, “serpente verde velenoso Vidû”, che non è un serpente animale: “serpente verde degli spiriti con volto di uomo. Serpente Vidû è un Souquiant. Suo nome Zombi”. Zitter Arpád che non capisce più niente e chiede lumi. Usibepu spiega:
Souquiant è un uomo che può cambiare pelle. Vive in eterno. Uno spirito. Invisibile. Può fare ogni magia. Zombi era il padre dei neri. Gli zulù suoi figli prediletti. Discesi dal suo lombo sinistro. […] Ogni re zulù conosce nome segreto di Zombi. Quando lo invoca Zombi appare come grande serpente velenoso Vidû con volto verde di uomo e sacro segno su fronte. Se zulù vede Zombi per la prima volta e Zombi ha faccia velata, allora zulù deve morire; ma se Zombi appare con segno su fronte coperto e volto verde scoperto, allora zulù vive ed è Vidû T’changa, grande stregone e signore del fuoco. Io, Usibepu, Vidû T’changa.
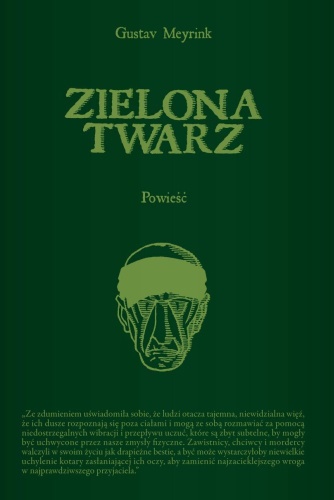 Ai fini del romanzo, non è così importante entrare nello specifico del discorso. Meyrink attinge ai dati antropologici delle ricerche d’epoca, e può non essere immediato riportare i dati a quanto troviamo oggi documentato (si pensi solo all’uso del termine Zombi, qui non un cadavere vivente come oggi di solito inteso). Più utile rifarsi a testi di riviste occultistiche d’epoca, come l’articolo Obeah Wanga, in “Light. Journal of Psychical, Occult and Mystical Research”, 9 novembre 1895: Obeah (“che uccide”, in sostanza uno stregone) indica pratiche magiche e religiose originarie dell’Africa centrale e occidentale, ricollegabili dunque ai sincretismi d’oltre Atlantico, e implicanti rapporti con tre tipi di entità, cioè revenant, zombi (intesi però spesso come spiriti), e Souquinant, spiriti separati dai corpi di appartenenza. L’Obeah vede in azione una sola persona, “mentre T’changa richiede i poteri uniti di un uomo e una donna, che agiscono in presenza di un Totem o Feticcio, nella forma di un Serpente Sacro” (ibidem). Quanto a Souquiant, sembra accedere alla costellazione onomastica di Soucouyant, Soucouyans, Soucriant, Sukuyâ eccetera, di assonanza francese e in uso specialmente nel folklore sincretico caraibico per un mutaforma. In sostanza Usibepu si sente offeso dall’essere etichettato come Obeah T’changa, stregone cattivo, mentre richiama i suoi poteri al più nobile Vidû, “attratto” nella simbolica del Volto verde.
Ai fini del romanzo, non è così importante entrare nello specifico del discorso. Meyrink attinge ai dati antropologici delle ricerche d’epoca, e può non essere immediato riportare i dati a quanto troviamo oggi documentato (si pensi solo all’uso del termine Zombi, qui non un cadavere vivente come oggi di solito inteso). Più utile rifarsi a testi di riviste occultistiche d’epoca, come l’articolo Obeah Wanga, in “Light. Journal of Psychical, Occult and Mystical Research”, 9 novembre 1895: Obeah (“che uccide”, in sostanza uno stregone) indica pratiche magiche e religiose originarie dell’Africa centrale e occidentale, ricollegabili dunque ai sincretismi d’oltre Atlantico, e implicanti rapporti con tre tipi di entità, cioè revenant, zombi (intesi però spesso come spiriti), e Souquinant, spiriti separati dai corpi di appartenenza. L’Obeah vede in azione una sola persona, “mentre T’changa richiede i poteri uniti di un uomo e una donna, che agiscono in presenza di un Totem o Feticcio, nella forma di un Serpente Sacro” (ibidem). Quanto a Souquiant, sembra accedere alla costellazione onomastica di Soucouyant, Soucouyans, Soucriant, Sukuyâ eccetera, di assonanza francese e in uso specialmente nel folklore sincretico caraibico per un mutaforma. In sostanza Usibepu si sente offeso dall’essere etichettato come Obeah T’changa, stregone cattivo, mentre richiama i suoi poteri al più nobile Vidû, “attratto” nella simbolica del Volto verde.
Zitter Arpád non sa che farsi di quelle spiegazioni, ma si offre a “Maria Maddalena” come interprete con l’africano: lei però non è interessata, riesce a farsi capire egualmente da Usibepu e lo conduce all’alloggio del calzolaio. Questi ricade in stato di sonnambulismo: ed è in tale momento sospeso, quando Eva ha “l’impressione che un angelo sterminatore stesse emergendo tastoni dalla terra” che all’aprirsi lento della porta compare l’immagine del nero. Ma il calzolaio scatta in piedi rantolando che è lì di nuovo “il Terribile, con la maschera verde sul volto, colui che mi ha dato il nome di Abram e il libro da ingoiare” (si pensi al libro inghiottito in Apocalisse 10, 8-10) e ricade a sedere. Usibepu commenta allora che “Il Souquiant è dietro di lui” – poi il silenzio cala. Eva è terrorizzata, ha “la sensazione che un essere invisibile stesse attraversando la stanza con orrenda lentezza”. L’apparizione della gazza parlante Jakob non migliora la situazione… ma alla fine lasciano lì il calzolaio in trance con la nipotina addormentata, spingendo fuori anche Usibepu che ha adocchiato i soldi del veggente. Chiudono la porta a chiave.
 Klinkherbogk sta sognando di traversare il deserto in groppa a un asino, con la piccola Katje (“Isacco”) al fianco e preceduto da un uomo dal volto velato. Nel sogno sacrifica la bambina come Abramo sta per fare con Isacco, e a quel punto l’uomo che li guidava svela il proprio volto: lo fa perché lui abbia la vita eterna, ma insieme cancella dalla propria fronte il simbolo della vita perché quella vista non consumi più la mente del calzolaio. “Poiché la mia fronte è la tua fronte e il mio volto è il tuo volto. In questo, sappilo, consiste la ‘seconda nascita’: tu sarai con me una cosa sola e riconoscerai che la tua guida verso l’albero della vita sei stato tu stesso”. Molti hanno visto il suo volto ma ignorano che quella sia la “seconda nascita”. Certo, la morte verrà a lui ancora una volta prima del passaggio della porta stretta, ma poi entrerà nel regno: e a quel punto “Abram” vede che il volto dell’interlocutore è di oro verde e riempie l’intero cielo (inevitabile ricordare, sia pure con diversi sottotesti simbolici, il finale de Il gioco dei grilli). Ma, allo sparire dell’uomo, lentamente torna in sé, trovandosi in mano la lesina insanguinata del suo lavoro, e nella penombra il corpo della nipotina che in stato sonnambulico ha ucciso con un colpo mortale. In preda all’angoscia vorrebbe farla finita e trova la porta chiusa dall’esterno; ma dalla catena che pende dalla parete esterna Usibepu, attratto dal denaro, si arrampica e balza nella stanza. Il veggente, alla deriva del ricordo del sogno, stende le braccia verso l’uomo che ha fatto irruzione: questo, terrorizzato, si avventa su di lui e gli spazza il collo. Poi si riempie le tasche dell’oro del calzolaio, e ne getta il corpo nel canale sottostante. L’immagine negativa del nero (ne ritroveremo un’eco ne La notte di Valpurga) risponde a stereotipi diffusi tra Otto e Novecento, da Poe a Verne a Stoker a tanti altri, e non stupisce – di certo non è in sé un marcatore ideologico che rimandi alle speculazioni razziali tanto care a certa destra italiota. D’altra parte, come vedremo, anche su Usibepu, Meyrink ci riserverà delle grosse sorprese.
Klinkherbogk sta sognando di traversare il deserto in groppa a un asino, con la piccola Katje (“Isacco”) al fianco e preceduto da un uomo dal volto velato. Nel sogno sacrifica la bambina come Abramo sta per fare con Isacco, e a quel punto l’uomo che li guidava svela il proprio volto: lo fa perché lui abbia la vita eterna, ma insieme cancella dalla propria fronte il simbolo della vita perché quella vista non consumi più la mente del calzolaio. “Poiché la mia fronte è la tua fronte e il mio volto è il tuo volto. In questo, sappilo, consiste la ‘seconda nascita’: tu sarai con me una cosa sola e riconoscerai che la tua guida verso l’albero della vita sei stato tu stesso”. Molti hanno visto il suo volto ma ignorano che quella sia la “seconda nascita”. Certo, la morte verrà a lui ancora una volta prima del passaggio della porta stretta, ma poi entrerà nel regno: e a quel punto “Abram” vede che il volto dell’interlocutore è di oro verde e riempie l’intero cielo (inevitabile ricordare, sia pure con diversi sottotesti simbolici, il finale de Il gioco dei grilli). Ma, allo sparire dell’uomo, lentamente torna in sé, trovandosi in mano la lesina insanguinata del suo lavoro, e nella penombra il corpo della nipotina che in stato sonnambulico ha ucciso con un colpo mortale. In preda all’angoscia vorrebbe farla finita e trova la porta chiusa dall’esterno; ma dalla catena che pende dalla parete esterna Usibepu, attratto dal denaro, si arrampica e balza nella stanza. Il veggente, alla deriva del ricordo del sogno, stende le braccia verso l’uomo che ha fatto irruzione: questo, terrorizzato, si avventa su di lui e gli spazza il collo. Poi si riempie le tasche dell’oro del calzolaio, e ne getta il corpo nel canale sottostante. L’immagine negativa del nero (ne ritroveremo un’eco ne La notte di Valpurga) risponde a stereotipi diffusi tra Otto e Novecento, da Poe a Verne a Stoker a tanti altri, e non stupisce – di certo non è in sé un marcatore ideologico che rimandi alle speculazioni razziali tanto care a certa destra italiota. D’altra parte, come vedremo, anche su Usibepu, Meyrink ci riserverà delle grosse sorprese.
Lontano dal teatro di tanta atrocità, Hauberrisser si sveglia, e scopre che il rotolo di carta cadutogli sul viso nella notte era stato lasciato in un ripiano sopra il letto da un precedente inquilino. Presenta un testo quasi illeggibile per inchiostro sbiadito e muffe da umido. Quel che resta pare tuttavia l’abbozzo di un lavoro letterario, senza nome né data: e sembra emergervi a un certo punto il nome fatale di Chidher Grün, per cui l’ingegnere resta terrorizzato. Diffidando di se stesso, dalla governante signora Ohms apprende che il precedente inquilino era un uomo molto ricco e strambo, poi la casa è rimasta vuota per parecchio tempo. Da quanto si legge nel manoscritto, la storia è quella di un uomo che lotta contro la sfortuna, pessimista come l’ingegnere: ma pur considerando una generale mancanza di progresso dell’umanità – che a grandi numeri gira in tondo – l’ignoto autore deve ammettere come alcuni individui abbiano invece saputo fare passi avanti. 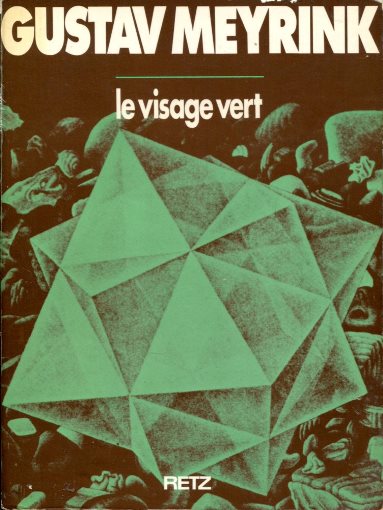 Purtroppo l’impossibilità di leggere lo scritto nella sua totalità rende impossibile capire come c’entri Chidher Grün: ma al pensiero di recarsi alla “Bottega” e interpellare il vecchio ebreo, Hauberrisser si domanda che colpa ne abbia costui, se il suo nome lo “perseguita come un coboldo”. Si chiede anzi se davvero gli importi della faccenda, e il disgusto della vita si riaffaccia in lui: così chiude a chiave il misterioso manoscritto, meno una pagina su cui legge il nome Chidher Grün, e che infila nel portafogli. Ma a quel punto arriva un telegramma dell’amico Pfeill che lo invita a un tè purtroppo fin troppo frequentato (e dove sospetta s’infilerà anche il finto conte polacco).
Purtroppo l’impossibilità di leggere lo scritto nella sua totalità rende impossibile capire come c’entri Chidher Grün: ma al pensiero di recarsi alla “Bottega” e interpellare il vecchio ebreo, Hauberrisser si domanda che colpa ne abbia costui, se il suo nome lo “perseguita come un coboldo”. Si chiede anzi se davvero gli importi della faccenda, e il disgusto della vita si riaffaccia in lui: così chiude a chiave il misterioso manoscritto, meno una pagina su cui legge il nome Chidher Grün, e che infila nel portafogli. Ma a quel punto arriva un telegramma dell’amico Pfeill che lo invita a un tè purtroppo fin troppo frequentato (e dove sospetta s’infilerà anche il finto conte polacco).
Da una carrozza si fa condurre nella Jodenbreetstraat, e insomma attraverso la Judenbuurt del ghetto – di cui viene offerta una vivida descrizione – giunge infine alla “Bottega delle Meraviglie”. Alla sua richiesta di parlare col principale, la commessa comunica che “il professore è partito ieri per un periodo di tempo indeterminato” ma Hauberrisser non stava chiedendole del ciarlatano balcanico: vorrebbe parlare qualche minuto con il vecchio signore ebreo dietro lo scrittoio. Lei ribatte che quella è una ditta cristiana, “gli ebrei non sono ammessi” e non ce n’era nessuno. Lui domanda allora chi sia il Chidher Grün citato nell’insegna, la ragazza ribatte allibita che il nome riportato è Zitter Arpád: e, uscito a controllare, Hauberrisser deve ammettere che è proprio così, la commessa ha ragione…
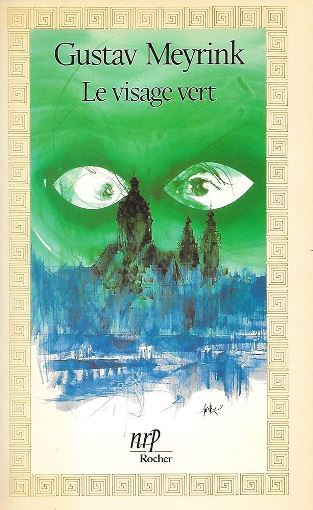 Confuso al punto da dimenticare lì il bastone da passeggio, l’ingegnere esce e si perde nei vicoli, tra edifici storti (pensiamo a quelle del Caligari), botteghe, cortili deserti dove “Tutto era come morto”. A un tratto si siede a riflettere domandandosi come sia possibile che lui, in fondo abbastanza giovane, ragioni come un vecchio. Fin oltre i trent’anni era stato schiavo delle passioni, ma forse la riflessività che gli era cresciuta dentro in modo nascosto. Recupera dunque la pagina del manoscritto dal portafogli, e che trova singolare corrispondenza con le proprie meditazioni. La voce narrante considerava la propria ignoranza di essere stata padrona del proprio destino senza saperlo, per aver “sottovalutato la magica potenza dei pensieri”, considerando “l’azione un gigante e il pensiero una chimera. Ora, chi impara a muovere la luce può manovrare le ombre, e con loro il destino; chi cerca di ottenere ciò tramite le azioni è soltanto un’ombra che combatte inutilmente con le ombre”. Ma tutto questo viene generalmente poco capito: “È l’ambiguità della lingua che ci separa. […] noi osserviamo i precetti quando dovremmo infrangerli e li infrangiamo quando dovremmo osservarli”. Gli uomini troppo spesso sono “accecati da una falsa umiltà, che li fa indietreggiare terrorizzati e barcollanti come bambini dinanzi alla propria immagine riflessa, e temono di essere folli quando giunge l’ora… e il suo volto li guarda”.
Confuso al punto da dimenticare lì il bastone da passeggio, l’ingegnere esce e si perde nei vicoli, tra edifici storti (pensiamo a quelle del Caligari), botteghe, cortili deserti dove “Tutto era come morto”. A un tratto si siede a riflettere domandandosi come sia possibile che lui, in fondo abbastanza giovane, ragioni come un vecchio. Fin oltre i trent’anni era stato schiavo delle passioni, ma forse la riflessività che gli era cresciuta dentro in modo nascosto. Recupera dunque la pagina del manoscritto dal portafogli, e che trova singolare corrispondenza con le proprie meditazioni. La voce narrante considerava la propria ignoranza di essere stata padrona del proprio destino senza saperlo, per aver “sottovalutato la magica potenza dei pensieri”, considerando “l’azione un gigante e il pensiero una chimera. Ora, chi impara a muovere la luce può manovrare le ombre, e con loro il destino; chi cerca di ottenere ciò tramite le azioni è soltanto un’ombra che combatte inutilmente con le ombre”. Ma tutto questo viene generalmente poco capito: “È l’ambiguità della lingua che ci separa. […] noi osserviamo i precetti quando dovremmo infrangerli e li infrangiamo quando dovremmo osservarli”. Gli uomini troppo spesso sono “accecati da una falsa umiltà, che li fa indietreggiare terrorizzati e barcollanti come bambini dinanzi alla propria immagine riflessa, e temono di essere folli quando giunge l’ora… e il suo volto li guarda”.
Le frasi recano sollievo al Nostro. E in fondo, riflette, gli strani eventi legati al nome di Chidher Grün fanno di lui un fortunato. Pregusta le lettura del manoscritto ma ora deve correre al tè dell’amico. E succede qualcosa di curioso: non lontano dalla panchina gli appare, con la sua tuta, quel che risulterà l’apicultore del convento, “Lo sciame gli era scappato ma ora ha ripreso la regina”.
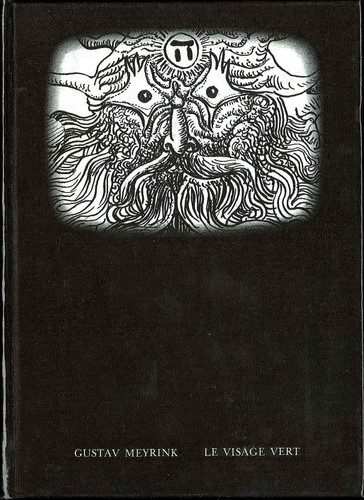 La storia proseguirà ancora a lungo, ma già è chiara sul piano stilistico l’enfasi espressionistica sul grottesco, i personaggi “caricati”, le visioni fantastiche, il tessuto di allegorie, metafore e simboli, con una serie di temi come la città mostruosa. Si è osservato come il primo capitolo, alla “Bottega delle Meraviglie”, costituisca in fondo una grande metafora del mondo, e i primi capitoli evocano il sapore di calamità che grava su tutto un orizzonte d’epoca.
La storia proseguirà ancora a lungo, ma già è chiara sul piano stilistico l’enfasi espressionistica sul grottesco, i personaggi “caricati”, le visioni fantastiche, il tessuto di allegorie, metafore e simboli, con una serie di temi come la città mostruosa. Si è osservato come il primo capitolo, alla “Bottega delle Meraviglie”, costituisca in fondo una grande metafora del mondo, e i primi capitoli evocano il sapore di calamità che grava su tutto un orizzonte d’epoca.
L’ingegnere si avvia, giunge a una piazza e si fa condurre da un’auto a casa dell’amico. Tra le mille immagini sfreccianti lungo il percorso una sola gli resta fissa negli occhi, quella dello sciame recuperato attorno alla regina. Un simbolo: così in fondo, pensa, il suo corpo è uno sciame di cellule attorno a un nucleo nascosto. Se riuscirà a vedere sotto una luce nuova le cose rese mute dall’abitudine, si dice, il mondo risorgerà davanti ai suoi occhi.
(6-continua)
