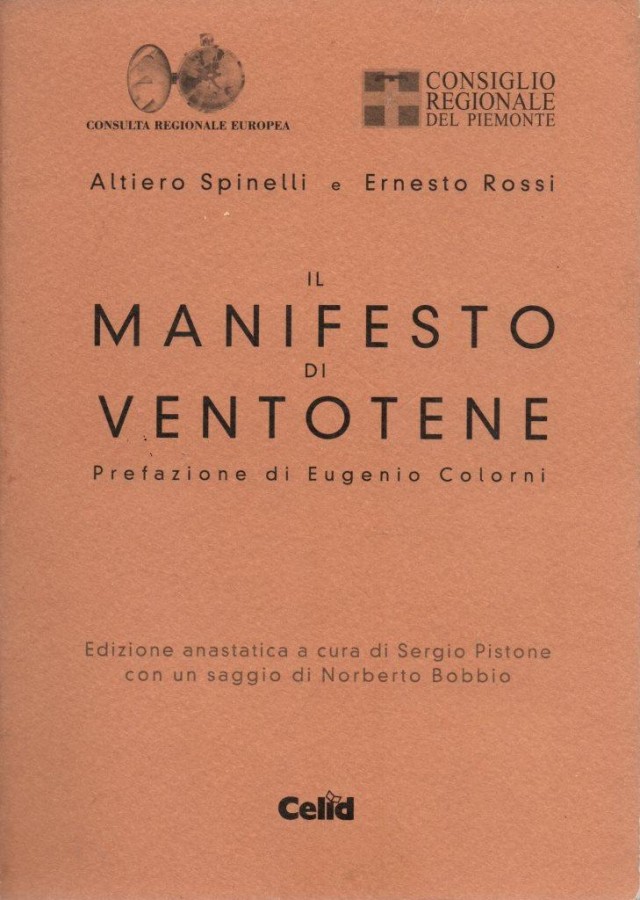
Di Davide Amerio
Meloni contro il Manifesto di Ventotene. La sinistra (PD) insorge. Baruffe, commenti, pro e contro il manifesto: da alcuni vissuto come testo fondante dell’Unione Europea, da altri come elemento che racchiude in sé il pensiero ordoliberista su cui si fonda tutta l’attuale economia. Chi ha ragione e chi ha torto?
Chi ha assolutamente torto.
Iniziamo dal punto più semplice: chi ha assolutamente torto si chiama Giorgia Meloni & C. Solamente il coraggio della sfacciataggine di questo modus operandi dei politicanti italiani può prendere un Manifesto, scritto nel 1941 (dagli antifascisti Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, e Eugenio Colorni), estrapolarne alcune frasi e utilizzarle per una propaganda personale. Ma questa è la tipica azione di mistificazione con cui procede la politica a corto di idee che, necessariamente, deve distruggere le posizioni degli “avversari”. Già nel suo incipit la Meloni parla facendo spallucce di fronte alla parola “Socialismo”, e questo la dice lunga su politici che “giurano” fedeltà alla Costituzione Italiana, di fatto ignorando che proprio essa contiene quei principi di Socialismo Liberale di cui Colorni fu pregevole rappresentante (ammazzato -guarda caso- dai fascisti nel 1944).
Il Manifesto di Ventotene.
Per comprendere il senso di quel manifesto, e darne un giudizio attualizzato, non si può prescindere dal contesto storico nel quale venne elaborato, quali erano gli obbiettivi degli autori, quale era la storia personale degli autori che composero quel testo. Sugli autori:
[…] Spinelli e Rossi non erano comunisti, ma esponenti della sinistra antifascista critica verso lo stalinismo e l’Unione Sovietica. Spinelli aveva fatto parte del Partito Comunista fino al 1937, poi ne era uscito. Rossi aveva idee liberali ed era tra i fondatori del movimento Giustizia e Libertà (di cui furono leader Carlo Rosselli e, dopo il suo assassinio insieme al fratello Nello, Emilio Lussu). Entrambi, durante la Resistenza e l’immediato dopoguerra, avrebbero aderito al Partito d’Azione (in seguito Rossi fondò il Partito Radicale nel 1955, mentre Spinelli fu eletto deputato ed eurodeputato da indipendente nelle liste del PCI). Il Manifesto fu scritto con contributi di Colorni e di altri antifascisti non comunisti in un momento in cui quasi tutta l’Europa continentale era occupata dalla Germania nazista. […] (1)
Il contesto storico è quindi quello di una Europa devastata da due guerre mondiali, e in cui quasi tutto il continente europeo era sotto l’oppressione del regime Nazista. La distruzione non era solamente materiale, ma anche intellettuale: come era stato possibile l’accadere di due guerre terribili causate dalla Germania? Perché il pensiero democratico e liberale aveva fallito nel prevenire tanta barbarie?
Senza addentrarci troppo in vicende storiche complesse, rimaniamo focalizzati su Ventotene e sulla risposta che in molti diedero alle cause scatenanti delle guerre. Lo possiamo rilevare nella prima parte del Manifesto che, non a caso, titola “La crisi della civiltà moderna” (2):
La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita […]
Si è affermato l’eguale diritto a tutte le nazioni di organizzarsi in stati indipendenti. Ogni popolo, individuato nelle sue caratteristiche etniche geografiche linguistiche e storiche, doveva trovare nell’organismo statale, creato per proprio conto secondo la sua particolare concezione della vita politica, lo strumento per soddisfare nel modo migliore ai suoi bisogni, indipendentemente da ogni intervento estraneo.
L’ideologia dell’indipendenza nazionale è stata un potente lievito di progresso […]
Essa portava però in sé i germi del nazionalismo imperialista, che la nostra generazione ha visto ingigantire fino alla formazione degli Stati totalitari ed allo scatenarsi delle guerre mondiali […]
Siamo qui di fronte a una considerazione non negativa del concetto di Nazione in sé, piuttosto quella della sua degenerazione in “nazionalismo”. Questa degenerazione si espresse progressivamente nel primo ventennio del ‘900 attraverso la concezione del ”Equilibrio di Potenza”. Secondo questo principio ogni nazione deve essere nelle condizioni militari di potersi non solo difendere, ma di conquistare nuovi spazi “vitali” alla propria sopravvivenza.
Questa logica conduce inevitabilmente alla “Trappola di Tucidide”, e tutta l’economia delle nazioni viene indirizzata per acquisire superiorità e potenza militare (ricorda qualcosa?). Specificatamente dal Manifesto (2):
La nazione non è più ora considerata come lo storico prodotto della convivenza degli uomini, che, pervenuti, grazie ad un lungo processo, ad una maggiore uniformità di costumi e di aspirazioni, trovano nel loro stato la forma più efficace per organizzare la vita collettiva entro il quadro di tutta la società umana. E’ invece divenuta un’entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio sviluppo, senza in alcun modo curarsi del danno che gli altri possono risentirne. La sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato alla volontà di dominio sugli altri e considera suo “spazio vitale” territori sempre più vasti che gli permettano di muoversi liberamente e di assicurarsi i mezzi di esistenza senza dipendere da alcuno. […]
In questo passaggio si introduce l’elemento chiave che costituirà la critica di tutto il Manifesto al modello politico in corso: la sovranità assoluta degli Stati. Contemporaneamente si puntualizza la lotta tra le classi sociali, laddove esso ritiene che, per reprimere i conflitti emergenti tra le classi (la lotta “comunista” stava emergendo all’interno del quadro europeo come azione di riscatto della classe proletaria sfruttata), siano stati proprio i ceti “privilegiati” a fomentare restrizioni progressive della libertà le quali, inevitabilmente, condussero ai sistemi totalitari. Ancora dal Manifesto (2):
[…] la libertà di stampa e di associazione e la progressiva estensione del suffragio rendevano sempre più difficile la difesa dei vecchi privilegi mantenendo il sistema rappresentativo. I nullatenenti a poco a poco imparavano a servirsi di questi strumenti per dare l’assalto ai diritti acquisiti dalle classi abbienti; le imposte speciali sui redditi non guadagnati e sulle successioni, le aliquote progressive sulle maggiori fortune, le esenzioni dei redditi minimi, e dei beni di prima necessità, la gratuità della scuola pubblica, l’aumento delle spese di assistenza e di previdenza sociale, le riforme agrarie, il controllo delle fabbriche, minacciavano i ceti privilegiati nelle loro più fortificate cittadelle
[…] Anche i ceti privilegiati che avevano consentito all’uguaglianza dei diritti politici non potevano ammettere che le classi diseredate se ne valessero per cercare di realizzare quell’uguaglianza di fatto che avrebbe dato a tali diritti un contenuto concreto di effettiva libertà. Quando, dopo la fine della prima guerra mondiale, la minaccia divenne troppo forte, fu naturale che tali ceti applaudissero calorosamente ed appoggiassero le instaurazioni delle dittature che toglievano le armi legali di mano ai loro avversari.
[…] convinzione che solamente lo stato totalitario, abolendo la libertà popolare, potesse in qualche modo risolvere i conflitti di interessi che le istituzioni politiche esistenti non riuscivano più a contenere.
Le tirannie quindi erano considerate il frutto conseguente di un sistema sociale al cui interno vigeva un conflitto: tra nuove classi emergenti, in cui i lavoratori prendevano sempre più coscienza del proprio ruolo all’interno dell’economia, si pensi al “biennio rosso”(3), e quelle che oggi chiameremmo élite, decise a non cedere i propri privilegi.
Nel ragionamento del Manifesto sono quindi gli Stati nazionali, fomentati e deviati da queste élite, a condurre inevitabilmente alle guerre, come strumento del capitalismo e delle classi privilegiate per impedire la diffusione delle idee Socialiste.
All’interno del Manifesto (cui si rimanda per una lettura completa ed esauriente) si critica anche lo stesso concetto della “politica democratica” che non ha impedito il diffondersi delle tirannie. L’idea “rivoluzionaria” socialista si estende dal concetto di maggior controllo dello Stato a quello della necessità di una struttura di governo sovranazionale che superi il concetto di “sovranità”, così come era stato concepito negli ultimi decenni.
Torti e ragioni, pro e contro il Manifesto.
Come viene ricordato, il Manifesto di Ventotene fu ispiratore delle potenziale Europa unita, ma la realizzazione di questa seguì altri percorsi; il testo non fu per lo più ben accolto proprio dai socialisti e dai comunisti del tempo in quanto li criticava (1):
[…] Quando circolò a Ventotene, il testo fu comprensibilmente contestato dai Comunisti e dai Socialisti, anche perché era critico verso di loro: considerava i primi diretta emanazione dell’Unione Sovietica e fautori di divisioni nel fronte antifascista, e i secondi non all’altezza della «rivoluzione socialista» (quella citata a sproposito da Meloni) che era vista come necessaria per abbattere le dittature che avevano trascinato l’Europa in guerra. […]
[…] L’europeismo federalista di Spinelli e Rossi è comunque distante da quello su cui si improntò l’integrazione europea fin dall’inizio, che fu più verticistico (cioè calato dall’alto, il contrario di federale) e legato a personalità di un’altra area politica rispetto alla loro, più moderata (come Alcide De Gasperi, Winston Churchill, Robert Schuman o Konrad Adenauer) […]
Se si vuole tirare in ballo Ventotene, bisogna allora riconoscere e mettere in chiaro, con un minimo di onestà intellettuale, alcuni punti:
1) L’interpretazione letteraria del testo deve essere contestualizzata al periodo storico: esso rappresenta la conseguenza di ciò che è stato vissuto in quel periodo. Non si dimentichi il ruolo della Germania nelle due guerre mondiali, e l’errore grave che fu commesso con la pace di Versailles obbligando la stessa a un gravoso pagamento dei danni materiali provocati dalla prima guerra mondiale che, come spiegò molto bene Keynes (4), avrebbero condotto i tedeschi in miseria prima, e a ribellarsi poi.
Non hanno torto coloro i quali rivendicano l’importanza della sovranità, così come le conseguenze (oggi sotto i nostri occhi) del suo venir meno. Ma ciò che consideriamo oggi, non è ciò che è stato vissuto a quei tempi.
2) La realizzazione dell’Unione Europea, come già indicato, ha seguito ben altri percorsi rispetto a quello spirito di fraternità e del benessere collettivo individuato dal Manifesto. L’urgenza individuata fu quella di una maggiore estensione del libero mercato considerando come questo avrebbe “unito” i popoli europei allontanandoli dall’idea di “competere” con le armi.
L’Europa è nata da un’antitesi mai completamente risolta tra una struttura Federalista e una Confederale. Nella prima l’ispirazione era quella del modello americano: un unico governo centrale, un’unica moneta, esercito, Banca centrale, tassazione unificata, e una serie di prerogative rimaste in capo agli Stati federati. Nella seconda, gli Stati mantengono la propria sovranità, e mettendo in comune solamente la gestione di alcune funzioni.
Questa ambivalenza ha generato l’attuale UE costruita attraverso il “Funzionalismo”: ovvero una progressiva unificazione di singole attività economiche, con l’obiettivo finale di raggiungere l’unificazione politica.
La domanda che però dovrebbero porsi i difensori – a spada tratta- di Ventotene è: questa Europa che stiamo più “subendo” piuttosto che “vivendo”, si può davvero dire “ispirata” a quei principi di Ventotene?
3) Il parto peggiore di queste contraddizioni è stato l’euro: pur sapendo che l’Europa non corrispondeva ai canoni di una Area Valutaria Ottimale, e che un numero notevole di economisti aveva previsto come questo avrebbe comportato danni economici molto seri, disparità sociali, nonché inevitabile declino, fu deciso di procedere ugualmente. I popoli europei furono esclusi dalla possibilità di scelta in merito: e gli unici due referendum consultivi realizzati diedero esito negativo.
I Trattati iniziali, post II guerra mondiale, trattavano materie squisitamente economiche (CECA, EURATOM, commercio), nella idea fiduciosa che solamente un Libero Mercato, liberato dai dazi, e l’aumento degli scambi, avrebbero garantito la Pace: perché, a rigor di logica, gli interessi commerciali avrebbero dovuto ridurre il rischio del risorgere di sentimenti nazionalistici.
La lettura del TUE (Trattato dell’Unione Europea) che ne esprime i fondamenti “politici”, e del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea) che descrive l’organizzazione, mettono in chiaro come l’UE sia stata realizzata su fondamenti tipicamente neoliberisti, e su una struttura intergovernativa poco o nulla democratica. Evidenti sono le contraddizioni laddove si parla contemporaneamente di “piena occupazione”, di un “mercato fortemente competitivo”, e di un mandato alla BCE limitato al solo obiettivo del “controllo dell’inflazione”.
A questa logica ubbidiscono i parametri di Maastricht (privi di fondamento scientifico), l’idea farlocca della “Austerità Espansiva”, nonché l’ossessione per i debiti sovrani, forieri di fallimenti dei singoli paesi (e in Giappone continuano a ridere…).
Su come questa costruzione europea sia all’origine della attuale situazione economica disastrosa, è evidente. La Pandemia Covid e la guerra tra Russia e Ucraina, nonché i silenzi complici sullo sterminio israeliano nella striscia di Gaza, la malcelata intolleranza verso il dissenso, il rigetto dei risultati elettorali non graditi ai vertici europei, hanno messo in evidenza come l’idea di Democrazia Liberale sia, chiaramente, poco amata dalle “élite” europee. Su questo punto troviamo purtroppo una corrispondenza con quei sentimenti di avversione, espressi nel Manifesto, verso i “gruppi dominanti” e i loro interessi (ben lontani da quello delle popolazioni). I 70 anni trascorsi non sembrano proprio aver migliorato la situazione.
La questione delle élite.
La democrazia, nella interpretazione di Norberto Bobbio(5), è lo strumento con il quale ci si pone l’obbiettivo di cambiare le élite, a cui è stato demandato l’onore e l’ònere di gestire lo Stato, senza dover ricorrere a una rivoluzione violenta. Laddove per élite intendiamo in modo ampio tutti coloro che influenzano il potere, oltre ai Rappresentanti delegati nel Parlamento attraverso il suffragio universale.
La Democrazia Liberale, essendo l’una e l’altra due pilastri su cui poggia uno Stato di Diritto occidentale, non vive però di vita propria in modo autosufficiente. Risulta sempre essere sotto la minaccia di una deviazione (manipolazione) da parte élite rappresentative, e a rischio di svilimento da parte dell’indifferenza dei cittadini.
Giustamente oggi si punta il dito contro questi gruppi auto referenziali, e questa Europa ne rappresenta un esempio da manuale. La questione delle élite è capire se queste agiscono avendo come obbiettivo il benessere e lo sviluppo della collettività, oppure se beceramente agiscono in funzione di loro interessi.
Lo storico e antropologo Y.N. Harari spiega in un interessante libro(6), come la nascita dell’Homo Sapiens (il figlio africano di una madre scimpanzé) ha effettuato il salto “cognitivo”, acquisendo la capacità di ragionamento complesso, nel momento in cui ha imparato a “narrare”, a costruire delle storie. E non è forse la Politica una narrazione di storie e di interpretazioni sul presente, e di immaginazione del futuro?
La “sovranità appartiene al Popolo”, recita l’articolo 1 della nostra Costituzione. Ma chi è il “Popolo”? Da chi è composto? Sono tutti i cittadini che appartengono a una determinata comunità dentro un determinato territorio? Ma sono più cittadini i poveri oppure i ricchi? Gli operai o gli impiegati? Gli imprenditori o i politici?
Le narrazioni che si costruiscono con la politica spostano il peso dell’una o dell’altra categoria di cittadini. Il Populismo si contraddistingue per l’elevare un gruppo di persone sopra tutte le altre, e ciò implica una politica costruita a beneficio di pochi, a discapito di tutti gli altri.
Nella filosofia Liberale è lo scontro tra questi gruppi portatori di differenti interessi ad animare la società e a condurla sulla strada dello sviluppo.
Per questo motivo Bobbio ci ricorda che la Democrazia Liberale non è un punto fermo fissato per sempre. La Democrazia è “fatica”, afferma anche il filosofo Nicola Donti.
La questione del “potere delle élite” (e del suo ricambio) non è solo scontro tra una concezione di Democrazia Rappresentativa e Democrazia Diretta. Non dipende solamente dal distacco dei rappresentanti dal popolo che ha dato loro un mandato.
Ha molto a che fare con l’arrendevole abbandono dei cittadini alle seducenti narrazioni della politica politicante.
Se la costruzione delle storie fa parte della nostra evoluzione come Homo Sapiens, è più che mai urgente recuperare proprio il senso della nostra capacità critica di Sapiens. Le “baruffe” su Ventotene sono una narrazione manipolata che distoglie dai problemi urgenti. Viviamo il tempo delle truffe ideologiche mascherate da ragionamenti razionali.
Per esempio: se contrappongo il principio “Se vuoi la Pace prepara la guerra”, a quello “Se vuoi la Pace prepara la Pace”, è truffaldino affermare che il primo è razionale e invece il secondo è “ideologico”. Entrambi rappresentano due ideologie diverse: per principi filosofici, interpretazione della storia, della socialità, della comunità internazionale.
La Politica quotidiana è farcita di queste truffe. Non riuscire a interpretarle è la nostra più grande debolezza. Quella sulla quale le élite locali ed europee prosperano, garantendosi una continuità e una longevità immorale avverse alle necessità del Popolo tutto. Il problema non è il Manifesto, ma la nostra soggezione a interpretazioni mistificatorie della realtà e della storia.
Di Davide Amerio
NOTE
(1) Che cos’è il Manifesto di Ventotene – IlPost.it
(2) Il Manifesto di Ventotene (edizione in rete)
(3) da Wikipedia: Il biennio rosso è stato un periodo della storia d’Italia compreso fra il 1919 e il 1920, caratterizzato da una serie di lotte operaie e contadine che ebbero il loro culmine e la loro conclusione con l’occupazione delle fabbriche nel settembre 1920. Nel corso del biennio rosso si verificarono soprattutto nell’Italia centro-settentrionale, mobilitazioni contadine, tumulti annonari, manifestazioni operaie, occupazioni di terreni e fabbriche con, in alcuni casi, tentativi di autogestione. Le agitazioni si estesero anche alle zone rurali e furono spesso accompagnate da scioperi, picchetti e scontri. Una parte della storiografia estende la locuzione ad altri paesi europei, interessati, nello stesso periodo, da moti analoghi […]
(4) J.M. Keynes – Le conseguenze economiche della pace
(5) Norberto Bobbio – Teoria generale della Politica
Norberto Bobbio – Liberalismo e Democrazia
(6) Y.N. Harari – Sapiens da animali a Dei, breve storia dell’umanità
