
[Per tutto il periodo febbraio-maggio non abbiamo rilasciato interviste sull’emergenza coronavirus. Finché durava la buriana, abbiamo valutato fosse meglio esprimerci solo per iscritto e solamente su Giap. Abbiamo declinato ogni invito di radio, giornali e riviste. Unica eccezione, l’intervista che esce oggi, a cura di Jakub Hornacek, sulla rivista politico-culturale ceca A2. Il titolo, tradotto dal ceco, suona così: «Invece delle fabbriche hanno chiuso i parchi». Le risposte le abbiamo spedite il 19 maggio scorso e le rendiamo disponibili anche in italiano, qui il pdf.
Rileggendole pochi giorni fa, ne abbiamo ricevuto un pungolo: era tempo di ricapitolare il lavoro fatto su questo blog, insieme alla comunità che qui ha discusso. Non solo per capire come siamo arrivati qui, ma per comprendere cosa ci attende dopo la fase “acuta” dell’emergenza. L’intervista, dunque, ha fatto da “trampolino” a un testo nuovo, dove aggiorniamo e approfondiamo varie questioni emerse su Giap fino a oggi, proponendo anche un “glossario” dell’emergenza. Appunti e spunti per chi, in futuro, dovrà storicizzare questo 2020. Buona lettura. WM]
INDICE
0. Le destre in piazza, ma che sorpresa!
1. «Riaperturismo» di destra e di “sinistra”
2. L’aperto e il chiuso
3. Lo scaricabarile psicopatogeno (per dirla con Bifo)
4. «Lockdown»
5. «Casa»
6. «Distanziamento sociale»
7. «Mascherina» e «Guanti»
8. «Minorenni» (scomparsa dei)
9. «Morti» (rispetto per i)
10. «Reddito» (di quarantena)
11. «Ripartenza» (tutto in nome della)
12. Un «canto di Natale» a primavera
0. Le destre in piazza, ma che sorpresa!
Mentre scriviamo si parla molto delle «destre che scendono in piazza cavalcando il malcontento». Su questo blog già dai primi di aprile avvisavamo che presto o tardi sarebbe accaduto: quel malcontento – la rabbia per la gestione dell’emergenza coronavirus e per le sue conseguenze sociali – stava già montando, ma si esprimeva in modi che non entravano nei radar, oppure ci entravano, ma venivano subito fraintesi, distorti, sminuiti, derisi.
Nel mainstream e “a sinistra” – qualunque cosa ciò voglia ormai dire in Italia – l’esistenza di un malcontento era negata: nella rappresentazione dominante il Popolo temeva solo ed esclusivamente il virus, era felice di #stareincasa e metteva i like sotto i video del premier su Facebook. Noi invece davamo per scontato che, non appena calata la paura, le destre avrebbero capitalizzato sulla rabbia, prendendosi simbolicamente le piazze e, soprattutto, prendendosi l’esclusiva della critica all’emergenza.
La destra fa il suo lavoro. Il problema è chi le dà modo di farlo bene. Il problema è “a sinistra”, dove non c’è stata disponibilità a recepire alcuna critica dei modi e tempi del lockdown. Chi la esprimeva, anche da un punto di vista anticapitalistico e di classe, era subito messo nel mucchio insieme ai fascisti.

Pappalardo e i suoi «gilet arancioni».
1. «Riaperturismo» di destra e di “sinistra”

Alberto Zangrillo. Le polemiche seguite alle sue dichiarazioni si inseriscono nello scontro tra due narrazioni «riaperturiste», entrambe basate su reticenze e omissioni.
Reazione ancora riscontrabile quando si parla dello stato attuale della pandemia e si azzardano sguardi retrospettivi su come l’abbiamo affrontata. Pensiamo agli strascichi della controversia scatenata da Alberto Zangrillo, primario del reparto terapie intensive dell’ospedale San Raffaele.
Zangrillo ha dichiarato che «dal punto di vista clinico» il Covid-19 è stato praticamente sconfitto, la «seconda ondata» prevista per fine maggio non c’è stata, si muore sempre meno, da tempo non ci sono nuovi ricoveri in terapia intensiva, i sintomi del Covid sono in media molto più lievi e i tamponi rivelano una carica virale «infinitesimale» rispetto a quella di due mesi fa.
Zangrillo è un grosso nome della sanità privata lombarda e un sodale di Berlusconi, e le risposte polemiche che ha ricevuto dal fronte governista e dai suoi media si sono concentrate su questo.
Nello spettacolino della politica, oggi la contrapposizione è tra le “sinistre” (sempre lato sensu) che difendono le scelte compiute a marzo e aprile – difendono la memoria del lockdown, si potrebbe dire – e le destre che invece devono intercettare il malcontento e lo scetticismo cresciuti in questi mesi.
Il governo sta ormai riaprendo tutto, sta addirittura “smarmellando”, ma quanto più lo fa, tanto più deve mantenere una postura “responsabile” e una narrazione che preservi un po’ di allarme, perché le riaperture non devono sembrare il “contrordine” che all’atto pratico sono. Al contrario, devono sembrare il più possibile in continuità con le restrizioni di prima. Anzi, il merito delle riaperture va dato alle restrizioni. Ne deriva il più classico «doppio legame»: io riapro tutto e quindi ti comunico che le cose vanno meglio, ma se dici che le cose vanno meglio intervengo subito a dire che non è vero.
Le destre, invece, devono rimarcare che le riaperture sono in contrasto con almeno alcune delle scelte fatte a marzo, e scaricare sul governo nazionale il maggior numero di colpe possibile. Ovviamente, nel farlo, glissano sul fatto che molti governatori e sindaci di destra sono stati tra i più alacri sceriffi e hanno imposto i divieti più draconiani e demenziali. Soprattutto, glissano sulle responsabilità della destra lombarda, senza le cui negligenze iniziali l’impatto del coronavirus sarebbe stato molto meno disastroso. Per non dire di responsabilità più di lungo corso, bipartisan ma con un forte protagonismo delle destre: pensiamo alla crescente privatizzazione della sanità, che in Lombardia ha portato allo smantellamento della medicina di territorio (e gli esiti si sono visti).
La polemica sulle dichiarazioni di Zangrillo ha avuto luogo in questa cornice, e così sono passate in secondo piano alcune cose fondamentali. Zangrillo ha detto quanto sopra citando i risultati di diversi studi virologici, che andrebbero quantomeno vagliati prima di rispondere ad hominem. Soprattutto, le sue sono constatazioni che si riscontravano e leggevano da più parti ormai da settimane.
2. L’aperto e il chiuso
Da svariati giorni l’articolo più letto sul sito di Internazionale – non certo una rivista di destra – è «Perché in Italia si muore sempre meno di Covid?» di Luca Carra. Cosa vi si legge?
Molto in sintesi: il virus ha fatto strage soprattutto in Lombardia – regione che da sola annovera oltre la metà dei morti in Italia – e soprattutto tra persone anziane e con co-morbilità, per via delle condizioni in cui si era ritrovata la sanità lombarda e per un concatenamento di errori diagnostici e procedurali dovuti a quelle condizioni e all’effetto-sorpresa.
Oggi la mortalità è dieci volte più bassa rispetto a marzo. Secondo le testimonianze mediche raccolte da Carra, si spiega così: i soggetti a rischio sono più consapevoli e tutelati, le procedure sanitarie sono più appropriate e la carica infettante media, che era schizzata alle stelle per via della «superdiffusione» dovuta alle infezioni ospedaliere, è ora calata a livelli bassissimi.
Nel frattempo, e qui ci inseriamo, tutti siamo tornati a circolare e a vivere gli spazi pubblici, facendo quello che soltanto un mese fa era demonizzato a media unificati, in titoli cubitali e giganteschi shitstorm su Facebook. È evidente a chiunque viva la propria città che ogni giorno, da settimane, ci sono “assembramenti” nelle piazze, nei parchi, nei dehors… Dove viviamo noi, a Bologna, sabato scorso ci sono state ben cinque manifestazioni politiche più o meno concomitanti. Quanto a noi, eravamo impegnati in un trekking sull’Appennino, insieme ad altre centocinquanta persone. Si può ormai girare ovunque, da oggi non c’è nemmeno più l’autocertificazione… Eppure non sta succedendo alcuna catastrofe sanitaria. Com’è possibile?
La risposta era chiara da tempo, benché i mezzi d’informazione italiani non abbiano fatto nulla per farla conoscere – anzi, si sono proprio impegnati a sostenere il contrario.
La risposta è: all’aperto, il contagio da SarsCov2 è sempre stato molto, molto, molto improbabile.

Erin Bromage
Anche l’articolo sul coronavirus più condiviso a livello mondiale nelle ultime settimane, quello dell’immunologo Erin Bromage che si trova tradotto in italiano sempre su Internazionale, dice con nettezza che all’aperto il rischio di contagio da Sars-Cov-2 è minimo, perché
«a due metri di distanza e con uno spazio aperto capace di ridurre la carica virale, il covid-19 non ha il tempo sufficiente per diffondersi. Il sole, il caldo e l’umidità sono tutti fattori che ostacolano la sopravvivenza del virus e minimizzano il rischio di trasmissione all’aperto.»
Infatti, scrive Bromage, «nei paesi che svolgono un tracciamento adeguato è stato registrato solo un focolaio collegato a un evento che si è svolto all’esterno. Meno dello 0,3 per cento dei contagi accertati.»
Il problema sono sempre stati gli spazi chiusi. In particolare, gli spazi chiusi, affollati e poco ventilati. Guardacaso, molti dei luoghi di lavoro rimasti aperti per tutto il tempo corrispondono alla descrizione.
«In tutte le situazioni prese in esame», prosegue Bromage, «le persone sono state esposte al virus presente nell’aria per un periodo prolungato (ore). Anche se si trovavano a 15 metri di distanza (coro e call-center) e la dose infettante era ridotta, il contatto prolungato con il virus è stato sufficiente a provocare il contagio e in alcuni casi la morte.»
Il quadro che emerge è coerente con molte delle cose scritte qui su Giap negli ultimi tre mesi e mezzo.
La demonizzazione dell’aria aperta e la conseguente caccia all’untore portate avanti da media e politici non c’entravano nulla con le reali dinamiche del contagio e dei decessi. Questi ultimi sono stati in gran parte conseguenza dei focolai scoppiati in ospedali e altre strutture sanitarie e sociosanitarie.
La demonizzazione, la titolazione terroristica tipo «il virus è nell’aria» (smentita dagli stessi studi scientifici citati nell’articolo), la caccia all’untore e al “furbetto” hanno distolto l’attenzione, avvelenato il clima e causato sofferenze soprattutto ai più deboli, con conseguenze sociali che pagheremo a lungo.
3. Lo scaricabarile psicopatogeno (per dirla con Bifo)
La cosa più logica sarebbe stata chiudere le fabbriche – se si fosse fatto per tempo in Val Seriana, plausibilmente non sarebbe avvenuto tutto il resto – e organizzare la vita sociale perché la gente potesse stare il più possibile all’aria aperta in parchi, boschi, campi, spiagge… Invece si è fatto l’opposto.

Per l’ennesima e ultima volta ribadiamo che c’è stato uno «scambio spettacolare». La chiusura delle fabbriche è stata una mezza farsa, c’è stata una pioggia di deroghe (vedi la nostra inchiesta pubblicata l’1 maggio scorso) e più della metà dei lavoratori dipendenti ha continuato a lavorare, mentre si è feticizzato lo #stareincasa e si sono tenuti milioni di persone in cattività. Contagiati e non contagiati insieme, dato che non c’è mai stata una seria campagna di test sulla cittadinanza.
Si è punito e messo alla gogna chi usciva a sgranchirsi le gambe e prendere una boccata d’aria, si sono multati persino conviventi perché erano usciti insieme, si sono chiusi i parchi, si è messo il nastro rosso e bianco intorno ai giochi dei bambini, si sono mandati gli elicotteri a pattugliare le spiagge e i droni a sorvegliare i boschi, si sono inondate le strade di varechina, tutte cose del tutto irrazionali rispetto al fine propagandato, e spesso dannose. Dannose non col senno di poi, ma con quello di prima: già il 15 marzo l’ARPA Piemonte aveva chiesto ai sindaci di non lavare i manti stradali con l’ipoclorito di sodio, perché
«non vi è evidenza che [ciò] possa avere efficacia per il contrasto alla diffusione del CODIV-19 dal momento che le pavimentazioni esterne non consentono interazione con le vie di trasmissione umana […] L’ipoclorito di sodio, componente principale della candeggina, è sostanza inquinante che potrà nel tempo contaminare le acque di falda, direttamente o attraverso i suoi prodotti di degradazione.»
Il 18 marzo, dichiarava la stessa cosa l’Istituto Superiore di Sanità. Sullo spettacolo della «sanificazione» dei luoghi pubblici, allestito anche contro le evidenze scientifiche, consigliamo il bell’articolo di Donato Greco intitolato Sorvegliare e pulire, pubblicato su Scienza in Rete.
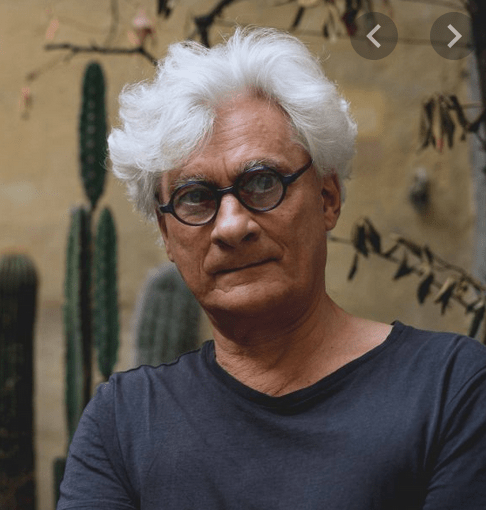
Bifo.
Nel mentre, come si è detto, le dinamiche reali del contagio erano tutt’altre.
Franco “Bifo” Berardi, in un articolo sul quale ritorneremo, descrive quanto accaduto più o meno al nostro stesso modo, e chiama lo scambio spettacolare «scaricabarile psicopatogeno»:
«Il potere ha compiuto un’operazione che consiste nel colpevolizzare la società usando l’arma sanitaria, e rovesciando la reciprocità affettuosa in una sorta di labirinto delle colpevolizzazioni. La chiamano responsabilità, ma io la chiamo in un’altra maniera: scaricabarile psicopatogeno. Quelli che hanno distrutto il sistema sanitario pubblico e molte altre cose, ci hanno detto: state tutti a casa, non muovetevi, altrimenti ammazzate la nonna. Lavorate moltissimo davanti a uno schermo, non chiedete aumenti di salario, accontentatevi di quello che passa il convento, altrimenti crolla l’economia.»
Lo scaricabarile è stato occultato in diversi modi, uno è stato l’uso astratto e generalizzante del termine «lockdown».
Su questo blog abbiamo cercato di sviluppare una critica all’uso capzioso di termini ed espressioni come «lockdown», «chiudere»/«riaprire» , «stare a casa» e «distanziamento sociale». Ci siamo impegnati, collettivamente, a discernere ogni volta, a smontare i discorsi per capire a cos’erano riferiti. Ecco una sintesi in forma di glossarietto. L’ordine non è alfabetico, segue l’argomentazione.
4. «Lockdown»
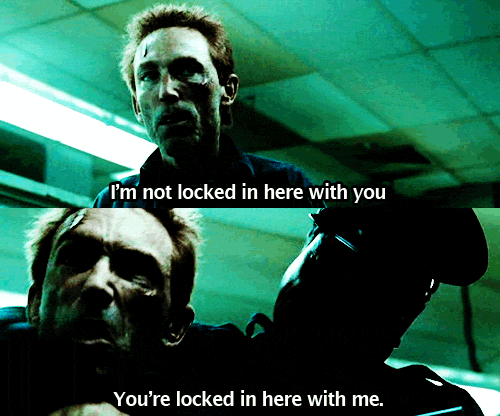 «Tu sei contro il lockdown», «non si poteva non fare il lockdown», «guarda cos’è successo dove non hanno fatto il lockdown»…
«Tu sei contro il lockdown», «non si poteva non fare il lockdown», «guarda cos’è successo dove non hanno fatto il lockdown»…
«Il lockdown» non vuol dire niente. Non esistono paesi che hanno fatto «il lockdown» e altri che non l’hanno fatto. Tutti i paesi hanno chiuso qualcosa, hanno fatto dei lockdown, compresa la vituperata Svezia. La questione è sempre stata: lockdown di cosa, come, quando e per quanto tempo. Non è mai esistito un unico “pacchetto”, un unico modello, un unico insieme di divieti e restrizioni. Le strategie sono state variegate e modulate – bene, benino, male o malissimo – nello spazio e nel tempo.
Ad oggi non sappiamo se i diversi tipi di lockdown abbiano prodotto risultati diversi in termini di contagio, letalità, mortalità ecc. In linea di massima, il virus sembra essersi comportato ovunque in maniera molto simile. Tuttavia, proprio guardando a come il virus si è comportato, possiamo dire che alcuni provvedimenti di questo o quel “pacchetto” non avevano giustificazione.
«Lockdown» al singolare, però, è un termine-ombrello che impedisce di discernere, utile a giustificare qualunque cosa. Soprattutto in Italia, dove è servito a mettere insieme tutte le chiusure, restrizioni, limitazioni, proibizioni introdotte a livello nazionale, regionale e municipale. Misure necessarie (ma spesso applicate nei tempi e modi sbagliati), misure magari non necessarie ma sensate, e misure del tutto irrazionali.
L’uso dell’espressione «il lockdown» ha fatto credere, ad esempio, che ci fosse un’inesorabile progressione logica tra vietare gli “assembramenti” e starsene tappati in casa.
5. «Casa»
 Il chiudersi in casa non è mai stato conseguenza obbligata del distanziamento fisico né del «lockdown». Repetita iuvant: nella lingua italiana un conto è «stare a casa» dal lavoro, un conto è pensare si debba stare sempre in casa. Anche in inglese esiste la differenza tra stare «at home» e stare «indoors».
Il chiudersi in casa non è mai stato conseguenza obbligata del distanziamento fisico né del «lockdown». Repetita iuvant: nella lingua italiana un conto è «stare a casa» dal lavoro, un conto è pensare si debba stare sempre in casa. Anche in inglese esiste la differenza tra stare «at home» e stare «indoors».
Nei vari paesi che hanno affrontato la pandemia, la limitazione di spostamenti e interazioni è stata declinata in modi anche molto diversi tra loro. In Italia, lo stare a casa è diventato ben presto stare in casa, e se ne è data un’interpretazione rigidissima, tetragona, che ha dato la stura a fenomeni inquietanti, a «ritorni del rimosso», a riemersioni di mentalità profonde.
#Iorestoacasa è stato una narrazione discriminatoria, escludente, classista. Per chi gode di un privilegio, quel privilegio è come l’acqua per il pesce. Privilegio di classe, di genere, di “razza”: chi ce l’ha lo dà per naturale, scontato e soprattutto universale, non si accorge che il suo punto di vista è situato, se altre persone non glielo fanno notare e non gli smontano la costruzione davanti agli occhi. È dunque normale che chi aveva le condizioni per passarsi «tutto sommato bene» la clausura domestica sia incline a pensare che tutti quanti se la siano passata «tutto sommato bene», e che l’angolatura da cui guarda quei mesi sia quella “normale”. Consultando la sua cerchia di amicizie e relazioni, il più delle volte, avrà solo conferme, perché il bias è comune. A volte, poi, la cerchia – spesso un gruppo su Whatsapp – è divenuta una bolla, in seguito a scazzi e alla fuoriuscita o esclusione di chi non vedeva la situazione allo stesso modo.

Sovente i progressisti del ceto medio ci hanno chiesto – astrattamente e senza pensare all’assurdità della cosa – di «empatizzare coi morti». Al tempo stesso, proprio non riuscivano a capire che stavamo empatizzando con molte persone vive: famiglie proletarie costrette in appartamenti minuscoli, bambini e adolescenti impossibilitati a seguire la DAD perché in tutta la famiglia c’era un solo dispositivo ed era il telefono del papà, donne costrette tra quattro mura con mariti prevaricatori, disabili e sofferenti psichici rimasti senza assistenza, elementi deboli e discriminati del mondo LGBTQ+, migranti, e in generale tutte le persone per le quali la reclusione domestica non è stata una fase «rigenerante», non è coincisa con la riflessione, con la riscoperta di vecchi hobby, col cucinare manicaretti, con l’aperitivo a distanza su Zoom, con niente di tutto questo.
Ecco, quando parliamo di cos’è stata la «Fase 1», cerchiamo di non rimuovere il fatto che la «casa» della narrazione #iorestoacasa era la casa borghese – e, sovente, liberal.

Ida Dominijanni
Di fronte a questa realtà concreta, ai fini del confronto e dell’analisi non ci pare centrato né utile disquisire, come ha fatto Ida Dominijanni, sullo #stareincasa come scelta libera e altruistica, non imposizione dall’alto ma «(auto)contenimento della potenzialità di ciascuno di infettare l’altro: e dunque come […] segno di una postura relazionale e responsabile, non ego-centrata e asservita.»
Non mettiamo in dubbio le intenzioni di chicchessia: semplicemente, ci interessano poco. A interessarci sono gli esiti dell’emergenza sulle vite di chi non ha potuto scegliere dove, come e con chi #stareincasa, né ha avuto libertà di distinguere tra stare at home e indoors. Per non dire di chi una home non ce l’aveva, o stava indoors ma non at home, perché in una RSA o in un CPR. Il tutto, sempre ricordando che indoors era molto più facile prendersi il virus, mentre per pigliarselo outdoor bisognava proprio andarlo a cercare.
Nell’incontro con determinati costrutti ideologici, in ambienti che hanno aderito allo #stareincasa “da sinistra” e con grande zelo, lo #stareincasa ha portato a derive penitenziali e sacrificali. È riemerso qualcosa di profondissimo, di “hardcore”, proveniente da qualche recesso della Kultur italiana, localizzabile tra le memorie remote del cristianesimo medievale e il retaggio della Controriforma.
 Non ci riferiamo all’esperienza del cristianesimo come ἐκκλησία – raduno, assemblea, comunità. Anzi, dai cristiani che si vivono come ecclesia sono spesso giunte critiche – e disobbedienze – ai dpcm e ordinanze. No, ci riferiamo ad altre correnti e sfaccettature dell’esperienza storica cattolica, a quelle zone oscure in cui l’accento cade su percorsi di penitenza, restrizione, mortificazione e sacrificio individuali: clausura, isolamento, espiazione, eremitaggio, misticismo…. Abbiamo letto un diario della quarantena dove si vedevano in filigrana gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio, e a un certo punto c’era la foto di una ragade venuta a furia di lavarsi le mani col disinfettante. L’apparizione delle stimmate. Santa Caterina da Siena o, più plausibilmente, Padre Pio.
Non ci riferiamo all’esperienza del cristianesimo come ἐκκλησία – raduno, assemblea, comunità. Anzi, dai cristiani che si vivono come ecclesia sono spesso giunte critiche – e disobbedienze – ai dpcm e ordinanze. No, ci riferiamo ad altre correnti e sfaccettature dell’esperienza storica cattolica, a quelle zone oscure in cui l’accento cade su percorsi di penitenza, restrizione, mortificazione e sacrificio individuali: clausura, isolamento, espiazione, eremitaggio, misticismo…. Abbiamo letto un diario della quarantena dove si vedevano in filigrana gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio, e a un certo punto c’era la foto di una ragade venuta a furia di lavarsi le mani col disinfettante. L’apparizione delle stimmate. Santa Caterina da Siena o, più plausibilmente, Padre Pio.
Anche senza arrivare a tali estremi, ci sembra che l’emergenza coronavirus abbia scavato molto in profondità. Sono argomenti che fanno tremare le ginocchia, ed è difficile scriverne in modo equilibrato. Possiamo solo offrire questi spunti. Approfondirli sarà compito di storici, sociologi e antropologi.
6. «Distanziamento sociale»
L’espressione inglese «social distancing» indica lo stare discosti l’uno dall’altro nelle occasioni di socialità. Occasioni che non vengono negate, anzi, sono poste a premessa e cornice dell’interazione.
«Social» è spesso un false friend, perché ha connotazioni diverse dal nostro «sociale». Ecco il primo significato del lemma riportato dall’Oxford Dictionary: «
L’espressione «social distancing» dice che le distanze fisiche vanno rispettate senza annullare tutto questo.
Al contrario, «distanziamento sociale» contiene già lo sfilacciarsi dei legami.
Aver reso «social distancing» in “traduttese” letterale anziché con una parafrasi in italiano corretto è stato un errore fecondo di mostri. Ha contribuito a produrre distanza sociale, patita da tutti i soggetti più deboli. Addirittura, spesso si è sentito usare come quasi-sinonimo «isolamento sociale». Bel lapsus.
7. «Mascherina» e «guanti»
 La prescrizione di mascherina e guanti anche all’aria aperta e in altre situazioni dove non sarebbero serviti a nulla ha dato luogo a un vero e proprio feticismo, proprio nell’accezione del termine usata in etnologia: a quegli oggetti si sono attribuiti poteri pressoché magici. Al punto che anche nella letteratura medica, in testi dove si dice che persino nelle strutture sanitarie portare la mascherina ovunque è di dubbia utilità, si usano parole come «ruolo simbolico» e «talismano».
La prescrizione di mascherina e guanti anche all’aria aperta e in altre situazioni dove non sarebbero serviti a nulla ha dato luogo a un vero e proprio feticismo, proprio nell’accezione del termine usata in etnologia: a quegli oggetti si sono attribuiti poteri pressoché magici. Al punto che anche nella letteratura medica, in testi dove si dice che persino nelle strutture sanitarie portare la mascherina ovunque è di dubbia utilità, si usano parole come «ruolo simbolico» e «talismano».
È forse il primo talismano usa-e-getta della storia, e ha già prodotto miliardi di tonnellate di pattume che finirà in mare o verrà bruciato sprigionando diossina.
Su questo, non abbiamo molto altro da aggiungere. Avevamo scritto già molto nel post «Al ballo mascherato della viralità», che è dell’8 aprile.
8. «Minorenni» (scomparsa dei)
 Ad aver sofferto il distanziamento sociale sono stati soprattutto i bambini e gli adolescenti.
Ad aver sofferto il distanziamento sociale sono stati soprattutto i bambini e gli adolescenti.
Nelle vite degli adolescenti, la negazione della compagnia e della corporeità, l’affermarsi di una pervasiva narrazione basata su sospetto nei confronti dell’Altro – del suo approssimarsi, dei suoi fluidi e umori, e proprio nella fase in cui si dovrebbe scoprire l’eros –, tutto ciò avrà conseguenze a lungo termine.
Del succitato articolo di Bifo non condividiamo l’impostazione «noi giovani degli anni ’70 invece» e il disfattismo nero nei confronti delle nuove generazioni (che secondo noi possono riservarci grandi sorprese), ma alcune osservazioni sono perfette, come quando parla di «sensibilizzazione fobica al corpo dell’altro, alle labbra, che d’ora in avanti saranno nascoste per sempre come pudenda pericolose.»
Avrà conseguenze su ragazze e ragazzi anche il non essere stati minimamente considerati, l’essere stati rimossi dal quadro – mai nominati nei testi di dpcm e ordinanze, ignorati nelle conferenze stampa del premier, esclusi a priori dall’autocertificazione – salvo essere reintrodotti all’improvviso solo quando serviva usarli come facili capri espiatori, perché dopo la riapertura si “assembravano” o si davano alla “movida”.
Durante quest’emergenza si è espressa tutta l’adolescentofobia di una società di attempati e di «giovani per proroga dei termini».
Tutto ciò mentre, nella comunità scientifica, emergeva la consapevolezza che bambini e ragazzi molto difficilmente vengono contagiati dal SarsCov2, e nei casi in cui ciò avviene difficilmente contagiano altre persone. L’afflizione e la colpevolizzazione extra che sono state riservate ai minori – con l’avallo di certi virologi da talk-show – hanno sempre avuto basi scientifiche molto precarie. La constatazione dei danni “collaterali” dell’emergenza, invece, ha basi molto solide.
È quel che hanno fatto notare i pediatri che hanno scritto e firmato un appello apparso sul Manifesto il 29 maggio scorso. Dove si critica anche l’ossessivo focus su virologia e infettivologia, come se il punto di vista specialistico di quelle discipline riassumesse in sé tutta la scienza e fosse sufficiente a descrivere l’impatto di un’epidemia sulla società:
«I pediatri sono portatori di una visione più ampia su salute, sviluppo, assistenza e benessere dei bambini. Infatti, le maggiori riviste e associazioni internazionali pediatriche continuano a ribadire in modo chiaro e, al meglio delle conoscenze, inequivocabile, che il rischio di contagio per e da parte dei bambini è molto basso mentre il rischio di compromissione di aspetti cognitivi, emotivi e relazionali conseguenti alla prolungata chiusura delle scuole è molto alto.
Oltre a tutto, si sono enfatizzati i rischi di contagio derivanti dalla riapertura delle scuole e dei nidi, senza tener conto che i bambini lasciati a casa non ne sono affatto esenti: al contrario, affidati a parenti o amici o lasciati soli (i più grandicelli) stanno andando incontro a rischi infettivi senz’altro maggiori di quelli insiti in situazioni controllate dove gli adulti (insegnanti, educatori, ecc,) sono sottoposti a misure di prevenzione e controllo, dove si seguono regole di distanziamento, igiene personale e sanificazione ambientale.
Questo squilibrio si è verificato e si verifica in Italia a differenza di molti altri Paesi europei, dove, a partire dalle massime autorità fino a buona parte delle istituzioni locali, ci si è preoccupati di assicurare l’integrità fisica cognitiva ed emotiva dei bambini con una prospettiva più olistica, comprensiva di tutti gli aspetti.
È quindi urgente cambiare rotta, se si vuole evitare che alla crisi sanitaria e a quella economica si aggiunga una crisi educativa e sociale dalle conseguenze pesanti per tutti i bambini, e drammatiche per una consistente minoranza, che già in precedenza viveva situazioni di difficoltà di apprendimento. Vanno aperti, e riaperti sollecitamente spazi ludici con componenti educative, e vanno messe in campo iniziative specifiche di supporto per quei bambini, che gli insegnanti e gli educatori già conoscono, con difficoltà specifiche.»
9. «Morti» (rispetto per i)
Come ricorda Gina Kolata in un pezzo sul New York Times tradotto da Internazionale, la fine sociale di una pandemia arriva spesso prima della fine sanitaria. Arriva quando la gente non ne può più di avere paura. Tra le due “fini” c’è un momento di inevitabile contraddizione, dentro la quale è necessario muoversi.
Riscontriamo intorno a noi una grandissima voglia di stare in giro il più possibile. Nessuno si illude che d’ora in avanti le cose vadano bene: nell’immaginario incombe la crisi più grande di sempre, portatrice di nuove povertà ed esclusioni, e incombono collassi ecologici epocali, a cominciare dalla crisi idrica dietro l’angolo. Eppure camminare, prendere aria, chiacchierare persino con gli estranei è la vistosa prassi di chiunque: si esce dal lavoro e non si torna subito a casa ma si passeggia a lungo perché «meglio fare scorta, nel caso quelli decidano di rinchiuderci di nuovo»; ci sono famiglie che «noi praticamente stiamo vivendo nei parchi»; anche chi è ridotto in malora preferisce essere in malora all’aperto, con gente intorno, piuttosto che starsene in casa.
Forse è davvero la fine sociale dell’epidemia. Certo, il virus non è scomparso del tutto, per questo la gente porta le mascherine dov’è utile portarle, in fila mantiene le distanze, rispetta le regole sensate. La differenza è che lo fa senza affogare più nella paura.
Come lo fa adesso, avrebbe potuto farlo anche prima. E infatti viene detto. Tuco questa frase l’ha sentita in triestino, ma si ode in tutta Italia: «o i ne cioleva pel cul prima, o i ne ciol pel cul ‘desso, o tutte e due». Un livello di socialità attenta si sarebbe potuto mantenere anche prima, senza panico né odio fomentato contro chi “trasgrediva”, senza paranoie né capri espiatori. Ci sarebbero stati meno veleni in circolazione, ci sarebbe stato meno malessere psichico, soprattutto ci sarebbe stato più dibattito razionale.
E invece si è dato per scontato che le italiane e gli italiani fossero una masnada di imbecilli, una massa inerte da frastornare, da mobilitare con metafore belliche e intruppare dietro un nazionalismo d’accatto. Se all’inizio può essere stato puro panico, anche da parte della classe dirigente, gradualmente è prevalso l’interesse a impedire che si pensasse con la propria testa, a impedire che si facesse già ad aprile quel che tutti hanno poi fatto a maggio.
 Per impedirlo si è ricorso al ricatto morale: «ci sono i morti», «bisogna avere rispetto per i morti»… L’accusa di non rispettare i morti è scattata ogni volta che qualcuno ha reclamato il diritto di vivere, non solo di sopravvivere. «I morti» sono anche serviti per interdire ogni discorso critico: «non mi interessa parlare di questo, ci sono i morti», «a chi critica farei vedere le foto di tutte quelle bare»…
Per impedirlo si è ricorso al ricatto morale: «ci sono i morti», «bisogna avere rispetto per i morti»… L’accusa di non rispettare i morti è scattata ogni volta che qualcuno ha reclamato il diritto di vivere, non solo di sopravvivere. «I morti» sono anche serviti per interdire ogni discorso critico: «non mi interessa parlare di questo, ci sono i morti», «a chi critica farei vedere le foto di tutte quelle bare»…
Di fronte ai morti, bisognava mostrarsi più che contriti. E a esigere tale contrizione erano spesso i responsabili politici di quelle morti.
E così, si ritorna al tema del fare penitenza, e allo scaricabarile.
10. «Reddito» (di quarantena)
 La fine sociale dell’epidemia non è la fine dell’emergenza. L’emergenza, lo abbiamo già scritto, ha funzionato e continuerà a funzionare come acceleratore di processi che erano già in corso.
La fine sociale dell’epidemia non è la fine dell’emergenza. L’emergenza, lo abbiamo già scritto, ha funzionato e continuerà a funzionare come acceleratore di processi che erano già in corso.
C’è chi ha scambiato la spesa pubblica di questi mesi – spesso consistita in meri annunci – per l’alba di un nuovo socialismo, o quantomeno di un nuovo «redditismo» dopo quello incentrato sul reddito di cittadinanza, “bruciato” dal M5S. Si è dunque vista nell’imposizione del lockdown un’imperdibile occasione rivoluzionaria.
Scommettere sul «reddito di quarantena», però, ha portato a scommettere politicamente sulla quarantena stessa, sul suo protrarsi per chissà quanto. Durante quel lunghissimo #stareincasa, così si vagheggiava, si sarebbe combattuta la madre di tutte le battaglie. Ma stando tappati in casa non si fanno battaglie, né madri né figlie. Al massimo si fa clicktivism, cioè battaglie d’opinione, il più delle volte imbelli. Nel caso specifico, doppiamente imbelli, perché portate avanti con mille gergalismi e riferimenti criptici che le rendevano elitarie, e perché portate avanti da una comunità paradossale, di persone atomizzate che vivevano sui social dandosi ragione a vicenda.
Nulla di male nella rivendicazione in sé, ci mancherebbe. Ma mettendola al centro del proprio agire – o forse del proprio non-agire, wú wéi (无为) – e focalizzando i discorsi sempre e solo sul rischio virus, senza mai denunciare assurdità e abusi dell’emergenza, si è caduti in una trappola cognitiva dopo l’altra.
Non si è capito che in molti settori l’emergenza e lo #stareincasa creavano disagi e problemi a cui non si poteva rispondere con la rivendicazione di un reddito. Ad esempio, nella scuola: perdita della socialità, sofferenze psichiche, dinamiche escludenti nella DAD, calo dell’apprendimento, aumento della dispersione…
Soprattutto, non si è capito che la maggior parte delle persone non desidera affatto starsene reclusa in casa purché arrivi un sussidio con cui fare la spesa e pagare i giga di traffico.
La vita per cui si lotta, per cui si fa anche la lotta di classe, è sempre stata molto più di questo. Si lotta per una vita degna di essere vissuta, piena, ricca di relazioni. Si lotta per la salute, certo, ma non è salute fare una vita da talpe, sacrificando tutto pur di non ammalarsi. Essersi scordati di questo ha velato lo sguardo, così non si è visto che nella società, accanto alla paura del contagio, montava l’insofferenza verso l’emergenza stessa. Anche perché il «reddito di quarantena» è rimasto un sogno o un’ipotesi, mentre la realtà dei fatti mordeva il culo.
Non solo: scommettere sul lockdown – anche in vista di obiettivi condivisibili – ha portato a scommettere sulla paura, sulla politica della paura e sull’emergenza come modello di governance basato sulla percezione di un pericolo ubiquo e informe. La percezione, ricordiamo? Quante volte abbiamo condannato scelte politiche – in tema di immigrazione, di decoro urbano, di proibizionismo, di «legittima difesa» – basate sulla «percezione»?
Da tutto ciò è derivato un notevole “codismo” verso il governo Conte, con l’apoteosi dell’adesione di molt* “radicali” al famigerato appello «contro gli agguati». Mossa a tutta prima sconcertante, ma in realtà conseguente alla scommessa politica fatta dal principio.
Scommessa fallita, perché lo #stareincasa non poteva durare oltre, né aveva giustificazione scientifica in the first place. E faceva schifo.
11. «Ripartenza» (tutto in nome della)
Poi c’è stato chi non ha scommesso sulla paura ma ha ceduto alle tentazioni del «penso positivo» e del wishful thinking, vedendo l’emergenza come occasione per un ripensamento del modello di sviluppo: abbiamo avuto la dimostrazione che senza auto e senza aerei le emissioni crollano, ora non potranno non tenerne conto… Si è visto che la sanità pubblica è indispensabile, è un passo avanti…
Sorry to be the ones to tell you, ma… no. Purtroppo no.
Chi comanda sa benissimo che alla spesa pubblica d’emergenza seguiranno una stretta austeritaria e una nuova macelleria sociale. In quel quadro, l’emergenza – più prosaicamente: la situazione causata dalla pandemia e/o dal «lockdown», con conseguente necessità di «ripartire» – verrà usata per giustificare ogni passo indietro su terreni come il lavoro, l’ambiente, il welfare, la scuola, la sanità stessa…
Già un mese fa Confindustria ha chiesto la sospensione dei contratti nazionali e una rinegoziazione azienda per azienda di turni, orari e quant’altro, mentre c’è chi propone che la Lombardia e altre zone più colpite dalla pandemia divengano ZES, «zone economiche speciali» dove valgano deroghe fiscali e sui diritti dei lavoratori.
La “ripartenza” sta già avvenendo a colpi di grandi opere inutili: i governatori lanciano i progetti di ulteriori colate d’asfalto, si trovano supercazzole per giustificare la ripresa dei lavori sulla Torino-Lione, si torna persino a proporre il Ponte sullo Stretto di Messina… e «il sì è trasversale», titolano i giornali.
Si sono fatti giant steps a ritroso sulla questione della plastica: subito prima dell’emergenza sembrava una questione cruciale, circondata di indignazione, i fiumi e i mari pieni di plastica, gli animali uccisi dalla plastica, cosa fare della plastica… Poi la plastica ha invaso le nostre vite come non mai: miliardi e miliardi di paia di guanti, di flaconi di amuchina et similia, di sacchetti e vaschette di cibo ordinato su Just Eat o Deliveroo, e l’imballaggio della roba ordinata on line…
La plastica ha detto, imperiosa: – Non vi libererete di me.
E tutti hanno risposto: – Ah, ok.

Questi mesi di DAD hanno fatto schifo a chiunque li abbia vissuti sulla propria pelle, ma sono stati cruciali per imporre più privatizzazione strisciante della scuola. Al contempo, l’emergenza è usata per chiedere più verticismo e autoritarismo nella vita scolastica: più potere ai dirigenti e meno prerogative agli organi collegiali, detestato residuo di anni Settanta. A tale proposito, si leggano le proposte – e si valuti l’anglicorum aziendalistico – dell’ANP (la più grande associazione nazionale di dirigenti scolastici).
Nel dicembre scorso avevamo scattato la fotografia di una fase di contraccolpo, di backlash contro i colossi del Big Tech, con appannamento dell’immagine delle grandi piattaforme racchiuse nell’acronimo GAFAM: Google Apple Facebook Amazon e Microsoft. Oggi, grazie all’emergenza coronavirus, l’immagine di quelle corporation è tornata a scintillare, hanno “dimostrato” di essere imprescindibili, hanno “salvato” la scuola e la società, hanno macinato profitti portentosi mentre nessuno più parlava del loro strapotere, del data mining, del capitalismo della sorveglianza ecc. E lo #stareincasa ha portato al parossismo le dinamiche tossiche dei social media che avevamo descritto.
Sono solo alcuni esempi di quanto l’emergenza coronavirus ci abbia riportati indietro. E in generale, poiché per diversi mesi non si è potuto parlare d’altro, oggi ci ritroviamo aggrediti da tutti i problemi aggravatisi nel frattempo, con percorsi di lotta – come quello sul clima – da riavviare più o meno da capo, e con destre e complottisti vari a intercettare la rabbia sociale e deviarla verso sbocchi reazionari.
12. Un «canto di Natale» a primavera
 L’istinto generalizzato sarà quello di lasciarsi rapidamente l’esperienza traumatica alle spalle. Casomai ci sarà da lavorare sulla sindrome post-traumatica, che agisce più sottilmente di quanto si immagini. Chi è caduto negli equivoci di cui sopra per un po’ resterà afasico, poi tornerà a esternare come se nulla fosse accaduto.
L’istinto generalizzato sarà quello di lasciarsi rapidamente l’esperienza traumatica alle spalle. Casomai ci sarà da lavorare sulla sindrome post-traumatica, che agisce più sottilmente di quanto si immagini. Chi è caduto negli equivoci di cui sopra per un po’ resterà afasico, poi tornerà a esternare come se nulla fosse accaduto.
Ciò che rimarrà, nella percezione o nell’inconscio collettivo, è quel che l’emergenza ha rivelato del paese e di noi stessi: i meccanismi di cattura, gli scambi spettacolari, la segregazione domestica, la paradossale convivenza di paranoia e scetticismo, la bolla nefasta dei social media e l’intruppamento dei mass media che hanno avvelenato l’aria, lo stato di polizia e l’appoggio da sinistra a un governo ultraconfindustriale (prima, durante e dopo la pandemia), i quindici miliardi alle imprese e gli spiccioli alla scuola pubblica. E ovviamente la povertà. Perché c’è gente alla fame. Letteralmente.
Crediamo che questa vicenda abbia messo davvero il paese allo specchio e gli abbia mostrato il suo vero volto. Ora, appunto, ci si affretterà a passare oltre, perché nessuno vuole pensare sempre all’orrore delle decine di migliaia di morti e all’infelicità e sofferenza dei tre mesi scorsi. Ma nella retina rimarrà comunque impressa quell’immagine di sé tanto ridicola quanto inquietante e orribile. Per quello che si è stati capaci di esprimere, perdendo la testa e il raziocinio e abbandonandosi al dolore, al panico, alle fobie.
Quell’immagine, spinta alla periferia del campo visivo, potrà essere colta con la coda dell’occhio in ogni momento, per quanto ignorata dalla coscienza, fino a diventare, nelle notti che verranno, una sorta di spettro dickensiano del «Natale passato».


 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)