di Diego Gabutti
 Mai più tornato ad Avellino. Tra la stazione e la caserma c’era un lunghissimo viale. Mi sembra non fosse alberato, anche se non posso giurarlo. Era estate. Ricordo un largo marciapiede percorso da cittadini dall’aspetto rilassato. Avevano l’aria di poter passeggiare avanti e indrè senza fare nient’altro dal mattino alla sera, e senza mai annoiarsi (col tempo, letti molti libri sull’argomento, che interpretai come manuali, e stufo di spostarmi in automobile, avrei imparato anch’io l’arte del flâneur). Ricordo anche d’avere avuto l’impressione, mentre andavo per la prima volta dalla stazione alla caserma, che Avellino consistesse di quell’unico viale affiancato da due singole file di case, di tre-quattro piani al massimo, oltre le quali, a destra e a sinistra, c’era subito la campagna aperta.
Mai più tornato ad Avellino. Tra la stazione e la caserma c’era un lunghissimo viale. Mi sembra non fosse alberato, anche se non posso giurarlo. Era estate. Ricordo un largo marciapiede percorso da cittadini dall’aspetto rilassato. Avevano l’aria di poter passeggiare avanti e indrè senza fare nient’altro dal mattino alla sera, e senza mai annoiarsi (col tempo, letti molti libri sull’argomento, che interpretai come manuali, e stufo di spostarmi in automobile, avrei imparato anch’io l’arte del flâneur). Ricordo anche d’avere avuto l’impressione, mentre andavo per la prima volta dalla stazione alla caserma, che Avellino consistesse di quell’unico viale affiancato da due singole file di case, di tre-quattro piani al massimo, oltre le quali, a destra e a sinistra, c’era subito la campagna aperta.
Nei cortili delle case, lungo la strada, ricordo un vasto spentolio di pomodori messi a cuocere in grandi marmitte alimentate a legna, su grandi falò. Altre vaste distese di pomodori se ne stavano al sole a seccare. Era evidentemente la stagione della salsa e dei pomodori secchi. Mai saputo che ce ne fosse una. Gli odori erano intensi, i colori accesi, il rosso una vampa. Mai visto prima niente di simile. Praticamente un altro pianeta. E in fondo al viale, la caserma.
 Qui mi consegnarono (attenti, riposo, spall’arm) una divisa estiva da bersagliere, fez e tutto, compreso il cappellone di metallo piumato (anche se dire piumato, di quello sproposito di piume, roba da Ziegfeld Folies, è riduttivo). In libera uscita s’indossava il fez (rosso, il pon-pon blu madonna) che metteva allegria a bambini e burloni. Mi piaceva passeggiare per Avellino, il caffè era ottimo, idem le pastarelle, finché non saltò fuori che giù per il viale, quando capitava d’incrociare un ufficiale o anche solo un maresciallo, si doveva scattare sull’attenti, sbattere i tacchi e portare la mano a visiera sulla fronte. Marescialli e capitani non erano uomini ma caporali: per scacciare lo spleen, e spassarsela a spese delle reclute, non facevano che andare su e giù dalla stazione beandosi dei saluti militari. Personalità autoritarie calzate e vestite, accidenti a loro.
Qui mi consegnarono (attenti, riposo, spall’arm) una divisa estiva da bersagliere, fez e tutto, compreso il cappellone di metallo piumato (anche se dire piumato, di quello sproposito di piume, roba da Ziegfeld Folies, è riduttivo). In libera uscita s’indossava il fez (rosso, il pon-pon blu madonna) che metteva allegria a bambini e burloni. Mi piaceva passeggiare per Avellino, il caffè era ottimo, idem le pastarelle, finché non saltò fuori che giù per il viale, quando capitava d’incrociare un ufficiale o anche solo un maresciallo, si doveva scattare sull’attenti, sbattere i tacchi e portare la mano a visiera sulla fronte. Marescialli e capitani non erano uomini ma caporali: per scacciare lo spleen, e spassarsela a spese delle reclute, non facevano che andare su e giù dalla stazione beandosi dei saluti militari. Personalità autoritarie calzate e vestite, accidenti a loro.
Fortuna che avevo con me il contro-incantesimo: una copia della Dialettica negativa di Theodor Wiesengrund Adorno, il fenomeno filosofico della prima metà della seconda metà del Novecento. Rilegato e con sovraccoperta, era un libro giallo canarino (colore per il quale anch’io, come Nero Wolfe, ho sempre avuto un debole).
Comprata qualche giorno prima, a Milano, alla Feltrinelli di Via Manzoni, dov’ero capitato per caso, sapevo perché mi ero portato in partibus infidelium la Dialettica negativa, summa del pensiero adorniano, appena tradotto da noi ma uscito in Germania sette anni prima, nel 1963. Era per consolarmi in quest’improvvisa curva a gomito della vita, adesso che mi toccava portare il fez come Totò nella parte del Turco Napoletano («Guarda Omar quant’è bello!») Politicamente radical, filosoficamente chic, giallo canarino, Dialettica negativa era un saggio tirabaci.
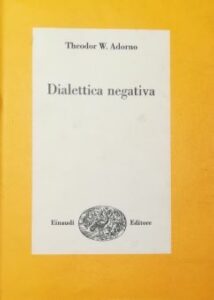 Cominciava così, con un incipit incantatorio che diceva: «La filosofia, che una volta sembrò superata, si mantiene in vita, perché è stato mancato il momento della sua realizzazione. Il giudizio sommario, che essa abbia semplicemente interpretato il mondo e che per rassegnazione di fronte alla realtà sia diventata monca anche in sé, diventa disfattismo della ragione, dopo che è fallita la trasformazione del mondo».
Cominciava così, con un incipit incantatorio che diceva: «La filosofia, che una volta sembrò superata, si mantiene in vita, perché è stato mancato il momento della sua realizzazione. Il giudizio sommario, che essa abbia semplicemente interpretato il mondo e che per rassegnazione di fronte alla realtà sia diventata monca anche in sé, diventa disfattismo della ragione, dopo che è fallita la trasformazione del mondo».
Monca. In sé. Disfattismo della ragione.
Non si poteva dir meglio – qualunque cosa, però, si volesse dire, e mica era chiaro. Che fosse colpa della traduzione? Delle virgole traballanti? Del tono incravattato e per così dire «animalescamente serioso», come altrove diceva lo stesso Adorno, diffidando forse un po’ anche di se stesso, oltre che d’interpreti e traduttori? O io duro?
Anni dopo, in una sorta di divorzio unilaterale musulmano, le Edizioni Einaudi ripudiarono la prima traduzione di Dialettica negativa, edita nel 1970, per sostituirla con un’altra, che apparve nel 2004. Colpita da un Verboten, della prima traduzione svanì ogni traccia.
Sempre con scarso riguardo per le virgole, lasciamo per un momento il senso da parte, adesso si poteva leggere questo nuovo incipit: «La filosofia, che una volta sembrò superata si mantiene in vita perché è stato mancato il momento della sua realizzazione. Il giudizio sommario, che abbia semplicemente interpretato il mondo e che per rassegnazione di fronte alla realtà sia paralizzata anche internamente, si trasforma in disfattismo della ragione, dopo che la trasformazione del mondo è fallita».
Non cambiava granché. Anzi, da come la vedo adesso, la nuova traduzione era meno sculettante e fascinosa della vecchia. Ma passons. Dopo la prima libera uscita, salutato il mio primo ufficiale e subito rientrato in caserma, ero corso ai ripari.
Giovane e convincente come il demonio, e se non bravo bidonista io allora babbioni loro, chiesi e ottenni di preparare il mio esame sulla Dialettica negativa dal comandante di compagnia (o comunque si dica) evitando l’addestramento. Mostrai il bel tomo, lo sfogliarono, e anche loro rimasero basiti. Non avevo nessun esame da preparare, naturalmente. Non ero neppure iscritto all’università. Furono tutti molto gentili. Mi venne riservato uno stanzone al primo piano, in fondo al cortile delle adunate.
Me ne stavo lì, cinque o sei ore al giorno, tutto solo, senza correre né saltare come gli altri bersaglieri, mai disturbato da nessuno, sonnecchiando e masticando caramelle gommose di liquerizia. C’era uno spaccio sempre aperto, e ogni tanto scendevo per una Coca, o un Buondì Motta. Leggevo la Dialettica, senza capirne una parola ma proprio per questo prendendoci sempre più gusto. Adorno era divertente, certamente malgré lui, ma comunque una vera sagoma, quando liquidava Heidegger per «l’oscurità, in cui nemmeno si formano più mitologemi come quello della realtà delle immagini». Oppure quando spiegava che «la filosofia non è scienza, né poesia di pensieri, come il positivismo con uno stupido ossimoro vorrebbe degradarla, bensì una forma mediata e distinta da ciò che è diverso da essa». Mitologemi! Oscurità! Che meraviglia!
Intendiamoci: vero che leggendola non si capiva granché: argomentazioni oscure, immagini belle e imperscrutabili. Ma la tesi, se non la sostanza, della Dialettica negativa era sotto gli occhi di chiunque si fosse preso il disturbo di dare anche soltanto un’occhiata, non importa quanto distratta, alla copertina del libro. C’era tutto lì nel titolo: «dialettica negativa» era praticamente uno spoiler.
Tesi, antitesi ma niente sintesi: Adorno predicava (anche se questa non è la parola giusta, però un po’ sì) una dialettica celibe, astratta e irriducibilmente teorica, persino un po’ astrattista, come le macchine dei surrealisti, queste e quella improprie all’uso. Negativa, la sua era una dialettica iconoclasta, e ai tempi (in primis) antisessantottesca, senza poster da venerare, tiranni da compiacere, popoli e classi da coglionare.
 Era una dialettica che non si proponeva nulla di pratico o di concreto e che anzi si vietava ogni proposito (come diceva egli stesso altrove, proprio parlando d’evasione, dunque anche di queste pagine, a pensarci bene). Non c’era qui una delle sue agili acrobazie linguistiche seguite dall’oplà, come al circo, dopo che si sono esibiti i trapezisti macedoni, dopo la sfilata degli elefanti ballerini e la piramide umana. Niente lancia in resta. Niente «e ora a noi due, fellone». Era una dialettica senza l’elmetto calato sugli occhi. Era cioè una filosofia che negava puramente e semplicemente senso all’ambaradan della rivoluzione per finta (come la chiamava lui: sovietica, cinese, cubana, sessuale o variamente giovanile che fosse). Non potevi piegarla a schiamazzare nei cortei, a proclamare che la lotta continua, che l’utero è mio, che il vento dell’est prevale sul vento dell’ovest e altre bandiere al vento. Forse troppo negativa, la dialettica adorniana si perdeva così, diciamocelo, tutto il divertimento: jazz e rock’roll, cinema, radio, romanzetti, cartoni animati e insomma tutto ciò che, mentre la vita (notoriamente) non vive, almeno un po’ si sforza d’ammazzare il tempo. Adorno, tra le innumerevoli cose che detestava, naturalmente disprezzava in particolar modo che s’ammazzasse il tempo, benché fosse proprio per ammazzare il tempo che si dilettava col freudismo, la musica dodecafonica, l’arte d’avanguardia. Ma proprio questa sua particolare ottusità era la sua forza. Proclamando il primato Über Alles della teoria della Kultur, egli aveva fatto qualcosa, ai miei occhi, di eminentemente pratico: aveva classificato il militantismo e le fanfaronate gosciste in genere, cioè l’identikit nel quale non potevo evitare (ahimè) di riconoscermi, nello stesso repertorio flaubertiano di cui anche la Dialettica negativa, come tutta l’opera d’Adorno, era in qualche modo l’aggiornamento a quello che i marxisti chic avrebbero poi detto «secolo breve» e che lui, più opportunamente, avrebbe definito invece «dopo Auschwitz», l’inizio d’una nuova età del mondo. In Adorno c’era qualcosa di Bartleby, lo scrivano di Melville, e di Amadeo Bordiga, il comunista che non s’unì mai allo spettacolo. Come loro, anche Adorno, «preferiva di no». E così anch’io, che li approvavo tutti, per la loro negatività, con una passione da nerd.
Era una dialettica che non si proponeva nulla di pratico o di concreto e che anzi si vietava ogni proposito (come diceva egli stesso altrove, proprio parlando d’evasione, dunque anche di queste pagine, a pensarci bene). Non c’era qui una delle sue agili acrobazie linguistiche seguite dall’oplà, come al circo, dopo che si sono esibiti i trapezisti macedoni, dopo la sfilata degli elefanti ballerini e la piramide umana. Niente lancia in resta. Niente «e ora a noi due, fellone». Era una dialettica senza l’elmetto calato sugli occhi. Era cioè una filosofia che negava puramente e semplicemente senso all’ambaradan della rivoluzione per finta (come la chiamava lui: sovietica, cinese, cubana, sessuale o variamente giovanile che fosse). Non potevi piegarla a schiamazzare nei cortei, a proclamare che la lotta continua, che l’utero è mio, che il vento dell’est prevale sul vento dell’ovest e altre bandiere al vento. Forse troppo negativa, la dialettica adorniana si perdeva così, diciamocelo, tutto il divertimento: jazz e rock’roll, cinema, radio, romanzetti, cartoni animati e insomma tutto ciò che, mentre la vita (notoriamente) non vive, almeno un po’ si sforza d’ammazzare il tempo. Adorno, tra le innumerevoli cose che detestava, naturalmente disprezzava in particolar modo che s’ammazzasse il tempo, benché fosse proprio per ammazzare il tempo che si dilettava col freudismo, la musica dodecafonica, l’arte d’avanguardia. Ma proprio questa sua particolare ottusità era la sua forza. Proclamando il primato Über Alles della teoria della Kultur, egli aveva fatto qualcosa, ai miei occhi, di eminentemente pratico: aveva classificato il militantismo e le fanfaronate gosciste in genere, cioè l’identikit nel quale non potevo evitare (ahimè) di riconoscermi, nello stesso repertorio flaubertiano di cui anche la Dialettica negativa, come tutta l’opera d’Adorno, era in qualche modo l’aggiornamento a quello che i marxisti chic avrebbero poi detto «secolo breve» e che lui, più opportunamente, avrebbe definito invece «dopo Auschwitz», l’inizio d’una nuova età del mondo. In Adorno c’era qualcosa di Bartleby, lo scrivano di Melville, e di Amadeo Bordiga, il comunista che non s’unì mai allo spettacolo. Come loro, anche Adorno, «preferiva di no». E così anch’io, che li approvavo tutti, per la loro negatività, con una passione da nerd.
Frugando nella biblioteca della caserma trovai Addio, Mr Chips! di James Hilton, una storia strappacore che invece, al contrario della Dialettica, suonava limpida, trasparente, cristallina e immediatamente comprensibile come una rima del Signor Bonaventura o una melodia di Lennon-McCartney, diciamo Penny Lane, o Eleanor Rigby. C’era nel romanzo questo timido professore. Hilton ne raccontava la vita dalla giovinezza all’età veneranda. Gli allievi, il college, l’alpinismo, gli affanni e la pensione, gli esami, la moglie troppo presto scomparsa. Ricordavo il film con Greer Garson e Robert Donat del 1939. Adorno, naturalmente, lo avrebbe detestato, come detestava un po’ tutto, a cominciare, lui musicologo, dal jazz. «Il cinema rende stupidi», diceva. Quanto a me, al film preferivo il romanzo.
C’era un gran caldo. Mai mangiato sbobbe più schifose; il profumo violento e speziato delle salse di pomodoro dava alla testa più del vino e del limoncello che la sera giravano nelle camerate torride. Mentre le altre reclute, per salire dal primo al secondo e al terzo piano, dovevano issarsi su per una corda, come fachiri, io usavo le scale.
Non li avevo con me, ma da tempo ero un fan dei Minima Moralia e della Dialettica dell’illuminismo. Quelli erano libri che si capivano, scritti in punta di penna, «poesia di pensieri» purissima, piacesse o spiacesse all’autore, anzi agli autori, visto che la Dialettica dell’illuminismo era firmata, oltre che da Adorno, da Max Horkheimer, del quale si diceva che, ricco sfondato com’era, si fosse comprato, pagando cash, l’Institut für Sozialforschung, poi detto Scuola di Francoforte, di cui era il plenipotenziario.
Chi ha letto da giovane gli aforismi di Adorno e la Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkheimer diventa magari un po’ snob ma almeno è vaccinato per sempre contro la volgarità delle ideologie radicali. Non ho orecchio per la musica, a meno che non sia musica pop per massaie e giovinastri (così come non ho orecchio per la narrativa alta, e leggo quasi esclusivamente romanzi in cui c’è minimo una galassia da salvare o il cadavere d’un assassinato dentro una camera chiusa dall’interno). Così non ho mai letto (sfogliato sì, un’occhiata veloce non si nega a nessun libro) i saggi di critica e filosofia musicale di Adorno. Può darsi che siano bellissimi. Anzi, lo saranno senz’altro e prima o poi, avanzandomene tempo, chissà che non mi decida a leggerli davvero. Ma l’Adorno macchinoso, ermetico, inesplicabile, che rimprovera agli altri il ricorso alle oscure trivialità del gergo filosofico, quando lui ne è un campione insuperabile e i suoi traduttori anche peggio, mi piaceva non perché m’impartisse chissà quale lezione di saggezza ma perché mi piaceva l’orrido: il Mulo Francis, Andy Wharol, gli «elseworlds» della DC Comics, La Chinoise di Godard e adesso anche la Negative Dialektic adorniana (tesi, antitesi, ma niente sintesi). In realtà, più che di Adorno, ero un tifoso dei suoi virtuosismi di prosatore, cioè dei Minima Moralia, tra i libri più belli mai scritti. Niente di personale. Erano affari estetici.
 Pochi anni dopo – via da Avellino e dal servizio militare, di cui non mi resta neppure un souvenir, e non mi spiacerebbe avere nell’armadio il cappello piumato o almeno il fez, nonché ormai sposato e con figli pargoletti – io e il mio amico e compare Paolo Pianarosa, oggi malauguratamente scomparso, celebrammo i Mimima Moralia con un pamphlet stile Stanlio e Ollio intitolato Adorno sorride. Era un titolo che omaggiava insieme Adorno e William S. Burroughs («Tio Mate Smiles, The Chief Smiles, Old Sarge Smiles», da Wild Boys, apparso da noi nel 1973 come Ragazzi selvaggi). Oltre alla fissa per Adorno ne avevamo una anche per Burroughs. C’erano solo fisse, ai tempi. O gioventù!
Pochi anni dopo – via da Avellino e dal servizio militare, di cui non mi resta neppure un souvenir, e non mi spiacerebbe avere nell’armadio il cappello piumato o almeno il fez, nonché ormai sposato e con figli pargoletti – io e il mio amico e compare Paolo Pianarosa, oggi malauguratamente scomparso, celebrammo i Mimima Moralia con un pamphlet stile Stanlio e Ollio intitolato Adorno sorride. Era un titolo che omaggiava insieme Adorno e William S. Burroughs («Tio Mate Smiles, The Chief Smiles, Old Sarge Smiles», da Wild Boys, apparso da noi nel 1973 come Ragazzi selvaggi). Oltre alla fissa per Adorno ne avevamo una anche per Burroughs. C’erano solo fisse, ai tempi. O gioventù!
 Fu Elvio Fachinelli, psicoanalista e grande firma sessantottesca, a chiederci d’intervenire con un libretto satirico sulla polemica divampata nel 1977 a proposito di certi aforismi dei che non erano stati tradotti nell’edizione Einaudi del 1954. Fachinelli, che in quel livido crepuscolo del Sessantotto, dirigeva una rivista chiamata L’erba Voglio e la casa editrice omonima, aveva pubblicato, tradotti da Gianni Carchia, saggista e filosofo molto amico di Paolo, gli aforismi «censurati». Entrerei nei particolari, ma sono noiosi, quindi lasciamoli fuori.
Fu Elvio Fachinelli, psicoanalista e grande firma sessantottesca, a chiederci d’intervenire con un libretto satirico sulla polemica divampata nel 1977 a proposito di certi aforismi dei che non erano stati tradotti nell’edizione Einaudi del 1954. Fachinelli, che in quel livido crepuscolo del Sessantotto, dirigeva una rivista chiamata L’erba Voglio e la casa editrice omonima, aveva pubblicato, tradotti da Gianni Carchia, saggista e filosofo molto amico di Paolo, gli aforismi «censurati». Entrerei nei particolari, ma sono noiosi, quindi lasciamoli fuori.
Cesare Cases, pezzo grosso della casa editrice, e Renato Solmi, il traduttore dell’edizione sotto attacco, nonché co-curatore delle Meraviglie del possibile (come abbiamo appena visto) con Franco Lucentini, autori Cases e lui di libri memorabili, non la presero bene. Quale censura, allibirono Solmi e Cases all’uscita delle traduzioni di Cechia? Di che parlano questi qua?
E la presero anche peggio quando gli toccò leggere Adorno sorride, dov’erano spietatamente svillaneggiati, messi in croce e sbertucciati, benché Fachinelli, Carchia, Paolo e io avessimo torto e loro ragione, almeno a proposito degli aforismi soppressi. Magari si meritavano quella gran tempesta di frizzi e lazzi in quanto establishment culturale e icone, ai nostri occhi goscisti, dell’egemonismo stalino-gramsciano-berlingueriano che, sempre ai nostri occhi, ma non soltanto ai nostri, si stava divorando l’Italietta. C’era un che di zdanoviano nel catalogo Einaudi (come avrebbero messo in chiaro, beffeggiatori ben più temibili e puntuti di noi, Carlo Fruttero e Franco Lucentini nel loro cult del 1979, A che punto è la notte, che fece il marxismo-einaudismo a brandelli). Si dice che Giulio Einaudi in persona, nei primi cinquanta, fu dissuaso dal pubblicare le opere complete di Peppone Stalin solo a un pelo dalla firma del contratto. Ma nessun einaudiano aveva censurato i Minima Moralia.
A che scopo censurarli, poi? Gli aforismi soppressi non dicevano niente di diverso da tutti gli altri. Avevamo un bell’inventare, Paolo e io, che fossero stati «sbianchettati» (come allora non si diceva ancora, ma c’eravamo quasi) perché in «aperta contraddizione» con la politica culturale del Pci, quale che fosse (Repubblica e l’Unità? il catalogo degli Editori Riuniti? Linus?) Non era vero. Ed era, anzi, una sciocchezza. Gli aforismi furono verosimilmente tagliati vuoi perché giudicati meno brillanti degli altri vuoi per sfoltire un libro troppo massiccio. Non fu bello, ma non fu neanche un crimine. Adorno, per quanto si dichiarasse ostile al socialismo reale, non era Solženicyn (che Umberto Eco, a proposito d’egemonismo stalino-gramsciano, aveva definito in quegli stessi anni «un Dostoevskij da strapazzo», e ciò proprio mentre l’autore di Arcipelago Gulag era nelle grinfie del KGB). Solmi e la redazione Einaudi non ricorsero alla guida pratica dell’Index Librorum Prohibitorum in versione bolscevica per cancellare con un Fiat Tenebris gli aforismi in eccesso. Ricorsero, più in piccolo e senza far danni, all’ambarabaciccicoccò. Ma Paolo e io trovammo divertente fingere indignazione.
Sul momento non lo capì nessuno, che per il senno di poi ci vuole tempo e pazienza, ma era cominciata l’età del falso sdegno, che presto sarebbe dilagato ovunque, come le armate degli zombie nei serial Netflix: questione morale, morte alla casta, politici ladri, democrazia canaglia, evviva e abbasso Berlusconi, il moralismo da talk show, populisti invasati, magistrati buoni e giusti, il fatto quotidiano. Fu il Sessantotto a cominciare, con le sue stizze da barzelletta, e certo anche Adorno, gran moralista, c’entrò per qualcosa. Un minimum di responsabilità tocca pure ai suoi interpreti e laudatores, tipo Paolo e me.
Non che lodassimo, e tanto meno interpretassimo, proprio Th.W. Adorno, la rock star della filosofia. Avevamo caricato a molla un pupazzo che somigliava al secondo violino dell’Institut für Sozialforschung ma che non era lui. Anche la somiglianza era vaga. Ci eravamo costruiti un Adorno che in parte poteva ricordare Clint Eastwood nei film (altra fissa) di Sergio Leone e in parte era un incrocio tra Bruce Lee e Fred Astaire. Un guerriero e un ballerino. Da come la vedevamo noi, questo particolare Adorno con la mascherina nera e un gran mantello da supereroe non s’occupava di filosofia. Quella era una copertura. Lui s’aggirava nei cataloghi editoriali, il solo campo di battaglia che riuscissimo a concepire, deciso a far piazza pulita dei filistei, come diceva Marx dei suoi e nostri nemici: i comunisti ortodossi, quelli eterodossi, da un lato György Lukács perché s’era venduto (il pidocchio) al realismo socialista, dall’altro Herbert Marcuse perché era un francofortese hippeggiante e New Age, la specie filosofica peggiore. Abusammo di questo Adorno action e immaginario fino a farne contemporaneamente un Pulcinella e un Matamoros.
C’inventammo Adorno, in quello scorcio di secolo popolato di lettori rococò, in cui non c’era libro sacro o profano che non rischiasse la maiuscola, come c’inventammo altri Libri e altre chimere: la Trilogia Nova di Bill Burroughs, l’Ispettore Callaghan e il Giustiziere della notte, i Fili del Tempo di Amadeo Bordiga, il cekista Blumkin, Gloria di John Cassavettes, i Warriors di Walter Hill, Walter Benjamin, Blonde on Blonde di Bob Dylan, Siegfried Kracauer, i manichei, per un po’ persino i Seminari di Lacan. Prima della realtà potenziata, con didascalie e sottotitoli visibili solo a chi indossa un visore o punta la fotocamera dell’iPhone sul QR code del monumento o dell’edificio storico, c’erano le biblioteche di libri (e autori) potenziati. Fu Adorno che pompammo di più, senza mostrare misericordia. Gli attribuimmo virtù ridicole e talenti inverosimili.
 Dopo Avellino era stato tutto un crescendo. In una pagina d’Adorno sorride lo disegnammo mentre faceva roteare un randello dietro la schiena. Adorno, un pacifico professore tedesco intimidito dalle studentesse che durante le sue lezioni gli mostravano le tette per beffeggiarlo, era diventato uno squadrista. Me ne vergogno ancora.
Dopo Avellino era stato tutto un crescendo. In una pagina d’Adorno sorride lo disegnammo mentre faceva roteare un randello dietro la schiena. Adorno, un pacifico professore tedesco intimidito dalle studentesse che durante le sue lezioni gli mostravano le tette per beffeggiarlo, era diventato uno squadrista. Me ne vergogno ancora.
 Scomparso nel 1969, il poveretto non poteva difendersi dai suoi laudatores come, da vivo, non aveva potuto difendersi dalle studentesse in topless. Con me si prese, però, una rivincita postuma. Se anni prima, da militare, m’ero inventato un esame sulla Dialettica negativa, alla metà dei settanta me ne toccò davvero uno, con Gianni Vattimo, sulla Teoria estetica, di cui era appena uscita una traduzione sempre Einaudi, un testo adorniano se possibile ancora più oscuro dell’altro e altrettanto giallo canarino. Presentai all’esame una relazione. Vattimo la lesse, disse di non averci capito niente, zero, non una parola, e francamente ero perplesso anch’io, ma aggiunse che gli erano piaciute la prosa gaglioffa e le carambole dialettiche, complimenti.
Scomparso nel 1969, il poveretto non poteva difendersi dai suoi laudatores come, da vivo, non aveva potuto difendersi dalle studentesse in topless. Con me si prese, però, una rivincita postuma. Se anni prima, da militare, m’ero inventato un esame sulla Dialettica negativa, alla metà dei settanta me ne toccò davvero uno, con Gianni Vattimo, sulla Teoria estetica, di cui era appena uscita una traduzione sempre Einaudi, un testo adorniano se possibile ancora più oscuro dell’altro e altrettanto giallo canarino. Presentai all’esame una relazione. Vattimo la lesse, disse di non averci capito niente, zero, non una parola, e francamente ero perplesso anch’io, ma aggiunse che gli erano piaciute la prosa gaglioffa e le carambole dialettiche, complimenti.
Ebbi un 30 e lode al buio, come a poker. Lì per lì fui contento. Poi realizzai che il vero voto, come in una ghost story, me lo aveva dato Adorno con una randellata ectoplasmica. Mi aveva lanciato la maledizione dell’oscurità. E adesso ero come posseduto: lui avrebbe detto che avevo «introiettato» l’adornismo.
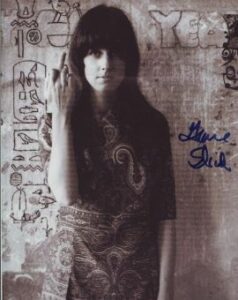 Leggendo i suoi Tre Studi su Hegel capii cos’era successo di preciso. Anche lui era stato posseduto, in giovinezza, da un filosofo che parlava oscuro, G.W.F. Hegel: «Gli ostacoli che le [sue] grandi opere frappongono all’intelligenza del testo, sono qualitativamente diversi da quelli che offrono altri testi famigerati per la loro difficoltà. È il senso stesso che in molta parte è in dubbio ci sia, e fin qui nessun’arte ermeneutica è riuscita a stabilirlo in modo incontrovertibile. Nella cerchia dei grandi filosofi Hegel è l’unico nel cui caso non si sa, alla lettera, e nemmeno si può convincentemente decidere di che cosa mai si stia discorrendo». Contagiato da Hegel, di cui aveva «introiettato» prosa gaglioffa e carambole dialettiche, anche Adorno era caduto sotto l’incantesimo dell’oscurità, che poi aveva trasmesso a me e agli altri suoi tifosi in giro per il mondo, certo pure alle studentesse sberflone di Heidelberg o Francoforte.
Leggendo i suoi Tre Studi su Hegel capii cos’era successo di preciso. Anche lui era stato posseduto, in giovinezza, da un filosofo che parlava oscuro, G.W.F. Hegel: «Gli ostacoli che le [sue] grandi opere frappongono all’intelligenza del testo, sono qualitativamente diversi da quelli che offrono altri testi famigerati per la loro difficoltà. È il senso stesso che in molta parte è in dubbio ci sia, e fin qui nessun’arte ermeneutica è riuscita a stabilirlo in modo incontrovertibile. Nella cerchia dei grandi filosofi Hegel è l’unico nel cui caso non si sa, alla lettera, e nemmeno si può convincentemente decidere di che cosa mai si stia discorrendo». Contagiato da Hegel, di cui aveva «introiettato» prosa gaglioffa e carambole dialettiche, anche Adorno era caduto sotto l’incantesimo dell’oscurità, che poi aveva trasmesso a me e agli altri suoi tifosi in giro per il mondo, certo pure alle studentesse sberflone di Heidelberg o Francoforte.
Era – inconfondibilmente – il principio del motivetto diabolico enunciato da Mark Twain in un celebre racconto: Oh fattorino dal ciuffo nero / fora il biglietto al… / fora il biglietto al… / al passeggeero! / Foralo bene, con diligenza / fin dal momento del… / fin dal momento del… / della parteeenza! (questa la remota versione Rai del motivetto satanico). Non puoi smettere di canticchiarlo fin quando non lo appiccichi a qualcun altro che comincia a canticchiarlo dopo averlo ascoltato da te. Personalmente non me ne sono mai sbarazzato del tutto. Quanto a Th.W. Adorno, non l’ho praticamente più letto, e non ne sento il bisogno. Ma vent’anni fa, nel 2003, il suo fantasma tornò a battere un colpo.
Su «Repubblica» del 12 febbraio, che lessi in un caffè sulle ramblas, a Barcellona, dov’ero finito con mia moglie per una breve vacanza, Cesare Cases citò Adorno sorride rievocando l’epoca sventurata «in cui si riteneva che la rivoluzione fosse stata mancata per un libro non tradotto». Fu allora che «due giovani sciagurati capirono che Minima Moralia era stato tagliato di circa un terzo (col consenso dell’autore) e menarono grande scalpore». Telefonai a Paolo dall’hotel. Anche lui fu contento d’essere definito uno sciagurato. Alla nostra età, già quasi veneranda, le soddisfazioni erano rare.
Mi ero portato a Barcellona, per svagarmi, gli albi di Cocco Bill pubblicati sul Giorno dei ragazzi nei remoti sessanta. Erano poi usciti, come supplementi del giornale, in otto albi separati, che io avevo smarrito da ragazzino e che avevo ricomprato in una libreria antiquaria, strapagandoli. Avevo lavorato più di dieci anni per il Giorno, ma quando ci arrivai io non era più un gran giornale, come all’epoca degli albi di Cocco Bill, ghiotti come pagine di Carlo Emilio Gadda («La cucaracia, la cucaracia! Cocco Bill è un diavolon! / La cucaracia,la cucaracia! Cocco Bill del corazon!»).
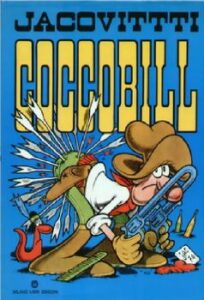 Avevo cominciato a rileggerli, passati quarant’anni, uno o due giorni prima, appena arrivato in Spagna. Tornai a rileggerli in un ristorante di Plaça Reial, sotto i portici, dove Sonia e io, quella sera, sedemmo dopo una lunga flânerie. Sul tavolo briciole di pane, una bottiglia mezza vuota di vino profumato, Repubblica con l’articolo di Cases, i resti d’un baccalà alla catalana e Kamumilla Cocco Bill.
Avevo cominciato a rileggerli, passati quarant’anni, uno o due giorni prima, appena arrivato in Spagna. Tornai a rileggerli in un ristorante di Plaça Reial, sotto i portici, dove Sonia e io, quella sera, sedemmo dopo una lunga flânerie. Sul tavolo briciole di pane, una bottiglia mezza vuota di vino profumato, Repubblica con l’articolo di Cases, i resti d’un baccalà alla catalana e Kamumilla Cocco Bill.
Non c’era poi tutta questa differenza da Avellino, incalcolabili anni prima, quando smanettavo la Dialettica negativa cercando una password per craccare le tenebre della filosofia, inalavo zaffate di salsa al pomodoro, leggevo Addio, Mr Chips! ricacciando i lacrimoni e portavo il fez. A parte Cases, Cocco Bill e il baccalà, era cambiato ben poco.
Sciagurato, sorridevo.
