
Viva la iena!
Ormai se lo aspettavano anche i sassi. L’unico dubbio era sui tempi dell’agonia terminale. Eppure, in meno di ventiquattr’ore, l’annuncio si è già trasformato in una notizia bomba: Oscar Natale Farinetti ha deciso di chiudere FICO, l’inquietante Fabbrica Italiana COntadina, figlia della sua Eataly e del «modello Expo 2015», nata sei anni fa nell’area dei mercati generali (CAAB), alla periferia nord-est di Bologna, su un terreno di proprietà del Comune, del valore di 55 milioni di euro, ceduto gratis per quarant’anni e senza bando di gara al presunto “uomo della Provvidenza”, un imprenditore amico di Matteo Renzi (quand’era in auge).
Gli amministratori bolognesi sono rimasti folgorati da questo progetto, lo hanno appoggiato in tutti i modi possibili, ripetendo come un mantra che avrebbe portato a Bologna tra i 5 e i 10 milioni di visitatori all’anno. L’urgenza di completare, nelle sue vicinanze, una strada a quattro corsie è stata più volte giustificata con la necessità di portare le masse alle porte di quest’osceno parco giochi del «food». Lo stesso si è detto per la navetta, sempre deserta, in partenza dalla stazione centrale. Infine, pure la Linea Rossa del nuovo tram porterà lì, come promesso fin dai giorni dell’inaugurazione. Porterà lì, ma intanto FICO chiude.
FICO è stato un pilastro della Bologna turistica: un pilastro immaginario, visto che non è mai arrivato al numero di ingressi di un qualunque ipermercato suburbano. Nondimeno, la nuova idea di città da mangiare, l’odierna Leporlandia, non sarebbe stata la stessa senza la creatura di Farinetti & Segré.

Una tipica giornata a FICO: si sgomitava per passare.
Oggi qualcuno dice che FICO è fallito perché era di plastica, troppo finto, mentre il turismo, sotto le Due Torri, fattura cifre da capogiro perché la città è rimasta autentica. Niente di più falso: FICO è fallito perché, dopo tutto, ne trovi uno più comodo e pittoresco in centro storico, con un discreto sfondo medievale. È fallito perché Bologna stessa gli ha fatto concorrenza, offrendo la stessa minestra, ma confezionata meglio.
Secondo Coalizione Civica, far notare che la débâcle di FICO era ampiamente prevista sarebbe da «iene». Così scrivono nel loro comunicato:
«Sul fallimento di un progetto imprenditoriale si accaniscono facilmente le iene, non vogliamo essere tra quelle. Sarebbe facile dire che eravamo in tanti e diversi a contestare l’idea di Fico, nel progetto, nell’impatto, nella sua narrazione, nell’idea di fondo. Ma oggi non è il tempo di dire chi aveva ragione e chi aveva torto.»
A parte il cliché specista, è trasparente l’imbarazzo di questi ex-movimentisti, dal momento che ad aver ragione era chi continua a contestare quel modello di città, mentre ad aver torto era Matteo Lepore, di cui oggi gli estensori del comunicato sono alleati subalterni. Il loro compito è difenderlo da ogni critica, fargli da scudi umani.
Dovrebbe esserci un limite alla mancanza di pudore. Coalizione Civica lo ha superato da tempo.
Che FICO sarebbe stato un bagno di sangue lo scrivemmo quattro anni prima che aprisse, il 4 dicembre 2013. Per la precisione, lo scrisse Wolf Bukowski, in un post intitolato «Stay FICO, Stay Hungry. Oscar Farinetti e la “Disneyland del cibo” a Bologna, Eataly». All’epoca, in città, a criticare nei dettagli quel progetto era poca gente. C’eravamo noi e Wolf, c’era il blog La foglia di Fico, e non molto altro.
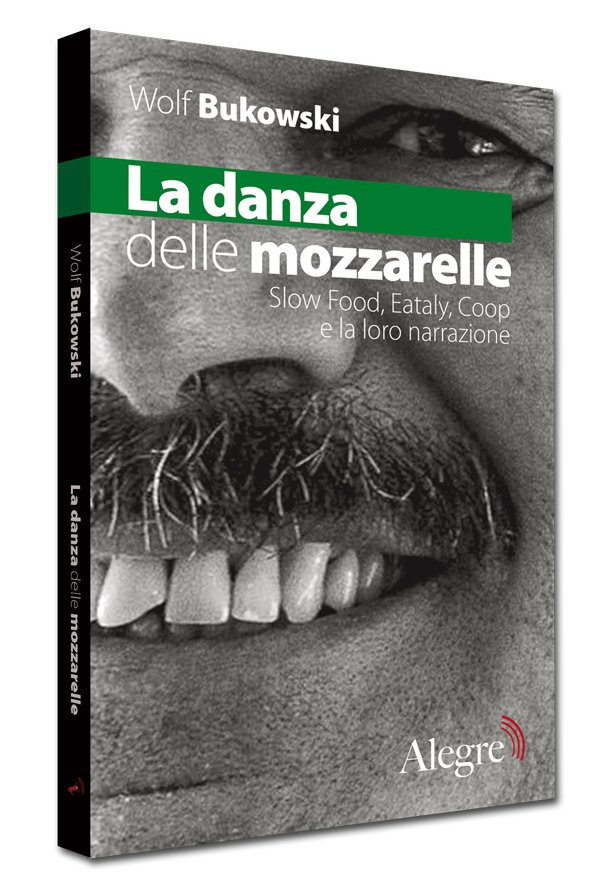 Nel 2015 Wolf eviscerò l’intero modello farinettiano e non solo, in un pamphlet affilato come un rasoio e dalla copertina indimenticabile, da allora più volte ristampato: La danza delle mozzarelle. Slow Food, Eataly, Coop e la loro narrazione (Edizioni Alegre).
Nel 2015 Wolf eviscerò l’intero modello farinettiano e non solo, in un pamphlet affilato come un rasoio e dalla copertina indimenticabile, da allora più volte ristampato: La danza delle mozzarelle. Slow Food, Eataly, Coop e la loro narrazione (Edizioni Alegre).
Poiché c’era ampio margine per smontare anche il modo in cui Farinetti parlava di Resistenza e del chiacchierato padre partigiano, su Giap si fece anche quello. E non era per niente un fuori tema.
Nel 2017, quando FICO inaugurò, Wolf andò a farci un giro. Dall’esperienza trasse un reportage che pubblicammo in tre puntate: «Westworld alla Bolognaise. Viaggio a #FICO, parco distopico farinettiano».
Alla fine del 2018 la défaillance di FICO era già sotto gli occhi di chi volesse vederla. In appendice a una presentazione del film The Harvest, facemmo il punto della situazione, a partire dai dati d’affluenza dichiarati.
Eppure i media locali, Repubblica in primis, con pervicacia negavano l’evidenza, nonostante il moltiplicarsi di inchieste e reportages critici, con titoli come: «Una giornata a FICO, il vuoto pieno di contenuti» o «Fico? Mica tanto».
Ci vollero altri venti mesi prima che, alla buon’ora, su Repubblica si potesse leggere un titolo come: «Bologna, Fico va in rosso: 3 milioni di perdite pre Covid». Era la fine di luglio del 2020.
Ora Farinetti dice che chiude FICO a dicembre per riaprirlo ad aprile, «più grande e più bello di prima». Ennesimo annuncio di restyling e ripartenza, dopo un’inappellabile serie di fallimenti. Sotto il nome di «FICO» si sono già susseguiti almeno tre tentativi diversi di rianimare un moribondo. Il prossimo abbandonerà il marchio «FICO», ormai incenerito, e più che una Disneyland del cibo sarà una specie di «Italia in miniatura».
Farinetti fa e disfa, gioca come un bimbo con i cubi di legno e quando gli gira, va in televisione a raccontare cos’ha in mente. È in questo modo che chi lavora a FICO è venuto a sapere del futuro dell’azienda: altro che piano industriale, prospettive occupazionali, tavoli sindacali… Ai tempi dell’inaugurazione, il patròn di Eataly dichiarò di «godere» nell’assumere le persone, ma già tre mesi più tardi la sua impresa bolognese faceva notizia per i contratti non rinnovati.
Ancora una volta, ci troviamo di fronte alle conseguenze di un gigantismo arrogante e ottuso. Persiste la convinzione che i problemi di un territorio, o di un’infrastruttura, si risolvano solo «pensando in grande», cioè gonfiando tutto a dismisura, senza il minimo senso del limite, come la rana che voleva imitare il bue.
La stessa visione di chi allarga le autostrade e i comprensori sciistici senza neve.
Lo stesso, prevedibile fallimento.

 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)