di James C. Scott
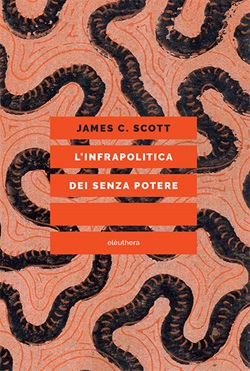 [Di seguito si riporta l’Introduzione al volume di James C. Scott, L’infrapolitica dei senza potere, traduzione di Elena Cantoni, elèuthera, Milano 2024, pp. 336, € 20,00. Si ringrazia la casa editrice per la gentile concessione – gh]
[Di seguito si riporta l’Introduzione al volume di James C. Scott, L’infrapolitica dei senza potere, traduzione di Elena Cantoni, elèuthera, Milano 2024, pp. 336, € 20,00. Si ringrazia la casa editrice per la gentile concessione – gh]
La struttura di questo volume ripercorre almeno tre traiettorie delle mie ricerche, forse simili a quelle di molti colleghi, scienziati sociali ed etnografi che si sono impegnati nello studio della società agraria.
La prima traiettoria è segnata dalla delusione e dalle speranze infrante nel cambiamento rivoluzionario. Si tratta di un’esperienza piuttosto comune per gli americani arrivati alla coscienza politica negli anni Sessanta. Per me e per molti altri, quel decennio rappresentò il culmine di quella che potremmo chiamare una storia d’amore con le modalità contadine di liberazione nazionale. Posto che l’ultimo mezzo secolo è stato un cimitero di speranze infrante anche per quanto riguarda la democrazia, un’autentica autodeterminazione nazionale e la giustizia economica in gran parte degli Stati agrari, non è facile evocare l’ottimismo inebriante che molti nutrivano allora. La morsa delle principali potenze coloniali sui loro imperi d’oltremare era stata spezzata dalle devastazioni della seconda guerra mondiale; alla Conferenza di Bandung, le potenze non allineate avevano proclamato un futuro wilsoniano di nuove nazioni sovrane che avrebbero trattato in regime di parità le une con le altre; e i movimenti rivoluzionari ovunque nel mondo sembravano determinati a cancellare una volta per tutte le schiaccianti ineguaglianze di terre, ricchezza e potere (e dunque opportunità di vita) che avevano segnato l’esistenza di tanta parte della popolazione mondiale. Anche in Occidente, il movimento per i diritti civili degli anni Sessanta negli Stati Uniti, oltre alle rivoluzioni sociali e culturali in Francia e Germania, sembravano parte integrante di una nuova apertura politica e di nuove potenzialità di emancipazione.
Per qualche tempo, io fui totalmente trascinato da questa flusso di possibilità utopiche. Seguii con trepidazione – e, in retrospettiva, con una buona dose di ingenuità – il referendum per l’indipendenza nella Guinea di Sékou Touré, le iniziative panafricane di Kwame Nkrumah, le prime elezioni indonesiane, l’indipendenza e le prime elezioni in Birmania, paese in cui avevo vissuto un anno, e naturalmente le riforme agrarie nella Cina rivoluzionaria e le elezioni nazionali in India.
Il contesto intellettuale e politico del successivo disincanto merita un breve riassunto. Alla fine degli anni Sessanta insegnavo alla University of Wisconsin. Madison era teatro di continue manifestazioni studentesche contro la guerra in Vietnam, a partire dall’impegno teso a impedire alla Dow Chemical, produttrice del napalm, di reclutare nel campus. Con il mio collega e mentore Edward Friedman, tenevo un affollato corso di lezioni sulle «rivoluzioni contadine». L’aula era stipata di quasi quattrocento studenti, per i quali la posta in gioco non era affatto irrilevante dato che nel 1965 c’era la leva obbligatoria. Per gran parte di loro, la nostra impostazione non era abbastanza progressista. Alla fine di ogni lezione gli studenti sgomitavano per impadronirsi dei microfoni e contestarci, e a decine si riunivano a preparare quattro o cinque pagine di contro-argomentazioni da distribuire ai compagni alla lezione successiva. La politica era importante, e tenere una lezione in quelle condizioni era al tempo stesso esaltante e (così sembrava allora) scoraggiante. Fu, tanto per i docenti quanto per gli studenti, un apprendistato d’urto sulla rivoluzione – con l’enfasi sull’urto.
Il disincanto assunse due forme: l’indagine storica e gli eventi contemporanei. Mi resi conto – e avrei dovuto arrivarci prima – che virtualmente ogni grande rivoluzione vittoriosa finiva per creare uno Stato più potente di quello che aveva abbattuto, uno Stato capace a quel punto di estrarre più risorse dalla stessa popolazione al cui servizio si sarebbe dovuto mettere. La Rivoluzione francese aveva portato al Termidoro e poi al precoce e bellicoso Stato napoleonico. La Rivoluzione d’Ottobre in Russia portò alla dittatura leninista del partito d’avanguardia e poi alla repressione degli scioperi dei marinai e operai di Kronštadt, alla collettivizzazione forzata e ai gulag. Se l’Ancien Régime si era retto su brutali disuguaglianze feudali, gli effetti delle rivoluzioni apparivano altrettanto scoraggianti. Non soltanto lo Stato rivoluzionario riusciva a imporsi con una presa sulla società che governava ancora più ferma del predecessore, ma le aspirazioni popolari che avevano fornito l’energia e il coraggio per la vittoria della rivoluzione venivano, in ogni lettura di lungo termine, quasi inevitabilmente tradite. La Rivoluzione messicana fu una significativa eccezione, nel senso che i contadini riuscirono perlomeno a tenersi le terre che avevano strappato alle haciendas.
Gli eventi allora in corso non erano meno inquietanti sul fronte di ciò che le rivoluzioni contemporanee significavano per la classe più vasta nella storia mondiale: i contadini. I Viet Minh, saliti al potere nel Vietnam del Nord dopo la Conferenza di Ginevra del 1954, avevano spietatamente represso una rivolta popolare di piccoli proprietari e agricoltori indipendenti nelle stesse regioni che erano state i focolai storici delle sollevazioni contadine. In Cina diventò evidente che il Grande Balzo in Avanti – nel corso del quale, messa a tacere l’opposizione, Mao costrinse milioni di contadini in vaste comuni agrarie e mense collettive – stava avendo risultati catastrofici. Gli studiosi e gli esperti di statistica discutono ancora dei costi umani inflitti tra il 1958 e il 1962, ma è improbabile che le vittime siano state meno di trentacinque milioni (grosso modo la popolazione attuale del Canada). E proprio nel momento in cui si riconoscevano i costi umani del Grande Balzo in Avanti, le notizie spaventose di carestie ed esecuzioni nella Cambogia dei Khmer rossi completavano un quadro di rivoluzioni contadine degenerate in repressioni letali.
Dunque la delusione non era tanto rispetto ai contadini ma rispetto a coloro che si erano impadroniti del potere, spesso a loro nome e con il loro sostegno, per poi imporre con la forza forme utopiche di collettivizzazione su quella medesima classe. È possibile che sia i contadini sia le élite rivoluzionarie nutrissero delle aspettative utopiche di un nuovo ordine, ma era evidente che le rispettive visioni dell’utopia divergevano in modo radicale.
Chi ha familiarità con quel periodo ricorderà che si assistette anche al primo boom degli studi sullo sviluppo e dell’inedita economia dello sviluppo. Se le élite rivoluzionarie avevano immaginato vasti progetti di ingegneria sociale nella vena collettivistica, gli specialisti dello sviluppo confidavano con pari certezza nella propria capacità di creare crescita economica con l’ingegneria delle forme di proprietà, la promozione della salute pubblica, gli investimenti nell’infrastruttura dei mercati, l’offerta di credito e, quando necessario per competere con i rivoluzionari di sinistra, persino (modeste) ridistribuzioni delle terre. I praticanti dell’arte dello sviluppo, sebbene spesso animati da un personale desiderio di espandere il benessere umano, durante la Guerra Fredda furono di fatto reclutati in uno sforzo controrivoluzionario di portata mondiale il cui scopo era frenare l’avanzata del comunismo. Di solito la ridistribuzione delle terre – la chiave per la sussistenza nei paesi poveri – è anatema per le economie liberali, e non a caso venne attuata solo come extrema ratio durante la Guerra Fredda. Ed è un dato diagnostico che, una volta caduto il Muro di Berlino e crollato il blocco sovietico, la riforma agraria scomparve del tutto dalle agende di USAID e della Banca Mondiale. Avendo nutrito fin dall’inizio scarse illusioni sugli scopi e i limiti dell’economia dello sviluppo, non posso dire di essere rimasto deluso.
Che cosa vogliono i contadini?
Essendomi gettato nello studio delle guerre contadine di liberazione nazionale, mi trovai sempre più a leggere di vita contadina, organizzazione dei villaggi, credenze popolari, feudalesimo, pratiche agricole dei piccoli proprietari, strutture familiari, mezzadria e bracciantato, religioni agrarie. In un certo senso, fu allora che trassi la logica conclusione indicata dalla mia traiettoria intellettuale. Posta la mia scarsa fede nelle capacità dello Stato rivoluzionario o dell’establishment dello sviluppo di servire gli interessi e le aspirazioni dei contadini, decisi di dedicarmi a uno studio approfondito dei ceti agrari nel Sudest asiatico e altrove.
L’obiettivo sembrava meritevole: una carriera accademica incentrata sulla comprensione di contadini e agricoltori. Non soltanto rappresentavano, allora, la maggioranza dell’umanità, ma sono a tutt’oggi la classe più numerosa in pressoché tutti i paesi poveri: a dispetto di tassi senza precedenti di urbanizzazione, esistono più contadini oggi che mezzo secolo fa. Si riteneva inoltre che la classe contadina – anche quando indicata dai rivoluzionari come «massa» contadina, quasi che contasse solo il suo peso numerico – rappresentasse l’anima di una nazione, ne incarnasse la cultura, lo spirito e il futuro. Retorica a parte, se le rivoluzioni non erano in grado di soddisfarne le aspirazioni e le esigenze, allora non c’era altro da dire. Il benessere e la dignità della classe contadina – era questo il mio ragionamento – dovevano essere il basilare metro di giudizio per la valutazione di qualsiasi ordine economico e politico. Partendo da questa premessa, mi impegnai a indagare rivolte e rivoluzioni attenendomi il più strettamente possibile alla prospettiva dei contadini. Per mia fortuna potevo contare sull’aiuto di molti grandi studiosi di vita agraria e movimenti contadini ai cui piedi continuo a sedere. Tra questi, Marc Bloch, Aleksandr V. Cajanov, Barrington Moore Jr., E.P. Thompson, Eric Wolf, Fei Hsiao-tung, Eric Hobsbawm, Clifford Geertz, Carl Landé, R.H. Tawney e Charles Tilly. Il mio lavoro dipende in larga parte dalle loro intuizioni e dalle domande che posero.
È impossibile immergersi in questa letteratura senza concluderne che esiste un enorme divario tra le politiche delle élite urbane da una parte e i coltivatori rurali dall’altra. Anche quando condividono una lingua e una cultura in senso lato, è come se parlassero dialetti reciprocamente inintelligibili. Persino quando in teoria partecipano allo stesso movimento nazionalista, alla stessa fede religiosa, allo stesso partito politico o alla stessa rivoluzione, è probabile che le rispettive poste in gioco, i rispettivi interessi e intenti, divergano in misura significativa. Gli storici e i giornalisti scrivono la storia perlopiù dai grandi centri urbani e dalla prospettiva delle élite alfabetizzate. In genere la popolazione rurale viene vista come il destinatario più o meno passivo di progetti concepiti e implementati dall’alto. Se vengono alla ribalta, è solo quando sfondano la patina sottile di presunta placidità con rivolte, movimenti millenaristi, occupazioni di terre, incendi, e così via. Negli ultimi vent’anni circa, la massiccia migrazione della forza lavoro nazionale e internazionale ha determinato un notevole restringimento del «gap cosmopolita» urbano/rurale. Quando questo nuovo cosmopolitismo rurale viene apertamente mobilitato come forza politica, per esempio nella vittoria dell’opposizione a base rurale del luglio 2011 in Thailandia, il risultato non fa che mettere in luce le tensioni tra le classi popolari rurali e urbane da un lato e le élite della capitale dall’altro.
La seconda traiettoria delle mie ricerche era di provare a evidenziare con precisione le effettive differenze di stile, pratiche, valori e interessi tra la sfera delle politiche di villaggio e quella delle élite urbane. Proprio come nessuna cultura equivale a un’altra, così non esistono due luoghi tra loro identici; perciò tracciare i contorni esatti delle politiche rurali, viste nel loro insieme, richiede un’attenta etnografia. Esistono, tuttavia, alcune differenze generali tra le comunità agrarie e di villaggio e gli agglomerati urbani. Precisare alcune di queste differenze di massima ci permette di coglierne la grana, e di capire il motivo per cui molti degli strumenti concettuali dell’analisi sociale che risultano adeguati alle società industrializzate rischiano di portarci fuori strada se applicati ai villaggi rurali.
I villaggi sono comunità del faccia-a-faccia e, in quanto tali, respingono le astrazioni. I rapporti di classe, la cui concretezza è così dolorosamente tangibile in quasi tutti i contesti rurali, sono percepiti non tanto come categorie – per esempio, proprietari terrieri e contadini – quanto come persone concrete, con storie, famiglie, valori, idiosincrasie e caratteristiche individuali. I contadini sanno bene che esistono proprietari terrieri con interessi di classe in comune, ma questo specifico proprietario è unico, e il suo rapporto con fittavoli e braccianti sarà altrettanto particolare. Conoscono la sua famiglia, genitori e nonni compresi, che con ogni probabilità avrà una reputazione condivisa nel villaggio; sono al corrente dei suoi fatti e misfatti passati; sanno come lui li considera. Quel proprietario è più una personalità specifica (apprezzata o detestata) che un rappresentante della sua classe. È a lui che affibbieranno un nomignolo ed è di lui che rideranno alle spalle. E naturalmente anche il proprietario terriero conosce i suoi locatari «a tutto tondo» e non come astrazioni. L’uno e gli altri hanno una conoscenza reciproca ben più dettagliata di quella che intercorre tra il padrone e gli operai di una fabbrica. Come gli abitanti del villaggio francese protagonisti del romanzo La Terra di Zola, è probabile che siano al corrente degli averi di ciascuno fino all’ultimo articolo di biancheria da letto. Non si può parlare di rapporti e conflitti di classe in questo tipo di comunità senza tener conto del loro profondo radicamento nelle storie personali che li hanno plasmati.
In buona parte del Sud globale, gli agricoltori vivono in modo precario, al limite della sussistenza. Hanno poco o nulla in termini di riserve o risparmi che possano servire da garanzia in un periodo nero. La morte di un animale da tiro, una malattia invalidante durante la stagione di lavoro nei campi, la perdita di un raccolto o un crollo nei prezzi di ciò che coltivano, può spingerli oltre quel limite. Nella peggiore delle ipotesi, questo significava tradizionalmente denutrizione o addirittura morte per fame; nella migliore, la perdita delle terre e la susseguente dipendenza a vita da un parente, un proprietario terriero o un patrono per la sussistenza e la protezione. Un rovescio, allora come oggi, poteva anche determinare la frammentazione, temporanea o permanente, della famiglia. Oggi significa spesso la migrazione in un altro continente.
Gli esiti potenzialmente catastrofici di una cattiva annata fanno sì che la situazione di gran parte della popolazione rurale sia, nella frase memorabile di Tawney, quella «di un uomo che sta sempre con l’acqua alla gola, così che basta la minima increspatura sulla superficie ad annegarlo»1. Questo significa, in breve, che i contadini in una tale situazione sono caratterizzati da una netta avversione al rischio: si impegnano a minimizzare le probabilità di un qualunque fallimento economico, potenzialmente letale. Le conseguenze sul loro comportamento sociale ed economico sono pervasive. È probabile che seminino colture diverse in campi distinti, affinché la perdita di un raccolto sia meno devastante; sceglieranno colture con una resa costante, anche se modesta, invece che colture le cui rese sono in media più alte ma che hanno una tenuta più fragile; tipicamente punteranno su prodotti commestibili oltre che commerciabili. Preferiscono essere proprietari di un piccolo appezzamento piuttosto che fittavoli e, in modo analogo, fittavoli piuttosto che braccianti, poiché ogni gradino in discesa su quella scala rappresenta una perdita di sicurezza nella sussistenza, anche se, nelle annate buone, potrebbe fruttare di più. In ambito sociale, questa etica di sussistenza significa cercare di tenersi buoni parenti, vicini, proprietari terrieri e amici che, in caso di necessità, possono accorrere in tuo aiuto. Specularmente, significa anche estendere la medesima assistenza agli altri, quando possibile, nella consapevolezza che la prossima volta potresti esserci tu nei loro panni.
Quando si tratta di capire le politiche di una popolazione rurale che vive costantemente in bilico, sul filo del rasoio, va sempre tenuto presente che questa etica della sussistenza porta a giudicare gli accomodamenti sociali ed economici più per la loro capacità di proteggere da esiti catastrofici che per le loro caratteristiche di sfruttamento quantitativo (per esempio quanta parte del raccolto esige il proprietario terriero). Di conseguenza, un sistema di regime fondiario magari più oneroso che però, in un anno sfavorevole, riduce gli affitti ed estende il credito sarà più stabile di un sistema meno oneroso negli anni favorevoli ma implacabile in caso di perdita del raccolto. Similmente, un sistema fiscale che calibri i tributi in base alle fluttuazioni nella resa dei raccolti, e dunque nel reddito della popolazione, sarà meno detestato di un sistema, come l’imposta capitaria a somma fissa, che non tiene conto delle cattive annate. A parità di altre condizioni, ogni forma di riscossione che violi l’etica di sussistenza sarà politicamente più esplosiva delle forme di estrazione che, per quanto esose, moderano le proprie pretese nelle stagioni negative e dunque evitano le conseguenze sociali più disastrose. Uno dei motivi per cui gli Stati coloniali si trovarono spesso alle prese con rivolte contadine era proprio il fatto che promuovevano rapporti capitalistici di produzione e politiche di prelievo fiscale fisso sul reddito, soppiantando un sistema di estrazione certamente predatoria, ma necessariamente più flessibile (data la debolezza degli Stati precoloniali), con un altro che non lasciava margine alle esigenze di sussistenza.
L’importanza dell’etica di sussistenza nei contesti agrari poveri è un tema che ho sviluppato in modo piuttosto dettagliato nel mio The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in South East Asia. Ma sarebbe fuorviante lasciare il lettore con l’impressione che si possano capire le implicazioni politiche della miseria semplicemente in termini di calorie, contanti o calcolo del rischio. Non credo sia possibile comprendere davvero le politiche delle classi subalterne di questo tipo se non le consideriamo anche come istanze locali di dignità e rispetto2.
Così come non si dà un’esperienza puramente astratta in una piccola comunità del faccia-a-faccia, parimenti non c’è esperienza di povertà che non sia socialmente e culturalmente incarnata. Ogni comunità presenta rituali che contrassegnano la posizione dell’individuo e della sua famiglia. Ci sono infatti standard minimi di condotta culturalmente accettabile per le feste di nozze, i funerali, i riti di passaggio e le celebrazioni religiose annuali. Non essere all’altezza di quei minimi equivale non soltanto a rivelare la propria indigenza, ma a scendere culturalmente sotto la soglia minima della cittadinanza e della posizione sociale. A suo modo, significa perdere la faccia e la piena appartenenza alla comunità. Nella comunità malese di coltivatori di riso in cui ho vissuto, la festività collettiva più importante era la fine del mese di digiuno islamico, celebrata dalle famiglie agiate con grandi banchetti cui venivano invitati tutti i parenti e i vicini. L’umiliazione più cocente per gli abitanti poveri del villaggio era la mancanza di mezzi per poter offrire quel genere di banchetti, ovvero il fatto di essere sempre gli ospiti, mai gli anfitrioni, di non poter contraccambiare. Molti di loro preferivano restare a casa piuttosto che subire la mortificazione di accettare cibo a quelle condizioni. Le nozze e soprattutto i funerali, data la loro imprevedibilità, potevano essere occasioni per accrescere il proprio status o per abbatterlo. Esisteva un livello minimo, condiviso da tutti, perché un matrimonio o un funerale, una bara o un banchetto, potessero essere considerati decorosi. Non disporre di quel minimo significava esporsi all’onta pubblica o al dileggio privato – oppure soccombere alla necessità di chiedere un prestito rovinoso o di vendere la terra per dimostrarsi all’altezza delle aspettative. Si capisce così anche come mai, nei contesti cristiani in cui i regali di Natale sono un simbolo di status sociale, le famiglie povere si indebitino fino al collo per procurare ai figli doni che attestino la propria posizione socioculturale nonostante siano economicamente disastrosi. In senso più lato, il possesso della terra, l’indipendenza economica o l’offerta di banchetti culturalmente accettabili non sono soltanto un indice del proprio reddito ma anche della propria reputazione sociale, del proprio status non servile. L’obiettivo dell’agire economico per gran parte dei poveri è il raggiungimento di una quota minima di agio e, soprattutto, di dignità culturale e rispetto di sé, non la massimizzazione della resa di ogni transazione.
Lo scopo del capitolo successivo è di esaminare le peculiarità legate alla classe, alla cultura e all’economia nei contesti agrari poveri. E come cercherò di dimostrare, comprendere le differenze essenziali tra le politiche rurali dei subalterni e le politiche urbane delle élite ci aiuterà anche a comprendere ciò che accade quando élite e classi contadine entrano in contatto, come alleate o avversarie, nei movimenti politici.
James C. Scott (Mount Holly 1936 – Durham 2024) è stato docente di Scienze politiche e di Antropologia nell’Università di Yale, ha fatto ricerca sul campo soprattutto nel Sud-est asiatico (non a caso parla anche birmano e indo-malese). Tra i principali esponenti della perestroika accademica, che nelle Scienze politiche ha portato a un riequilibrio tra gli studi di tipo quantitativo, preponderanti, e quelli di tipo qualitativo, ha pubblicato numerosi libri tradotti in tutto il mondo. In italiano sono usciti Le origini della civiltà. Una controstoria (2018) e L’arte di non essere governati. Storia anarchica degli altopiani del Sudest asiatico (2020) per Einaudi e Il dominio e l’arte della resistenza (2021 n.e.), Lo sguardo dello Stato (2019), Elogio dell’anarchismo (2022 n.e.) e L’infrapolitica dei senza potere (2024) per elèuthera. Nel 2005 la rivista «American Anthropologist» gli ha dedicato un numero speciale intitolato Moral Economies, State Spaces, and Categorical Violence e nel 2020 ha ricevuto l’Albert O. Hirschman Prize per il suo importante contributo interdisciplinare in antropologia, economia e storia. Tra una lezione e l’altra allevava pecore nella sua casa in Connecticut.
-
R.H. Tawney, Land and Labour in China, Beacon Press, Boston 1966, p. 77. ↩
-
I due capitoli che seguono uscirono in forma di saggio due anni dopo la pubblicazione di The Moral Economy of the Peasant e in particolare dopo la pubblicazione di The Rational Peasant, volume in cui Samuel Popkin contestava quel mio primo saggio. Credo che, allo scopo di creare un uomo di paglia, Popkin avesse intenzionalmente frainteso la mia argomentazione, dando a intendere che io vedessi i contadini come degli ingenui altruisti. Niente potrebbe essere più lontano dal vero. In quel saggio descrivevo i comportamenti razionali che un contadino, all’incombere di una possibile crisi di sussistenza, potrebbe adottare per minimizzare le perdite. Di fatto, il tipo di condotta descritto era perfettamente coerente con quello che un fautore della scelta razionale avrebbe potuto ipotizzare nella situazione esistenziale propria di un contadino. Anzi, tempo dopo, alcuni commentatori descrissero la mia argomentazione come una tesi di scelta razionale avant la lettre. In ogni caso i due libri venivano spesso accoppiati nei corsi universitari dedicati alla questione, perché sembravano partire dagli stessi dati, ma li interpretavano attraverso lenti analitiche diverse. La tesi che sostenevo in quei saggi era che gli accorgimenti sociali pensati per prevenire gli esiti peggiori acquisiscono, con l’andare del tempo, un valore normativo tale da essere assunti come diritti morali. Credo che le prove documentarie di questa dinamica siano schiaccianti. A dispetto della tentazione di rispondere al libro di Popkin con una puntuale critica della teoria della scelta razionale – un compito poi svolto da innumerevoli altri – decisi piuttosto di concentrarmi su un aspetto del mio The Moral Economy che a posteriori reputai carente, o quantomeno incompleto: l’aver trascurato gli aspetti religiosi e ideativi dei movimenti contadini. In altre parole, quel saggio presentava il ceto contadino come troppo freddo e lucido, e soprattutto avulso da quei valori religiosi che sono invece ben radicati nella cultura popolare. Dopotutto è stato solo dopo la Rivoluzione francese che in Occidente l’idea di rivoluzione ha cominciato a distaccarsi, e anche allora solo in modo tenue, dal pensiero religioso. Viceversa, per una gran parte del Sud globale mi sembrava che rivolta e religione popolare fossero inseparabili. Perciò, invece di rispondere alla critica di Popkin, decisi di occuparmi di quelle che io stesso ritenevo essere le lacune del mio scritto. Insomma, i due capitoli successivi sono stati la mia piccola forma di penitenza intellettuale per rispondere alle critiche che ritenevo il mio libro dovesse ricevere e che invece non aveva ricevuto! ↩
