di Giovanni Iozzoli
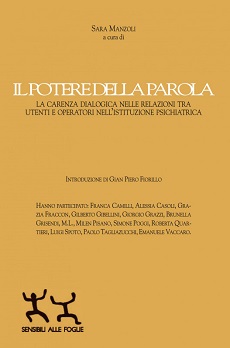 Sara Manzoli (a cura di), Il potere della parola, Sensibili alle foglie, 2021, 95 pp., € 13.00
Sara Manzoli (a cura di), Il potere della parola, Sensibili alle foglie, 2021, 95 pp., € 13.00
Dopo l’importante ricerca sulle badanti [su Carmilla], Sara Manzoli, sempre sotto l’egida di Sensibili alle Foglie, continua la sua opera di indagine e scavo negli “inferni di prossimità” – quei micro mondi a noi vicini, consueti, ma dei quali ignoriamo testardamente la dimensione di sofferenza e i meccanismi di sottomissione che ordinariamente riproducono. Sotto le lenti della “socioanalisi narrativa”, finisce il mondo del disagio psichiatrico, soprattutto nei suoi aspetti più destabilizzanti. Una domanda, non retorica, assai concreta, attraversa tutto il viaggio dell’autrice: chi detiene il potere della parola, nel mondo della malattia e della terapia psichiatrica? La parola apre e chiude mondi, universi di senso, biografie, strategie sanitarie: chi ha diritto di parola, nella relazione terapeutica paziente/istituzione? Chi ha il diritto di reclamare tale potere: “i pazienti che danno una descrizione soggettiva e quindi particolare di vissuti, emozioni, pensieri, oppure il sistema curante che incasella queste parole in coordinate nosografiche, costruendo una rappresentazione della realtà più rarefatta, rispondente a codici internazionali e presentata come risultante di complesse procedure scientifiche”? Quindi, in concreto: chi può prendere parola e che processo di trasformazione subisce quella parola, dentro il tritacarne dell’istituzione psichiatrica?
Sara Manzoli, operatrice militante della salute mentale, racconta la complessa cartografia del circuito psichiatrico istituzionale: un viaggio che mette il lettore a contatto con gli “appartamenti protetti”, i “centri diurni”, le residenze , i Servizi Psichiatrici di diagnosi e Cura, l’esperienza tremenda dei TSO, il ruolo degli ESP. Una rete complessa di strutture e strategie, il cui ordito è rappresentato da alcuni elementi costanti, quali la non emancipazione del paziente dalla terapia e la centralità onnipervadente della farmacologia. Sara costruisce indagine sociale, usando l’approccio del “cantiere socionarrativo”: far parlare le persone della loro “malattia” , del contesto sociale in cui nasce, del contesto terapeutico entro cui il disturbo, e in ultima analisi l’individuo nella sua integrità, vengono presi in gestione dall’istituzione. Una riappropriazione “dal basso”, orizzontale, del diritto rivoluzionario di autonarrazione della propria storia: che è la conquista di un punto di vista singolare, unico – irriducibile alla “terapia”e al rapporto paziente/medico – foriero anche di liberazione e guarigione.
La parola, quindi – o meglio la sua assenza, il suo addomesticamento o la sua potenzialità trasformatrice – è il filo conduttore di questo “viaggio al termine della malattia mentale”:
I partecipanti al Cantiere lamentano lunghi e ripetuti ricoveri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura dove è evidente la contenzione fisica spesso subita per lunghi periodi, a volte solo per maggior comodità personale. Sono lampanti le umiliazioni corporee subite; a una prima lettura di queste storie, pare che gli operatori riescano a rivolgersi a queste persone solo attraverso il loro corpo, evitando completamente il dialogo e l’uso della parola. Se una persona in evidente stato confusionale non mantiene la condotta richiesta, scattano immediatamente punizioni di tipo corporale. Non ci sono scambi dialogici, se non all’interno dei gruppi istituiti dal personale. In una testimonianza viene messa in evidenza un aspetto importante e cioè che in questi contesti totalitari e violenti è insensato poi organizzare dei gruppi terapeutici, ai quali, giustamente, i partecipanti al cantiere si rifiutano di presenziare, in quanto queste persone vorrebbero essere ascoltate sempre, non solo quando lo consentono gli operatori. Lo scambio non avviene neanche quando i ricoverati chiedono informazioni pratiche, le risposte sono tutte scritte nei cartelli e queste persone se le devono andare a cercare da sole, spaesate e appena entrate in questo insolito luogo di non vita, dove c’è una regola per tutto (pag. 25)
Il viaggio di Sara Manzoli si snoda per tutti i gironi della sofferenza psichiatrica, come se il vecchio manicomio, autoliquidando le sue forme più barbare, si fosse semplicemente ricostituito in una dimensione post-moderna, tecnologica, più adatta a intercettare e contenere ogni genere di “anomalia comportamentale” usando gli strumenti più adatti – dalle pillole alla contenzione meccanica. Un manicomio “light” che si dissolve ma penetra e informa di sé la cura psichiatrica, in un labirinto di istituzioni e prassi in cui i pazienti vengono indirizzati verso l’obiettivo della normalizzazione sociale – non disturbare troppo la vita dei “normali” e non rendersi pericolosi per sè e per gli altri – attraverso la perdita dell’anima, la demolizione dell’Io sofferente, destrutturato e ricomposto in una forma accettata e compatibilizzata dalle procedure psichiatriche. Centrale in questa fase è l’idea onnipervadente del controllo – del denaro, degli affetti, dell’igiene, dei tempi di vita – e, ovviamente, della parola. In una infantilizzazione del paziente/utente che rinuncia alla sua autonomia di cittadino e di adulto, e si consegna mani e piedi all’istituzione e ai suoi custodi.
Un capitolo straziante è dedicato all’“inesorabile avanzata degli psicofarmaci: “io assumo Risperdal, Paroxetina, Lamotrogina e altre due medicine per gli effetti collaterali dei farmaci, il Questran e l’Ossibutinina, e anche l’En! Con le medicine mi trovo bene, a parte gli effetti collaterali; ho il fegato spappolato e anche il pavimento pelvico che non tiene, gli psicofarmaci rilassano gli sfinteri. Gli unici che stanno bene grazie agli psicofarmaci sono gli psichiatri!” (pag. 43). Una egemonia ormai totale dell’approccio farmacologico che lascia dire all’autrice, sconsolatamente esperta di questa degradazione continua della pratica medica: “Emerge quindi in maniera emblematica che i farmaci che dovrebbero essere somministrati “per il bene della persona” di fatto servono solo a “far stare bene gli psichiatri”, che liquidano facilmente la presa in carico del loro paziente, e le case farmaceutiche con i profitti che ne traggono, perchè in questo modo si aggirano modalità di cura più impegnative (…) Ma una persona che non ha voce, come fa a parlare? Cos’altro può dire al di fuori di tutto ciò che ha orecchiato? Come fa a parlare se il linguaggio che usa è quello che le rimane del gergo di chi l’ha messa a tacere, di chi le ha tolto il linguaggio lasciandole solo le caricature di parole scientifiche: bordeline, bipolare, schizofrenico ecc, oppure scialorrea, secchezza delle fauci, insomma “effetti collaterali”? Del resto siamo sicuri che si tratti soltanto di “effetti collaterali”? (pag. 47)
Le parole degli “utenti” dei servizi psichiatrici (espressione assai ipocrita che presuppone una soggettività autonoma e consapevole del paziente) sono fendenti e lineari: “Una volta volevano ricoverarmi per la depressione e ho concordato di non farlo; nei ricoveri ti bombardano solo di farmaci; i farmaci e il ricovero non sono la soluzione. La medicina serve solo a rimbambirci, in questo gruppo non noi possiamo aiutarci, se io arrivo qui e sono depresso, ci aiutano e ci parliamo e a me serve. Talofen, ambulanza e TSO non sono la soluzione. Un bravo dottore dovrebbe dirti “ti attivo uno psicologo”, perché i farmaci per un quarto fanno bene ma per tre quarti fanno male. In conclusione voglio dire che quando si sta male serve dialogo, confronto, parole NON terapia al bisogno.” ( pag. 31)
Le intenzioni e le finalità di un “cantiere socionarrativo” sono ben espresse dal bilancio che l’autrice fa della sua esperienza di ascolto e di autoascolto dei soggetti: “La cura della parola e della relazione è lo spostamento di immaginario che gli utenti della psichiatria propongono. Spostarsi dalla centralità del farmaco alla centralità della parola. Il loro scambio dialettico di opinioni non è stato solo un mezzo per evitare la solitudine, ma una precisa e determinata formulazione politica che modifichi radicalmente (forse sarebbe più corretto dire: che sovverta) le istituzioni psichiatriche nel loro complesso” (pag. 81).
E il suggello ad un libro come questo, può essere un frammento dedicato al calvario di un maestro di provincia italiana:
È morto dopo essere rimasto mani e piedi legato ad un letto per più di 80 ore, senza essere né alimentato né idratato. A dieci anni dalla morte di Francco Mastrogiovanni, il maestro elementare di Castelnuovo Cilento (Salerno) sottoposto nel 2009 a trattamento sanitario obbligatorio nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, arriva una lettera di scuse da parte di un infermiere che avrebbe dovuto assisterlo. ‘Abbiamo commesso una barbarie’ ammette Nicola Oricchio. ‘Non abbiamo capito la richiesta di aiuto di Franco strappandolo al vostro affetto’ (…). Franco è morto invano perché ancora oggi, nei reparti di psichiatria degli ospedali, gli utenti ricoverati in trattamento sanitario obbligatorio continuano a morire a causa della contenzione meccanica. (pag. 30)
