di Gioacchino Toni
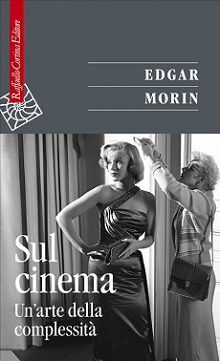 «Come mai a volte la nostra realtà ci appare ovvia e familiare e a volte strana e sconosciuta? Come mai a volte la nostra realtà possiede una sua realtà assoluta e a volte invece ne ha così poca? Malgrado il sentimento indubitabile della nostra realtà, […] abbiamo a volte la sensazione della scarsa realtà della nostra realtà. Al cinema, invece, diamo una forte realtà ai personaggi e alle loro storie, e solo un piccolo barlume di vigilanza nella nostra mente non dimentica, durante la proiezione, che siamo spettatori seduti su una poltrona. Da qui l’idea che la nostra realtà umana sia intessuta di immaginario: sogni a occhi aperti, fantasmi, immaginazioni, fantasie, desideri, romanzi, film, serie televisive e svaghi sono costitutivi della nostra realtà umana. L’immaginario collabora con il reale nelle arti dove si opera la nascita di un universo fantasma dotato di effetto di realtà. La missione del cinema è quella di affrontare questa doppia natura del reale. Obbliga gli spettatori a porsi domande fondamentali sulla loro vita, la loro società, il loro mondo, ossia sull’uomo stesso». (Edgar Morin)
«Come mai a volte la nostra realtà ci appare ovvia e familiare e a volte strana e sconosciuta? Come mai a volte la nostra realtà possiede una sua realtà assoluta e a volte invece ne ha così poca? Malgrado il sentimento indubitabile della nostra realtà, […] abbiamo a volte la sensazione della scarsa realtà della nostra realtà. Al cinema, invece, diamo una forte realtà ai personaggi e alle loro storie, e solo un piccolo barlume di vigilanza nella nostra mente non dimentica, durante la proiezione, che siamo spettatori seduti su una poltrona. Da qui l’idea che la nostra realtà umana sia intessuta di immaginario: sogni a occhi aperti, fantasmi, immaginazioni, fantasie, desideri, romanzi, film, serie televisive e svaghi sono costitutivi della nostra realtà umana. L’immaginario collabora con il reale nelle arti dove si opera la nascita di un universo fantasma dotato di effetto di realtà. La missione del cinema è quella di affrontare questa doppia natura del reale. Obbliga gli spettatori a porsi domande fondamentali sulla loro vita, la loro società, il loro mondo, ossia sull’uomo stesso». (Edgar Morin)
Con queste parole si apre Le Cinéma, un art de la complexité (2018), di cui è appena uscita l’edizione italiana – Edgar Morin, Sul cinema. L’arte della complessità (Raffaello Cortina Editore, 2021) – tradotta da Anna Battaglia. Si tratta di un’ampia raccolta di articoli sul cinema stesi da Morin nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta – in buona parte pubblicati su riviste come la Revue internationale de filmologie e La Nef, oppure ritrovati in forma di bozze, dattiloscritti e manoscritti presso l’archivio del Centre Edgar Morin. Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain – proprio mentre lo studioso lavorava ad opere destinate a lasciare il segno come Le Cinéma ou l’homme imaginaire (1957), Les stars (1957) e L’Esprit du temps. Essai sur la culture de masse (1962).
A far da sfondo agli articoli riportati dal volume sono dunque le coeve riflessioni contenute in questi importanti saggi in cui Morin affronta la complessità dei fenomeni audiovisivi concependo l’immaginario come una parte costitutiva della realtà umana.
Le Cinéma ou l’homme imaginaire viene tradotto in italiano nei primi anni Sessanta faticando però ad incidere sul dibattito cinematografico nazionale, come ricostruisce puntualmente Francesco Casetti nell’introduzione all’edizione proposta da Feltrinelli nel 1982 e riportata in quella realizzata da Raffaello Cortina Editore nel 2016. In questo saggio Morin si concentra sul rapporto del cinema con il reale e l’immaginario evidenziando le relazioni con i processi profondi della psiche e della conoscenza.
L’illusione di realtà prodotta dal cinema, secondo il francese, risulta inseparabile dalla coscienza della sua illusorietà da parte del pubblico. Lo spettatore vive il cinema in uno stato di doppia coscienza: da una parte viene posseduto dalla magia delle immagini e dall’altro è cosciente di assistere ad uno spettacolo immaginario. All’illusione di realtà si sovrappone la coscienza dell’illusione. Il cinema, dunque, secondo Morin, permette allo spettatore di godere della “vertigine del doppio”, della duplicazione del reale, permettendogli di immettersi in questo simulacro sottraendosi dal reale. Lo spettatore, durante la fruizione del film in sala, entra a far parte di un universo nuovo senza sentirsi spaesato: è attraverso una trasfigurazione di ordine estetico che esso scopre il mondo.
 Nella prefazione all’edizione del 1977 de Il cinema o l’uomo immaginario il francese sottolinea come reale ed immaginario si intersechino a partire dall’era cine-fotografica:
Nella prefazione all’edizione del 1977 de Il cinema o l’uomo immaginario il francese sottolinea come reale ed immaginario si intersechino a partire dall’era cine-fotografica:
l’unica realtà di cui siamo sicuri è la rappresentazione, cioè l’immagine, cioè la non-realtà, dato che l’immagine rimanda a una realtà sconosciuta. Certo, queste immagini sono vertebrate, organizzate, non solo in funzione degli stimoli esterni, ma anche della nostra logica, della nostra ideologia, e cioè anche della nostra cultura. Tutto il reale percepito passa quindi per la forma immagine. Poi ricompare sotto forma di ricordo, vale a dire come immagine di immagine. Il cinema, come ogni figurazione (pittura, disegno), è un’immagine di immagine ma, come la fotografia, è un’immagine dell’immagine percettiva e, più della foto, è un’immagine animata, cioè viva. Proprio perché rappresentazione di rappresentazione viva, il cinema ci chiama a riflettere sull’immaginario della realtà e sulla realtà dell’immaginario1.
Ed ancora:
l’immagine non è solo il punto di incontro tra reale e immaginario ma è l’atto costitutivo radicale e simultaneo del reale e dell’immaginario. A questo punto si può concepire il carattere paradossale dell’immagine-riflesso o “doppio”, che da una parte esprime un potenziale di oggettivazione (distinguendo e isolando gli “oggetti”, permettendo il distacco e la presa di distanza) e contemporaneamente, dall’altra, esprime un potenziale di oggettivazione (la virtù trasfigurante del doppio, il “fascino” dell’immagine, la fotogenia…). Bisogna quindi arrivare a concepire non solo la distinzione ma anche la confusione tra reale e immaginario; non solo la loro opposizione e concorrenza, ma anche la loro complessa unità e complementarità2.
Sempre nel corso degli anni Cinquanta lo studioso pubblica Les stars (1957), ove approfondisce i processi psichici e affettivi di proiezione e identificazione e mette in relazione la dimensione economica con l’immaginario collettivo, invitando a leggere il divismo come un prodotto della società capitalistica e al contempo come una risposta a bisogni antropologici profondi riconducibili addirittura al mito ed alla religione.
 Ciò che invece Morin delinea nel successivo L’Esprit du temps. Essai sur la culture de masse (1962), ripubblicato nel 2017 in italiano da Meltemi in un’edizione tradotta da Claudio Vinti, curata da Andrea Rabbito ed impreziosita da un’introduzione di Ruggero Eugeni, si rivela utile ad una comprensione critica del potere delle nuove immagini proposte dalla scena mediatica contemporanea.
Ciò che invece Morin delinea nel successivo L’Esprit du temps. Essai sur la culture de masse (1962), ripubblicato nel 2017 in italiano da Meltemi in un’edizione tradotta da Claudio Vinti, curata da Andrea Rabbito ed impreziosita da un’introduzione di Ruggero Eugeni, si rivela utile ad una comprensione critica del potere delle nuove immagini proposte dalla scena mediatica contemporanea.
È in tale contesto di riflessioni sul cinema e sull’immaginario condotte nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta che Morin scrive gli articoli raccolti nel volume Sul cinema. L’arte della complessità. Questi suoi pezzi partono pertanto dalla convinzione che la realtà umana sia intessuta di immaginario; che si tratti di sogni a occhi aperti, fantasmi, desideri, romanzi o film, l’immaginario collabora con il reale ogni qual volta si dà vita a «un universo fantasma dotato di effetto di realtà»3. Il cinema, nell’affrontare questa doppia natura del reale, obbliga gli spettatori a «una riflessione, una presa di coscienza, un’apertura al pensiero che interroga, al pensiero che cerca»((Ivi., p. X.)), dunque a porsi domande sulla vita, sulla società, sul mondo, in definiva sull’essere umano stesso.
Per farsi un’idea di come Morin traduca le sue riflessioni generali relative al rapporto tra cinema, immaginario e realtà nel “quotidiano” di brevi articoli per qualche rivista riferiti a singoli film o alle poetiche autoriali, si possono prendere in considerazione, tra i tanti contenuti nel volume, gli scritti Elogio del Grido e Ingmar Bergman. L’uomo che pone domande.
Nello pezzo relativo al film del 1957 di Michelangelo Antonioni – pubblicato originariamente in La Nef, gennaio 1959 – Morin sottolinea come la sua bellezza derivi da
una combinazione intima tra il senso profondo di una storia, questa stessa storia e i mezzi formali di una tecnica raffinata. Questa raffinatezza dell’immagine e anche del montaggio sembra a priori mal adattarsi all’esiguità, alla semplicità della vicenda. Eppure è proprio questa dissonanza a emozionarci fino in fondo, a darci quell’emozione che solo una grande opera può procurare: un’emozione che non si riduce all’emozione estetica, ma che non potrebbe sgorgare senza l’emozione estetica4.
 La scelta di ambientare il film tra i paesaggi invernali di un’Italia settentrionale periferica coperta da un cielo uniformemente grigio, secondo lo studioso si rivela in grado di conferire al film la sua vita interiore. «Questo paesaggio sarà l’anima stessa del film, l’anima svuotata del protagonista del film: l’operaio Aldo»5. L’intera vicenda è contenuta tra il momento in cui l’uomo è «colpito a morte» – quando Irma, la donna con cui vive, lo lascia – «e il momento in cui cade» morendo «senza neanche compiere un gesto attivo nel suicidio, lasciandosi cadere dall’alto della torre della raffineria dove lavorava»6, dopo aver rivisto, a distanza di tempo, la donna amata che nel frattempo si è costruita un’altra vita senza di lui. Tra questi due terminali c’è il girovagare di Aldo, che diserta il lavoro e cerca di riempire in qualche modo le sue infinite e vuote giornate.
La scelta di ambientare il film tra i paesaggi invernali di un’Italia settentrionale periferica coperta da un cielo uniformemente grigio, secondo lo studioso si rivela in grado di conferire al film la sua vita interiore. «Questo paesaggio sarà l’anima stessa del film, l’anima svuotata del protagonista del film: l’operaio Aldo»5. L’intera vicenda è contenuta tra il momento in cui l’uomo è «colpito a morte» – quando Irma, la donna con cui vive, lo lascia – «e il momento in cui cade» morendo «senza neanche compiere un gesto attivo nel suicidio, lasciandosi cadere dall’alto della torre della raffineria dove lavorava»6, dopo aver rivisto, a distanza di tempo, la donna amata che nel frattempo si è costruita un’altra vita senza di lui. Tra questi due terminali c’è il girovagare di Aldo, che diserta il lavoro e cerca di riempire in qualche modo le sue infinite e vuote giornate.
È dunque, di fatto, la storia di un’agonia che dura un anno o due, ma un’agonia intima, di cui nulla ci è mostrato esteriormente. È dalla fatica sempre più grande, dall’indebolimento progressivo dei riflessi di Aldo, che noi capiamo che lui si sta svuotando delle ultime riserve biologiche. Una successione di episodi, sulla sua strada, distraggono lo spettatore dalla visione permanente di ciò che di fatto è un pellegrinaggio di morte. Potremmo anche lasciarci prendere da questo rosario di incontri pittoreschi, di piccoli casi fortuiti, di piccoli avvenimenti, se non ci fosse permanentemente il cielo grigio e il fiume snervato, lento, che con la sua presenza sempre uguale ci fa entrare nell’anima di un uomo. Il film è intriso di una vita interiore suggerita dal paesaggio7.
Antonioni, sostiene Morin, mantiene per tutto il film una “distanza clinica” nei confronti della soggettività del protagonista osservandolo con un’apparente non-partecipazione. Il film ci mostra un essere umano
schiacciato da forze che lo sovrastano, e alla fine domato o distrutto. […] Nulla può essere più doloroso dello spettacolo di un uomo ridotto ad automa, quando ogni sua intima risorsa si è spezzata, e quando si è esaurita ogni sua energia vitale. […] Ne Il grido non si tratta di un automa convenzionale: è l’uomo automatizzato che rimane quando ogni autonoma spinta si è spenta in lui e quando l’energia vitale si è prosciugata in lui. Che cosa straordinaria e rara sullo schermo, la sofferenza silenziosa di un uomo! Diciamo anche soltanto la sofferenza d’amore di un uomo. Il fatto è che il cinema attribuisce sempre solo alle donne i temi profondi dell’amore. Si vedono, è vero, uomini che si suicidano per amore, ma per un gesto di nobiltà o per sacrificio, e sono personaggi, del resto, secondari. Non si è mai visto un uomo agonizzare d’amore per tutto un film. Eppure, i fatti di cronaca dimostrano che anche gli uomini sono capaci di disperazione e di follia. E non sono neanche uomini particolarmente deboli o particolarmente provati e neanche frustrati. Sono come Aldo, degli esseri condotti all’estrema debolezza, all’estrema frustrazione, perché hanno perso ciò che era essenziale per la loro vita. Ne Il grido ci troviamo proprio lì, nell’universo dei fatti di cronaca. Nella cronaca gelida e nebbiosa dell’inverno italiano che riesce a darle musicalità, pur mantenendoci nello “spaccato di vita”. È solo alla fine del film, quando Aldo torna a morire sui luoghi della felicità di un tempo, è solo allora che il fatto di cronaca si trasforma in tema da romanzo, persino romantico8.
Le scelte estetiche del regista ferrarese, continua lo studioso, si adattano a questo racconto sin dalla scelta di mettere lo spettatore nell’incapacità di comprendere esattamente ciò che sta accadendo pur sapendo che qualcosa di tragico accadrà. «Nell’attesa abbiamo gli eventi di superficie» che potrebbero far dimenticare il nulla interiore di Aldo.
E invece Il grido è un film riuscito proprio perché sono queste descrizioni periferiche a rivelarci quel nulla. Nella vita di Aldo non c’è più niente che quella cinepresa possa trattenere, come scene di vita lungo una strada che si percorre velocemente. Le impressioni si succedono tanto per noi spettatori, quanto per il protagonista, ormai passivo, spettatore anche lui9.
Dopo il lento trascinarsi dello svuotamento di Aldo, sul finale Antonioni interviene bruscamente ricorrendo agli strumenti del teatro, del romanzo, della sinfonia:
Aldo arriva nella sua borgata. È assediata dai carabinieri. La folla è in agitazione. Questo tumulto teatrale e sinfonico viene spiegato: vogliono espropriare il comune per costruire un aerodromo. Ma, esteticamente, siamo entrati nel turbine della tragedia o dell’opera da cui sgorgherà il grande tema romanzesco e musicale: la fine che si ricongiunge con l’inizio, il grande ritorno al punto di partenza. Lo spettatore si accorge a stento di questa mutazione, perché il grande grido di orrore che irrompe è stato preparato, lungo tutto il film, come dentro una crisalide10.
Morin accosta la pellicola di Antonioni a quelle di altri registi – Sogni di donna (1955) di Bergman, Senso (1954) di Visconti, Una vita (1958) di Astruc (1958), Gli amanti (1958) di Louis Malle – che, per quanto diversissime tra loro, possono essere accomunate, secondo il francese, dalla comune volontà di approfondire il tema dell’amore in maniera più amara, realistica e tragica.
Tutto ciò, del resto, va di pari passo con l’indebolirsi dei temi sociali e politici che, intorno al 1936 in Francia e nell’immediato dopoguerra in Europa occidentale, attiravano i registi non conformisti. In altre parole, all’avanguardia che significava rivoluzione succede un’avanguardia che significa amore. La promozione del tema dell’amore non è affatto da deplorare, come fanno alcuni critici; ciò che bisogna deplorare è la scomparsa della questione sociale11 .
 Nello pezzo relativo a Bergman – pubblicato originariamente in La Nef, n. 27, aprile 1959 – Morin sottolinea come l’originalità del regista svedese risieda sopratutto nella sua capacità di superare, pur mantenendolo,
Nello pezzo relativo a Bergman – pubblicato originariamente in La Nef, n. 27, aprile 1959 – Morin sottolinea come l’originalità del regista svedese risieda sopratutto nella sua capacità di superare, pur mantenendolo,
il piano del racconto, della descrizione, della tesi, per rimanere costantemente al livello dell’interrogazione […] Ciò che mi colpisce in Ingmar Bergman è ch’egli interroga […] tutto. Il reale e il sogno, (il teatro, i guitti), la vita e la morte, il dolore e la felicità, l’uomo e la donna. […] L’interrogazione permanente di Bergman ritorna spesso a posarsi sul volto femminile, come se fosse lì, dietro quel volto, che risiedono i segreti più preziosi che si stanno cercando, come se le verità più profonde si manifestassero attraverso il volto […] La domanda che Bergman pone ai volti di donna non è “Cos’è la donna?”, è “Cos’è l’umanità?”. L’interrogativo di Bergman privilegia la donna, ma la domanda è generale: come vivere? Cosa significa vivere?12.
Interrogando la vita, puntualizza Morin, il regista svedese interroga la morte. Nonostante il cinema sia pieno di morti a mancare in esso è proprio la morte e Bergman per parlarne direttamente
è obbligato a ricorrere al mito supremo della morte, alla Morte-Personaggio, allo Spettro, al Doppio. Cioè a una faccia della morte che sia quella dell’uomo, misteriosa quanto la faccia dell’uomo e per la quale l’uomo non possiede alcuna risposta. Dio è invocato solo come un’impossibile possibilità. È l’interrogazione bergmaniana che ha la prima e l’ultima parola. Il rifiuto della Salvezza non è una sfida. È l’atto stesso del pensiero che interroga. Eppure in questa opera senza Dio e senza Salvezza, senza Provvidenza, senza ricompensa, la disperazione non si chiude in se stessa. Non si chiude proprio per il fatto che quest’opera è innervata dalla permanenza stimolante dell’interrogazione, da quel cortocircuito innescato dalla curiosità appassionata e attenta che nega la disperazione stessa. Non si chiude anche perché è costantemente interrotta da qualcosa di affascinante e stupefacente che è il gioco, anzi il doppio gioco tra il sogno e la realtà, il teatro e la vita. […] Bergman inserisce spesso un teatro nel teatro, ed è in questo doppio della vita, della sua quintessenza, in questa vita recitata e rappresentata, in questa sorta di ebbrezza che, malgrado le infelicità, i dolori e le domande senza risposta, la vita è finalmente accettata e assunta13.
In chiusura Morin invita a riflettere sui motivi per cui, nonostante Bergman goda dell’ammirazione incondizionata della critica, i suoi film non siano riusciti ad entrare nel grande circuito commerciale pur toccando, in molti casi, problemi quotidiani che gli spettatori conoscono in prima persona. Si può incolpare la stoltezza di molti distributori e proprietari di sale ma, conclude amaramente il francese, si può
anche pensare che lo spettatore sia talmente pavlovizzato dal cinema tradizionale da essere incapace, oggi, di aderire a un cinema senza provvidenza, un cinema che interroga, un cinema dove non è il pubblico a proiettare i propri sogni, le proprie sofferenze, la propria sete ardente di felicità e di avventura, ma che proietta, lui, cinema, sul pubblico, la mediocrità e la follia della vita – senza offrirgli la risposta salvifica14.
