di Gioacchino Toni
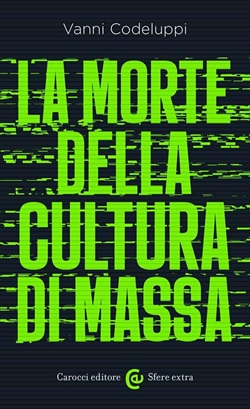 Vanni Codeluppi, La morte della cultura di massa, Carocci, Roma 2024, pp. 116, € 13,00
Vanni Codeluppi, La morte della cultura di massa, Carocci, Roma 2024, pp. 116, € 13,00
Nella prima parte del volume Codeluppi tratteggia come si è guardato alla cultura di massa nella seconda metà del Novecento ricordando come il dibattito che si è sviluppato negli anni Sessanta attorno ad essa risenta in buona parte delle tesi prodotte sin dall’immediato secondo dopoguerra dalla Scuola di Francoforte tendenti a denunciare come il modello economico capitalista soffochi ogni istanza creativa ed espressiva di cambiamento ricorrendo ai media per manipolare le coscienze ed omologare i comportamenti degli individui proponendo spesso nelle sue narrazioni l’happy end come strategia di soddisfazione immediata volta ad allontanare dall’impegno politico orientato alla giustizia sociale.
Per quanto a proposito della cultura di massa anche in Italia, nel corso degli anni Sessanta, si guardi alle teorie francofortesi, è soprattutto Pier Paolo Pasolini a sviluppare nei suoi confronti una critica radicale accusandola di operare, insieme all’industrializzazione ed al nascente consumismo, un’omologazione distruttrice dell’universo arcaico contadino cancellandone gli stili di vita e la cultura popolare tradizionale.
Mentre il francese Edgar Morin, sin dai primi anni Sessanta, guarda in maniera dialettica alla cultura di massa nella sua complessità, mettendo in relazione il sistema di produzione culturale con i bisogni espressi dagli individui, lo statunitense Dwight Macdonald denuncia il farsi strada di una cultura di livello medio che, pur differenziandosi da quella di basso livello, dietro a forme derivate dalla “cultura alta” diffonde contenuti di scarsa qualità.
A guardare invece alla cultura di massa con inedito interesse sono studiosi come Marshall McLuhan, Roland Barthes ed Umberto Eco. In particole, quest’ultimo osserva come nella cultura di massa il fruitore tenda a ricavare godimento dalle variazioni di una struttura sostanzialmente conservativa e, soprattutto, nel confrontarsi con i tre livelli culturali (alto, medio e basso) proposti da Macdonald, Eco sottolinea come in realtà questi non corrispondano automaticamente a tre differenti livelli qualitativi e nemmeno ad altrettante classi sociali nettamente distinte: ad essere differenti sono piuttosto le modalità di fruizione degli individui, lo sguardo con cui si guarda ai prodotti culturali al di là del loro livello qualitativo e contenutistico.
Codeluppi ricorda dunque come sia in particolare il sociologo tedesco Niklas Luhmann a cogliere, nel corso degli anni Settanta, la progressiva frammentazione della società occidentale, avviata verso una stratificazione fondata su numerose subculture, anche a causa della radio e della televisione e di un generale superamento del modello fordista in direzione di una struttura produttiva reticolare sparsa sul territorio: qua si pongono le basi per quello che sarebbe poi stato chiamato “capitalismo digitale”. In Italia è Alberto Abruzzese a riprendere la Scuola di Birmingham ed i cutural studies che hanno colto come il futuro capitalismo digitale si sarebbe fondato sul nuovo ruolo assegnato ai consumatori, orientati a divenire “prosumer”, cioè sia producer che consumer.
Altro momento chiave su cui si sofferma Codeluppi è la comparsa del concetto di posmoderno introdotto da Jean-François Lyotard sul finire degli anni Settanta, a cui si farà ampio ricorso nel decennio successivo per designare, tra le altre cose, il processo di frammentazione culturale e di disgregazione dei confini tra cultura alta e bassa, che, secondo Fredric Jameson, ha comportato nelle società capitalistiche occidentali un vero e proprio appiattimento da cui è derivata una “estetica della superficie”, prontamente fatta propria dal neoliberismo, fondata più sulla “sensazione” che non sul significato e sull’interpretazione.
Come ha avuto modo di argomentare in Ipermondo (2012), piuttosto che di postmodernità, Codeluppi preferisce parlare di ipermodernità, in quanto individua in quest’ultima un’esasperazione della modernità piuttosto che un suo superamento. L’autore spiega poi come la tendenza messa in luce da Walter Benjamin dei media ottocenteschi, come il telefono, di suscitare nell’essere umano un atteggiamento di soggezione, sia del tutto applicabile anche al grande schermo cinematografico che troneggia su una sala in cui il pubblico è mantenuto al buio ed al televisore che, come evidenziato da Jean Baudrillard, tende ad essere posto su un piedistallo. Come ha notato Byung-Chul Han, le cose sembrano cambiare con gli strumenti digitali e mediatici, visto che questi non creano forme di soggezione in quanto sono stati “naturalizzati”, si potrebbe dire con McLuhan incorporati come protesi, sancendo così l’avvenuta ibridazione dell’essere umano con i dispositivi tecnologici.
I media contemporanei si caratterizzano, oltre che per una inedita accelerazione dei tempi di fruizione, per il ricorso a modalità di “comunicazione di flusso” che non mancano di “fluidificare” gli stessi spettatori: se i media ottocenteschi e della prima parte del Novecento ambivano a “catturare l’attenzione” di una massa, gli strumenti digitali tendono invece a cerare “sciami digitali”, come li definisce Byung-Chul Han, cioè aggregati di individui che condividono una condizione comune sebbene d’isolamento. Al posto di ambire ad identificarsi in un gruppo di grandi dimensioni, gli individui contemporanei ricercano modalità con cui sentirsi differenti dagli altri.
Codeluppi segnala come l’universo televisivo da qualche tempo sembri essersi avviato verso una polarizzazione che vede da un lato i canali generalisti seguiti soprattutto da un pubblico di età avanzata e di basso livello di scolarizzazione e dall’altro le grandi piattaforme a pagamento che vantano un pubblico più giovane e maggiormente scolarizzato. Se tali piattaforme, interne ai processi di digitalizzazione e globalizzazione, da un lato tendono ad omogeneizzare la somministrazione di prodotti audiovisivi agli spettatori delle diverse aree del Pianeta e dei più diversi orientamenti culturali, dall’altro, ricorda lo studioso, non mancano di produrre opere imperniate attorno a specificità locali e culturali rendendole disponibili ovunque e a tutti.
A risultare sempre più evidente nella società contemporanea è soprattutto il ridimensionamento del ruolo svolto dalla middle class che in passato rappresentava il principale target di mercato per i prodotti culturali di livello medio. Soprattutto negli Stati Uniti è evidente come ad essersi indebolito sia quello che a lungo è stato il punto di forza del sistema cinematografico: la capacità di realizzare opere popolari di successo commerciale ed al tempo stesso di discreto livello qualitativo. Per indicare tale processo, Codeluppi parla di “marvelizzazione” della cultura, intendendo evidenziare come a tutto ciò abbia contribuito la Marvel con il suo cinema di supereroi.
Nati negli anni Trenta del Novecento, i supereroi hanno visto scemare il ruolo di grande rilievo che avevano assunto nell’immaginario collettivo alla fine della seconda guerra mondiale venendo per certi versi sostituiti dalla fantascienza, probabilmente più adatta a rapportarsi con le inquietudini del momento. Negli anni Sessanta la Marvel ha drasticamente modificato i suoi supereroi facendoli per certi versi “scendere dall’Olimpo”, umanizzandoli, un po’ come era avvenuto per le divinità della statuaria greca tardo classica, in un memento di crisi delle poleis. Pian piano è stato creato un unico grande contesto – Marvel Cinematic Universe – in cui i diversi personaggi della scuderia possono incontrarsi ampliando a dismisura gli intrecci narrativi e dando al tempo stesso unitarietà all’universo Marvel. Riprendendo la tendenza seriale televisiva, inoltre, i film dei supereroi tendono ad adottare finali aperti che preannunciano futuri sviluppi in nuovi “episodi”.
Il successo del sistema Marvel, sostiene Codeluppi, «ha contribuito in maniera significativa a fare andare profondamente in crisi ambiti in precedenza importanti all’interno del mercato cinematografico, come le commedie sentimentali, i film drammatici e i film indipendenti»; insomma, «il dominio dei film Marvel probabilmente ha accelerato la quasi totale scomparsa dal mercato di quelli che erano in passato i film di fascia media» (p. 69) e che ora non sarebbero sufficientemente redditizi, soprattutto se paragonati agli incassi delle opere con i supereroi, che, tra l’altro, si dilatano facilmente in redditizi franchise e merchandising.
Codeluppi si sofferma brevemente anche sull’universo musicale notando come, a partire dagli anni Ottanta, quando hanno preso piede i videoclip musicali, si è assistito ad un progressiva importanza assegnata all’immagine dei/delle cantanti, vero e proprio prodotto commerciale principale, rispetto alla creatività e alle sperimentazioni musicali e testuali delle canzoni. Si tenga inoltre presente, sottolinea lo studioso, che le stesse modalità di consumo dei prodotti digitali tendono ad abbassare la qualità estetica: i prodotti musicali ed audiovisivi vengono spesso fruiti in condizioni ambientali “disturbate”, esterne, di movimento, di scarsa concentrazione, superficiali, dunque come mero intrattenimento di fondo senza prestarvi particolare attenzione.
Si può pertanto parlare di una vera e propria crisi che riguarda le modalità espressive impiegate per comunicare. Se ciò avviene, è probabilmente perché si pensa che un’attenzione per la qualità estetica possa determinare un rallentamento dell’attività svolta dai flussi in azione nel sistema mediatico. Dunque si ritiene che sia necessario concedere spazio soprattutto a forme elementari e poco distintive, che possono circolare facilmente e senza ostacolare il movimento dei flussi, ma che, proprio per questo, determinano in impoverimento dell’offerta culturale (p. 78).
In un’epoca in cui il modello comunicativo è imperniato principalmente sull’efficacia di funzionamento, e sulla redditività, con conseguente abbassamento della cura formale dei messaggi, a proliferare, afferma Codeluppi, è il “culto del banale”. Basti pensare al successo dei reality show che, in alcuni casi, riescono a far coincidere il flusso della vita quotidiana del pubblico con quello televisivo. Il processo di “vertinizzazione” di cui lo studioso si è a lungo occupato (La vetrinizzazione sociale, 2007; Tutti divi, 2009; Mi metto in vetrina, 2015; Vetrinizzazione, 2021), particolarmente evidente nei social e in piattaforme come OnlyFans, assume le forme del “bordello senza muri”, di cui parlava McLuhan, privo di cura estetica dei contenuti.
Lo schermo non mostra eventi rilevanti, ma le persone rimangono ugualmente davanti a esso. Evidentemente, non siamo più di fronte a un processo di trasmissione di messaggi dotati di un contenuto, ma a una pura forma di circolazione, a una connessione costante basata su un flusso ininterrotto di contenuti poco rilevanti e finalizzati soltanto a ottenere di essere visti. Forse, è possibile anche sostenere che non siamo più di fronte a un vero processo di comunicazione, ma soltanto a semplici pratiche di condivisione di forme espressive (p. 84).
La stessa tendenza alla gamificazione, al ricorso delle logiche ludiche a scopi motivazionali-prestazionali-profiettevoli, enormemente aumentata con la digitalizzazione, può essere vista come evoluzione di quella proposta televisiva indirizzata, come argomentava a metà degli anni Ottanta Neil Postman, a promuovere contenuti visuali leggeri, trasmessi in rapida e frammentata successione, mercificati, progettati esclusivamente per attrarre e intrattenere il pubblico divertendolo ben oltre i generi storicamente votati a tale compito.
Rispetto ai simulacri (copie di copie che si rinviano senza fine senza che esista più un originale) a cui faceva riferimento Jean Baudrillard, nelle attuali società fortemente mediatizzate, secondo Codeluppi, si è di fronte a “simulacri integrali”, che si costruiscono autonomamente un loro originale, dunque non si avrebbe più a che fare «con un rapporto tra la realtà e un suo modello di rappresentazione, ma con un rapporto diretto tra modello e modello». Si giungerebbe così al tramonto della realtà; non perché questa cessi davvero di esserci, ma perché tende ad essere «sostituita da un altra specie di realtà: quella mediale e digitale. Perché i media tendono a costruire un mondo privo di problemi e decisamente più piacevole rispetto a quello fisico» (p. 96)
Gli strumenti digitali amplificano a dismisura quanto già introdotto dalla televisione: la richiesta ai fruitori di lasciarsi andare ad una comunicazione di flusso tendente ad annullare ogni contenuto profondo. «Il modello che s’impone è quello di un social media come TikTok: video brevi o anche brevissimi e assenza di qualsiasi forma di approfondimento» (p. 99). Altro che società dell’informazione, l’attuale era digitale si sta rivelando in realtà dispensatrice di disinformazione, disorientamento ed ignoranza. È in un tale contesto che, da qualche tempo, ha fatto irruzione l’intelligenza artificiale generativa prospettando per i cantori del mondo sin qua descritto magnifiche sorti e progressive e, per chi guarda a tutto ciò con occhio critico, un panorama decisamente inquietante, ma che può e deve essere cambiato.
