
I dipendenti FCA nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, foto di repertorio. Il 10 marzo 2020 sono scesi in sciopero spontaneo per strappare tutele contro il coronavirus.
di Wu Ming
Negli ultimi due mesi, la working class sembra avere riconquistato una visibilità sui media e una centralità nei discorsi che non aveva da molti anni. L’emergenza coronavirus ha riportato in auge questioni come le condizioni di lavoro, le nocività in fabbrica, il rapporto tra lavoro e salute, tra diritto del lavoro e medicina… La forma presa dal dibattito è stata quella della querelle su quali produzioni bloccare e quali no, quale voce si dovesse ascoltare di più, quali interessi dovessero prevalere.
Quali abbiano prevalso all’inizio diventa ogni giorno più chiaro: i catastrofici errori fatti nel gestire l’emergenza coronavirus in Lombardia – su tutti, non aver isolato la val Seriana – derivano in gran parte dall’aver anteposto le esigenze del padronato alla salute di lavoratori e cittadini. Tutt’intorno, nel mentre, si ricorreva al lockdown a macchia di leopardo e con continui riaggiustamenti, con piglio cialtrone e brancaleonesco.
E i lavoratori? Non pervenuti.
Non erano ancora entrati nello schermo del radar.
Per entrarci, hanno dovuto fare irruzione.
La working class in tempi di coronavirus: dall’invisibilità al protagonismo
Fin dalla prima puntata del nostro Diario virale abbiamo raccolto testimonianze dal mondo del lavoro, raccontando che le ordinanze in tema di epidemia stavano privando innumerevoli persone del loro reddito, che i precari si erano trovati fin da subito sotto il pelo dell’acqua, che molte e molti erano spinti alle ferie forzate… Il tutto perché le istituzioni avevano chiuso comparti – in primis quello della cultura e spettacoli – e sospeso attività in fretta e furia, per mostrare “nerbo”, dimenticandosi però dei lavoratori, senza chiarire quale fosse lo status di chi era costretto a restare a casa.
Sembrano già accadimenti remoti, tocca rovistare nel dimenticatoio per far notare che nelle prime due settimane nessun amministratore si è mosso per attivare alcun ammortizzatore, niente di niente. Hanno fatto la serrata e basta, passando pure per «responsabili». Ed è passato un mese buono, prima che il governo attivasse, oltre al frame paternalistico/poliziesco, un frame paternalistico/solidale/assistenziale. Perché accadesse, c’è voluta la minaccia di una rivolta sociale. C’è voluto lo spettro degli espropri proletari nei supermercati.
Nel frattempo, svariati padroni avevano approfittato delle ordinanze per chiudere baracca, alcuni per avviare una tanto attesa delocalizzazione, mandando a spasso i dipendenti. Il tutto in un contesto in cui era difficilissimo lottare, perché le restrizioni impedivano l’azione collettiva, e venivano usate per reprimere le lotte. Abbiamo visto picchetti caricati dalla polizia e sindacalisti – è accaduto, ad esempio al modenese Enrico Semprini – portati via a forza da piazzali di fabbriche e stabilimenti… in nome del contrasto al coronavirus.

La polizia interviene contro i dipendenti in lotta dell’Emiliana Serbatoi di Campogalliano (MO), 13 marzo 2020.
Motivazione paradossale: la repressione colpiva proprio chi nel frattempo aveva cominciato a scioperare per avere protezioni e tutele, per non ammalarsi in fabbrica o in magazzino.
Proprio come le rivolte nelle carceri partite pochi giorni prima, si trattava di lotte contro la gestione dell’emergenza sulla pelle dei più ricattabili, degli esclusi e dei più sfruttati. Lotte contro l’ipocrisia, contro la situazione incongrua e surreale creata da ordinanze, decreti e propaganda mediatica: #iorestoacasa ma tu vai a lavorare; io metto la mascherina ma a te in fabbrica non la danno; niente assembramenti ma tu ti assembri coi colleghi in fabbrica ogni giorno…
La domanda di quelle lavoratrici e lavoratori è stata: «Se dite che c’è un enorme e diffuso pericolo, come mai lo dobbiamo correre solo noi?»
Non ci è stato difficile raccogliere testimonianze. La moglie di uno di noi è sindacalista, mobilitata a tempo pieno dall’inizio di quest’emergenza, il fratello di uno di noi è operaio metalmeccanico, per non parlare di amiche e amici e parentado. Anche “accontentandoci” di questo, saremmo stati a un solo grado di separazione da centinaia di lavoratori che stavano subendo l’emergenza, scioperavano, raccontavano. E non ci siamo accontentati.

Sciopero alla Leonardo di Cascina Costa (LC), 9 marzo 2020.
Se si è fatta almeno la mossa di chiudere le produzioni non essenziali, è stato grazie a quell’ondata di scioperi di febbraio e marzo. Diciamo «la mossa», perché la lista dei codici Ateco che potevano continuare a operare è stata fin da subito molto lunga, e poi c’è stata la valanga di deroghe.
E a chi si è lasciato il compito di valutare le deroghe? Ai prefetti. Non agli assessorati alla salute, non agli uffici igiene, non alla medicina del lavoro, non ai sindacati, ma ai rappresentanti del governo sui territori. Con quale capacità o criterio di valutazione? Soltanto in Emilia-Romagna le deroghe sono state 28.000. Chi ha controllato che quelle imprese garantissero le tutele sanitarie ai lavoratori? Oltretutto, mentre la prefettura valutava il da farsi, quella fabbrica comunque non chiudeva. In dubio, pro domino.
Secondo l’Istat, in Italia è rimasto aperto per tutto il tempo oltre il 52% delle imprese.
Poi si è cominciato a parlare di «Fase 2», cioè del se e come riaprire anche le altre, ed è il momento in cui ci troviamo ora.

Sciopero alla Cartonstrong di Monza, 8 aprile 2020.
Tutto il lockdown è una questione di classe
Se da un lato la working class sembra più visibile e centrale, dall’altro si registra un’ulteriore invisibilizzazione della questione di classe. La working class è tale anche fuori del tempo di lavoro, anche in “quarantena”, e il lockdown e lo #stareacasa non sono mai stati uguali per tutti. Anzi. Come ha scritto Pietro De Vivo:
«Che nella gestione – tanto mediatica quanto fattuale – del pericolo del contagio si siano concretizzate discriminazioni di classe è evidente non solo dai vantaggi materiali di cui hanno goduto alcuni soggetti. Si nota anche in alcuni frame narrativi circolati sin dai primi giorni, come gli appelli a stare a casa incentrati non su necessità sanitarie ma su quanto sia bello restare nella propria abitazione, propagandati dai divi televisivi direttamente dalle loro ville con giardini o piscine, denotando un totale scollamento dalla realtà fatta di persone che vivono in case piccole o singole stanze, senza spazi aperti, in condomini senza affacci panoramici, e ignorando che per molte donne la casa non è affatto un luogo sicuro, per non parlare di chi una casa proprio non ce l’ha.»
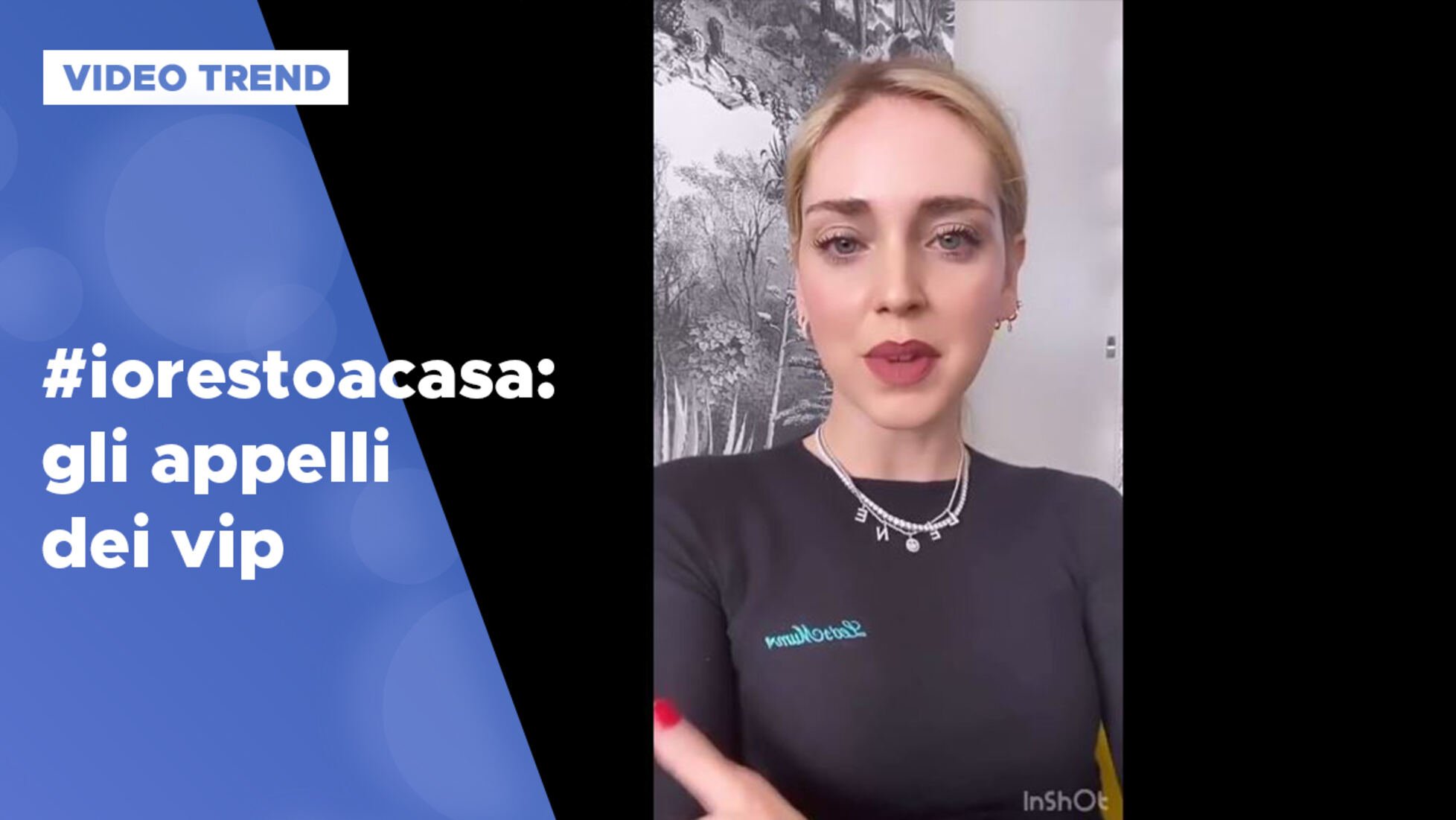
Un inciso: proprio la natura classista, diseguale e discriminatoria dello #stareacasa è stata fin da subito il fondamento della nostra critica ai decreti governativi e alla retorica dominante.
Come abbiamo provato a spiegare nella postilla a questo articolo, il nostro approccio è molto diverso da quello di chi ha parlato sì di lotte sul lavoro, ma sapendo dire quasi solo «chiudere tutto!», e soprattutto non criticando mai l’impianto dell’emergenza, i provvedimenti presi dal governo, la strategia dei capri espiatori, la repressione di comportamenti innocui. Anzi, sovente superando il governo stesso in rigidità, cipiglio burionesco e convinzione che la via imboccata fosse l’unica imboccabile.
Per noi la questione reale non è mai stata tout court «chiudere o tenere aperto», ma chiudere e tenere aperto cosa, con quale criterio e responsabilizzando chi.
Ecco perché abbiamo cercato di tenere insieme entrambi i piani: le lotte sul lavoro e la dissidenza nei confronti di norme assurde.
L’intuizione del Prunetti alla prova dell’emergenza Covid-19
Da questa fase, se non altro, la proposta di nuove scritture working class, avanzata su questo blog dal collega e compagno Alberto Prunetti e concretizzatasi in una collana per le Edizioni Alegre, esce rinvigorita e più attuale che mai.
Se ripercorriamo alla luce dell’emergenza coronavirus le «linee-guida» proposte da Alberto nel 2017, possiamo trarne spunti preziosi per raccontare le lotte degli ultimi due mesi e le sfide ai rapporti di forza che l’emergenza sta imponendo: 1) Niente approcci vittimari; 2) Umorismo di contrasto; 3) Responsabilità; 4) Punti di vista obliqui; 5) Narrazioni ibride; 6) Taglio da western crepuscolare; 7) Lingua antiretorica; 8) Atlante delle memorie operaie; 9) Ricorso all’allegorico e al perturbante, e dulcis in fundo, 10) «Test del babbo»:
«alla fine di ogni pagina mi chiedevo se mio padre o i suoi colleghi di lavoro avrebbero potuto apprezzare la pagina che avevo scritto o l’avrebbero considerata astrusa, o fighetta, o comunque lontana dai propri interessi. In questo senso, scrivevo deliberatamente per gli operai. Mi interessava che un operaio pensionato nato nel ‘45, o un suo giovane collega nato negli anni Ottanta fossero in grado di leggere il mio libro e di apprezzarlo a pieno. A dire il vero, non scrivevo solo per la vecchia classe operaia, ma anche per la nuova: un working poor, un precario dell’editoria con laurea, di estrazione sociale proletaria, o un figlio della classe media proletarizzata, costretto a fare un minijob per integrare le magre rendite di un lavoro da impiegato, è comunque parte della nuova working class. E confidavo che in quella pagina si ritrovasse e si riconoscesse anche lui. O lei.»
Questo nostro post è anche un invito a lavoratrici e lavoratori: scrivete delle vostre lotte ed esperienze da quand’è iniziata l’emergenza.
Chav: una nuova uscita… non ancora uscita
E qui arriviamo alla collana Working Class diretta da Alberto, e al libro Chav. Solidarietà coatta di D. Hunter pubblicato in italiano con prefazione di Wu Ming 4.
Si tratta di una delle tante nuove uscite “sacrificate” sull’altare del lockdown, mai arrivate fisicamente in libreria.
Scrivere e pubblicare in regime di lockdown è un’impresa improba: stamperie chiuse o a mezzo servizio, librerie chiuse, contratti sospesi, pagamenti dilazionati. Continuare a farlo è stato un modo di non piegarsi all’epidemia, ai metodi raffazzonati e incoerenti con cui la si è affrontata, al clima di isteria generale… e al morire di fame. Per questo Alegre ha deciso di pubblicare comunque Chav.
Si tratta di un libro strano e interessante, a metà tra la riflessione politica e l’autobiografia. L’autore, Dan Hunter, è un attivista britannico, fondatore di una rivista per autori working class, con una storia personale davvero tosta da raccontare.
Per lunghi giorni si è potuto acquistarlo soltanto online. Ma nei prossimi giorni un po’ di librerie riapriranno, compresa quella di Alegre al Pigneto, come spiegato nel comunicato Diffondere libri per una società solidale, noi riapriamo:
«Noi riapriremo la libreria rispettando ovviamente tutte le norme di sicurezza per chi lavora e per chi viene a trovarci, in primo luogo la precauzione che tutti gli esperti considerano più efficace per evitare il contagio: la distanza fisica di almeno un metro tra tutte le persone.
Ci teniamo però a chiamarlo “distanziamento fisico” e non “distanziamento sociale” perché la parola “sociale” vogliamo lottare per preservarla nel presente e nel futuro. “Sociale” è poter andare nella libreria di quartiere a farsi consigliare un libro da leggere, e scambiare due chiacchiere in tutta sicurezza con un libraio; “sociale” è permettere alle librerie di sopravvivere anche dopo la pandemia; “sociale” è costruire idee collettive per fermare un modo di produrre destinato a devastare il pianeta e le nostre stesse esistenze. Abbiamo sempre combattuto chi ci ha detto negli ultimi quarant’anni che “la società non esiste, esistono solo gli individui”: non vogliamo smettere di farlo proprio oggi.»
È arrivato, dunque, il momento del vero “lancio” di Chav. Il momento di pubblicare la prefazione di Wu Ming 4.
Buona lettura.

La libreria Alegre, Roma.
Prefazione all’edizione italiana – di Wu Ming 4
«Non è la coscienza degli uomini che determina la loro vita,
ma le condizioni della loro vita che ne determinano la coscienza»
K. Marx, Per la critica dell’economia politica
La storia di D. Hunter raccontata da lui stesso medesimo è una sorta di apologo politico, il cui protagonista potrebbe essere un Oliver Twist del XXI secolo e con un happy ending che lascia l’amaro in bocca e mette il lettore allo specchio. Non importa quanto diversa sia la biografia di chi legge – molto probabilmente sarà assai diversa, in effetti –, perché quello che conta è il dato di fatto che ci viene sbattuto in faccia. E cioè che la realtà narrata in questo libro è il prodotto del sistema, nel bene e nel male. Una consapevolezza questa, alla quale il protagonista giunge dopo un’infanzia e una giovinezza “difficili”, per usare un eufemismo, e che, come in una perfetta parabola marxiana, lo porta a diventare un militante anticapitalista.
La svolta avviene grazie a una serie di incontri fortuiti con attivisti politici di base, ma la scintilla scocca in galera, leggendo le Lettere dal carcere di Gramsci.
Certe letture cambiano la vita. Possono perfino trasformarti in uno scrittore a tua volta, in qualcuno che ha qualcosa da raccontare al mondo, traendo un senso generale dal proprio destino particolare. Quando Hunter parla di dinamiche capitalistiche, patriarcali, razziste (questa è la triade che chiama continuamente in causa) e mostra le cicatrici che gli hanno lasciato sulla pelle, non ha bisogno di teorizzare e non gli serve altra sociologia che quella inscritta nella sua storia.
Tuttavia è difficile definire questo libro una biografia, perché la scrittura segue il ragionamento della voce narrante piuttosto che una trama. C’è un tizio che riflette su ciò che gli è accaduto, e non ti racconta le cose per filo e per segno, ma piuttosto per aneddoti, accenni, descrizioni di momenti, gesti, stati d’animo, che sta al lettore mettere in sequenza. L’andamento è ondivago e lo stile spiazzante, ineffabile: a volte l’io narrante parla del passato, a volte del presente; a volte del “sé” di prima, a volte di quello di oggi; a volte le immagini arrivano come jab d’ingaggio, a volte come montanti alla mandibola.
L’infanzia del protagonista, nella periferia di Nottingham, nella pancia dell’Inghilterra reale – non quella venduta ai turisti in forma di countryside, World Wide London e Windsor Dinasty – è un mix quasi letale di prostituzione minorile, abbandono, microcriminalità e reclusione. Il tutto condito con dosi di disagio mentale e comizi del British National Party. Una lumpen-vita verso la quale il narratore non mostra alcuna accondiscendenza. Eppure, dopo essere scampato a tutto questo, riesce comunque a dire che se fosse stato donna o nero avrebbe avuto molte meno chance di sfangarla. Perfino all’inferno vige la gerarchia sistemica. Forse soprattutto lì. Ma in quei gironi infernali c’è anche un’altra cosa: la solidarietà dei coatti, dei chav, i paria della società neoliberista. Qualcosa che tra i “regolari” non troverà in egual misura.
«Nelle persone dimenticate dalla società ufficiale ho visto, ho trovato un bisogno di solidarietà profondo, di accettazione degli altri, mentre la società rispettabile mi spinge a giudicare e respingere gli altri».
Il recupero della chav solidarity si compie al netto di qualsivoglia esaltazione naïf e senza alcuna retorica. Hunter vuole ricordare ai regolari e ai borghesi di sinistra cosa si è costretti a fare per sopravvivere a determinate condizioni, e quanto sia importante l’aiuto insperato tra disperati, di cui loro non sanno nulla. Il suo approdo alla militanza finirà per ricordarci, di riflesso, che la sinistra liberale, la sinistra senza lotta di classe, si autoriduce a una parte di borghesi benpensanti, che si sentono inutilmente superiori al resto del mondo perché hanno letto più libri e – nella migliore delle ipotesi – assumono comportamenti virtuosi potendoseli permettere. Se poi in questo si volesse trovare la radice della crisi di quella compagine politica, lo si farebbe a buon diritto.
Hunter non risparmia critiche anche ai suoi nuovi compagni, con i quali non realizza furti né si prostituisce, ma partecipa all’organizzazione di lotte sociali e movimenti dal basso. Quanto sanno, quanto conoscono, i militanti dei movimenti politici anticapitalisti della macchina tritacarne che intendono combattere? Quanto sono solidi i loro moventi? Troppo spesso, dice il narratore, «quel che ho visto e provato in questi movimenti era una spiacevole combinazione di autocompiacimento per la propria saggezza e di dubbi sul fatto che ne valesse la pena».
Ecco perché questo libro mette il lettore allo specchio, si diceva. Perché registra anche i tic e i meccanismi autodifensivi dei militanti più o meno integrati o dotati di quello che Hunter chiama “capitale culturale”, quindi comunque avvantaggiati rispetto agli ultimi della società con i quali si sentono solidali. Ci sarebbe molto da riflettere su queste sue considerazioni. Sul fatto che la lotta che conta davvero è quella condotta da chi subisce la discriminazione sociale piuttosto che dai “garantiti” che si candidano a rappresentarlo. Il problema è proprio quello di rendere protagonisti delle lotte i soggetti che nella società capitalistica vengono marginalizzati o discriminati: le donne; gli immigrati; la comunità LGBTQ; i non bianchi; «coloro che hanno più familiarità con la precarietà dell’economia» e non già «chi si prende il lusso di fare il povero a vent’anni, e poi pretende di contare quanto chi non ha altra scelta che essere povero».
Chi viene dai bassifondi e guadagna l’autocoscienza di classe sospetta che chi non ha compiuto lo stesso cammino, ma ha potuto scegliere uno stile di vita e relazionale, mantenga un germe di paternalismo nell’approccio alle lotte e di incombente disillusione, non appena qualcosa non va come dovrebbe andare. Per coloro ai quali niente è mai andato come dovrebbe andare, il problema non si pone. E certo difficilmente costoro cadranno nel vizio borghese di disquisire e distinguere le forme del conflitto come fossero opzioni liberamente selezionabili. Il narratore riconosce in questa tentazione l’imprinting idealistico di chi è più interessato a teorizzare la forma di lotta perfetta o a stabilire i confini del politicamente lecito e politicamente corretto, piuttosto che assumersi l’onere di riconoscere e appoggiare gli oppressi senza condizioni. Così ci ricorda – e non lo farà mai abbastanza – che basta un attimo per rientrare nel discorso dominante:
«Si continua a rifiutare l’idea che debba essere l’oppresso a decidere la propria forma di resistenza. Gli altri devono sostenere quella scelta, se vogliono essere considerati alleati o complici. L’alternativa è passare al lato dell’oppressore».
Hunter riconosce di dovere la propria rinascita e presa di coscienza agli «attivisti e organizzatori radicali che hanno provato nella loro esistenza la povertà e il precariato», imparando da loro cose come il valore dell’organizzazione, della cooperazione, la fiducia reciproca, cose che non andrebbero mai date per scontate, davvero mai, soprattutto presso chi nasce e cresce oggi. Tra questa gente ha trovato un ruolo attivo – ancorché sempre scomodo, sempre sulle spine – e grazie a questo ha potuto trasformare il potenziale autodistruttivo della vita di prima in attivismo politico. Ciò ha significato anche il raggiungimento di un parziale equilibrio esistenziale, una maggiore integrazione nella working class, una vita “normale”, nella quale è consapevole che non si troverà mai del tutto a proprio agio, come se questi nuovi panni non fossero davvero i suoi, ancorché preferibili a quelli di un tempo.
Ecco la grande qualità della scrittura di Hunter, del suo modo di riflettere: la sincerità, essere diretto, soprattutto nel parlare delle contraddizioni proprie e altrui. In una parola, la parresia. La dote degli intellettuali con i controcazzi. Hunter non racconta tutto, ma senz’altro dice tutta la verità, senza fare sconti né a sé né agli altri, con una lucidità disarmante, proprio perché priva di autogiustificazioni ed ellissi. Il suo non è il sentenziare romantico di un vecchio duro, non è il tono di chi dice «ho visto cose che voi umani…», ma la riflessione asciutta di un quarantenne che ha già vissuto due vite e prova a farne tesoro senza autoindulgenza, perché fanno entrambe parte di lui: la solidarietà coatta e la coscienza politica; l’istinto di sopravvivenza e la lotta di classe.
Una voce del genere va senza dubbio letta e ascoltata.



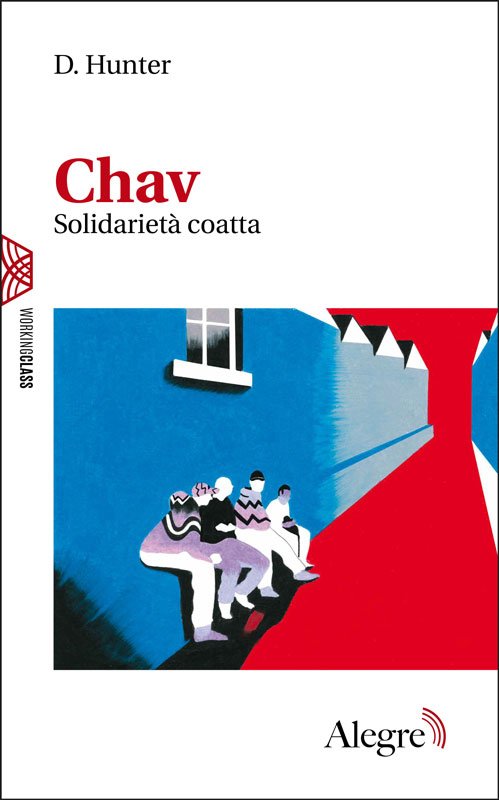
 Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)
Scarica questo articolo in formato ebook (ePub o Kindle)