di Fabio Ciabatti
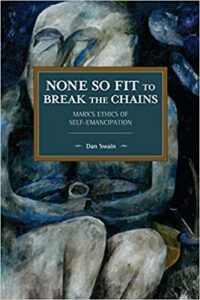 Dan Swain, None So Fit to Break the Chains. Marx’s Ethics of Self-Emancipation, Haymarket Books, Chicago 2020. pp. 224, 33,00 euro.
Dan Swain, None So Fit to Break the Chains. Marx’s Ethics of Self-Emancipation, Haymarket Books, Chicago 2020. pp. 224, 33,00 euro.
“L’emancipazione della classe operaia deve essere opera dei lavoratori stessi”. Questa famosa affermazione di Marx appare inequivocabile. Basta però, per alimentare qualche dubbio, accostare questa citazione a un altro famoso passaggio in cui il Moro di Treviri parla dell’“organizzazione dei proletari in classe e quindi in partito politico”. Si può così concludere che l’emancipazione della classe operaia è sostanzialmente opera del Partito comunista. Peccato che, come si evince dall’intero corpus marxiano e come è stato chiarito esplicitamente in una lettera dal diretto interessato, Marx quando parla di partito si riferisce generalmente al partito della classe in senso eminentemente storico, non a una qualche specifica organizzazione politica.
In altri termini, il concetto di partito, almeno nella sua accezione dominante nell’opera marxiana, coincide con il “movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti”.1 Un movimento che si costituisce come parte, la parte proletaria in lotta con quella borghese, ponendosi l’obiettivo politico di abbattere il modo di produzione dominante e per fare ciò si cristallizza temporaneamente in specifiche organizzazioni. Saremmo però dei materialisti assai bizzarri se pensassimo che importanti sviluppi storici, come la centralità assunta dal partito nelle vicende novecentesche, siano dipesi dalla cattiva interpretazione di alcuni testi, fossero anche quelli di Marx.
La citazione con cui abbiamo aperto testimonia che l’intera opera marxiana è pervasa da un impegno etico-politico nei confronti della rivoluzione intesa come autoemancipazione del proletariato.2 Ma stando così le cose si apre subito un problema: se la società comunista deve essere il frutto di un’autonoma attività emancipatrice del proletariato come può darsi questa attività in una società che sistematicamente la impedisce? E’ proprio a fronte di questa difficoltà teorica, ma soprattutto pratica, che si afferma la soluzione rappresentata dal primato del partito sulla classe. Che però non è la soluzione di Marx il quale nota perentoriamente, nella terza tesi su Feuerbach, che “l’educatore stesso deve essere educato”.
 E’ allora interessante utilizzare il principio dell’autoemancipazione del proletariato come cartina di tornasole per valutare alcuni snodi centrali dell’opera marxiana, come fa Dan Swain in un recente testo intitolato None so fit to break the chain. Marx’s ethics of self-emancipation.3 Da questa prospettiva si può comprendere meglio l’antiutopismo di Marx, laddove per utopia si intenda la costruzione di piani dettagliati per la società dell’avvenire. Se c’è qualche mente illuminata che è in grado di progettare in anticipo il futuro con dovizia di particolari, allora è chiaro che alla massa non rimane che il ruolo del mero esecutore. Addio autoemacipazione.
E’ allora interessante utilizzare il principio dell’autoemancipazione del proletariato come cartina di tornasole per valutare alcuni snodi centrali dell’opera marxiana, come fa Dan Swain in un recente testo intitolato None so fit to break the chain. Marx’s ethics of self-emancipation.3 Da questa prospettiva si può comprendere meglio l’antiutopismo di Marx, laddove per utopia si intenda la costruzione di piani dettagliati per la società dell’avvenire. Se c’è qualche mente illuminata che è in grado di progettare in anticipo il futuro con dovizia di particolari, allora è chiaro che alla massa non rimane che il ruolo del mero esecutore. Addio autoemacipazione.
Però, se per utopia intendiamo semplicemente la speranza o la fiducia in una società futura radicalmente migliore di quella presente definire Marx un antiutopista è un semplice non senso. Esiste comunque una terza accezione di utopia che si incentra sulla proposta di modelli alternativi di società dal carattere esplicitamente limitato e provvisorio. Nei confronti di questi tipi di modelli Marx rimane diffidente perché ritiene possano rappresentare un elemento fuorviante rispetto alle necessità più impellenti del conflitto di classe. Un atteggiamento che ha le sue fondate ragioni, sostiene Swain, ma che da un punto di vista politico potrebbe portare a sottostimare la capacità mobilitante di un immaginario alternativo sufficientemente articolato. E ciò è vero oggi più che ai tempi di Marx, perché noi dobbiamo fare i conti con il crollo di un immaginario centrato, in un modo o nell’altro, sul socialismo realizzato di stampo sovietico.
Poiché la nostra capacità di prevedere il futuro è limitata, prosegue Swain, l’immagine della futura società comunista deve essere concepita come una visione. Siamo cioè capaci di raffigurare la società futura allo stesso modo in cui siamo in grado di vedere, da un punto di osservazione posto in alto, un paesaggio lontano di cui possiamo scorgere solo i contorni più marcati, le figure più grandi. Quanto più cerchiamo con l’immaginazione di riempire di dettagli ciò che non possiamo osservare direttamente, tanto più siamo portati a utilizzare inconsapevolmente elementi tratti dalla nostra esperienza quotidiana. Il futuro diventa così un ombra del presente. Ciò che rimane precluso è il nuovum in senso forte, perché esso può essere prodotto e concepito soltanto attraverso una prassi di emancipazione di un soggetto collettivo che si trova ad operare in modo autonomo in circostanze impreviste e imprevedibili.
 Non potendo eliminare la contingenza dalla nostra visione politica, cosa rimane del materialismo storico inteso come analisi scientifica del funzionamento del modo di produzione capitalistico e come capacità di prevedere le sue traiettorie di sviluppo futuro? Di certo comprendere che le leggi che governano il nostro mondo sono storicamente determinate è il primo passo necessario per capire che possono essere cambiate. Ma non è tutto. Imparare a leggere i necessari vincoli che i rapporti sociali di produzione ci pongono è un altro passo necessario per formulare concrete strategie per sovvertire le regole del gioco. In base a queste regole possiamo prevedere l’avverarsi di alcune categorie di eventi, come crisi e rivoluzioni, non i singoli eventi. Solo se l’analisi scientifica non diventa rivelazione di un futuro già scritto, profezia, essa può diventare strumento nelle mani di un soggetto collettivo che liberamente si autodetermina.
Non potendo eliminare la contingenza dalla nostra visione politica, cosa rimane del materialismo storico inteso come analisi scientifica del funzionamento del modo di produzione capitalistico e come capacità di prevedere le sue traiettorie di sviluppo futuro? Di certo comprendere che le leggi che governano il nostro mondo sono storicamente determinate è il primo passo necessario per capire che possono essere cambiate. Ma non è tutto. Imparare a leggere i necessari vincoli che i rapporti sociali di produzione ci pongono è un altro passo necessario per formulare concrete strategie per sovvertire le regole del gioco. In base a queste regole possiamo prevedere l’avverarsi di alcune categorie di eventi, come crisi e rivoluzioni, non i singoli eventi. Solo se l’analisi scientifica non diventa rivelazione di un futuro già scritto, profezia, essa può diventare strumento nelle mani di un soggetto collettivo che liberamente si autodetermina.
E qui sorge la domanda successiva. Questo soggetto che si autodetermina verso quale meta si dirige? L’autodeterminazione per Marx è possibile solo attraverso forme sociali che permettono la gestione democratica dell’attività lavorativa, l’appropriazione della totalità delle forze produttive da parte degli individui uniti. Ciò è impossibile nel mondo moderno su piccola scala e per questo è necessario esercitare una capacità di decisionalità collettiva su una scala geografica sufficientemente ampia. Quale che sia questa scala, è il lavoro stesso che deve cambiare e a tal fine è necessario superare la distinzione tra lavoro mentale e manuale, tra compiti direttivi e compiti esecutivi. Certamente Marx sostiene che il regno della libertà inizia solo dove finisce il regno della necessità. Ma se intendiamo quest’ultimo come il regno del lavoro necessario a soddisfare i bisogni della società, non c’è bisogno di pensarlo come il luogo della subordinazione e della soggezione dei lavoratori. La limitazione della giornata lavorativa per Marx è essenziale ma, sostiene Swain, rappresenta un mezzo, non un fine. Altrimenti si finirebbe per confermare la contrapposizione tra tempo libero e tempo di lavoro limitandosi ad ampliare il primo a discapito del secondo. Rimane invece vero che è necessario superare la relazione antagonistica che è storicamente esistita tra lavoro e libertà.
Questo antagonismo e lo sfruttamento che è ad esso connesso è per Marx storicamente necessario e al tempo stesso da condannare. Questa condanna non avviene però sulla base di una morale metastorica. Ogni società ha una sua giustificazione morale delle forme di sfruttamento storicamente date. Esse sono in qualche modo legittime. Questa necessità storica può essere messa in questione soltanto perché lo sfruttamento è vissuto da una parte della società come qualcosa contro cui combattere. Se ci si mette dal punto di vista degli sfruttati questa reazione non ha nulla di misterioso. Per combattere lo sfruttamento non c’è bisogno di basarsi su una qualche teoria della giusta distribuzione della ricchezza o dello scambio equo tra possessori di beni. Ciò che in ultima istanza emerge dalla critica marxiana dello sfruttamento, afferma l’autore, è che esso rappresenta una rapporto di dominio, esercitato in primo luogo nel segreto laboratorio della produzione, in cui i capitalisti approfittano della debolezza e della mancanza di potere dei lavoratori.
In modo simile Swain sostiene che per parlare di alienazione non abbiamo bisogno di una concezione essenzialista, metastorica della natura umana che verrebbe negata dall’attuale società. E’ sufficiente focalizzarsi sulle reali esperienze di sofferenza fisica e psicologica cui sono sottoposti i lavoratori e le lavoratrici. Partendo da questa negatività possiamo sostenere che l’essenza umana è qualcosa che deve essere ancora realizzata. Parlare di alienazione è dunque un modo per denunciare una situazione economico-sociale che nega la possibilità di un’attiva partecipazione degli individui uniti alla libera costruzione dell’identità umana.
 In un modo o in un altro si torna verso la medesima conclusione: la possibilità di riempire di dettagli la visione del comunismo non dipende da standard preordinati all’azione politica, siano essi relativi alla giustizia distributiva o all’essenza umana, ma può emergere solo nell’ambito di movimenti di resistenza e reazione a specifici mali della società capitalistica. Ciò significa, tra l’altro, che la resistenza deve possedere dei caratteri prefigurativi, in grado cioè di anticipare alcuni elementi della realtà che vogliamo costruire. Deve essere in grado, mentre si pone specifici obiettivi, di proiettarsi verso un successivo stadio di sviluppo che ancora non è dato, aiutando così la trasformazione dei soggetti coinvolti, l’acquisizione di nuove capacità ed attitudini. Questo perché la coscienza comunista, almeno su larga scala, non è qualcosa di dato, ma qualcosa da costruire, da conquistare. L’autoemancipazione è cioè un processo collettivo di autoeducazione attraverso il conflitto. Solo così è possibile sviluppare pratiche sociali realmente nuove e differenti rispetto a quelle esistenti. Queste pratiche sociali devono negare alla radice la separatezza tra sfera socio-economica e sfera politico-statuale. In questo senso l’autoemancipazione è una pratica di spoliticizzazione e dunque di critica di tutte quelle forme politiche che in questa separazione trovano il loro habitat naturale. Ma, per altro verso, si tratta di una dinamica di politicizzazione radicale, nel senso che attribuisce alla decisionalità collettiva una capacità di intervento su sfere sociali, economiche e anche personali considerate oggigiorno sottoposte all’arbitrio privato o a leggi “naturali” e perciò immodificabili.
In un modo o in un altro si torna verso la medesima conclusione: la possibilità di riempire di dettagli la visione del comunismo non dipende da standard preordinati all’azione politica, siano essi relativi alla giustizia distributiva o all’essenza umana, ma può emergere solo nell’ambito di movimenti di resistenza e reazione a specifici mali della società capitalistica. Ciò significa, tra l’altro, che la resistenza deve possedere dei caratteri prefigurativi, in grado cioè di anticipare alcuni elementi della realtà che vogliamo costruire. Deve essere in grado, mentre si pone specifici obiettivi, di proiettarsi verso un successivo stadio di sviluppo che ancora non è dato, aiutando così la trasformazione dei soggetti coinvolti, l’acquisizione di nuove capacità ed attitudini. Questo perché la coscienza comunista, almeno su larga scala, non è qualcosa di dato, ma qualcosa da costruire, da conquistare. L’autoemancipazione è cioè un processo collettivo di autoeducazione attraverso il conflitto. Solo così è possibile sviluppare pratiche sociali realmente nuove e differenti rispetto a quelle esistenti. Queste pratiche sociali devono negare alla radice la separatezza tra sfera socio-economica e sfera politico-statuale. In questo senso l’autoemancipazione è una pratica di spoliticizzazione e dunque di critica di tutte quelle forme politiche che in questa separazione trovano il loro habitat naturale. Ma, per altro verso, si tratta di una dinamica di politicizzazione radicale, nel senso che attribuisce alla decisionalità collettiva una capacità di intervento su sfere sociali, economiche e anche personali considerate oggigiorno sottoposte all’arbitrio privato o a leggi “naturali” e perciò immodificabili.
Non bisogna però dimenticare che questi processi si sviluppano nell’ambito di dinamiche conflittuali e devono fare i conti con la violenza dello relazioni sociali dominanti e dello stato. Secondo Marx nessuna rivoluzione si può dare senza che a un certo punto si ponga il problema del potere statale. Che si tratti di conquistarlo, di distruggerlo o di impadronirsene per trasformarlo in profondità i temi della violenza degli sfruttati e quello della loro organizzazione diventano ineludibili, con tutto il portato problematico che riguarda il rapporto tra efficacia dell’azione politica e principio dell’autoemancipazione, tra politica e etica rivoluzionarie. Anche per questo, pur assumendo che la coerenza tra mezzi e fini sia un problema decisivo, è semplicemente assurdo assumere che i primi debbano coincidere con i secondi.
 Alla luce di queste ultime considerazioni il tema dell’autoemancipazione, se preso sul serio, risulta essere meno “innocente” di quanto potrebbe apparire a prima vista. Ma proprio per questo un pensiero che si pretenda rivoluzionario, come sostiene Swain, deve prendere sul serio l’attualità della rivoluzione ponendosi, in ogni fase, la questione di cosa possa aiutare il proletariato a costruire e riconoscere la propria capacità di trasformare il mondo. E per fare questo non bisogna applicare schemi esterni alle lotte degli sfruttati o pretendere di educare e dirigere ex cathedra gli oppressi, ma occorre partecipare alla loro forme di resistenza cercando di far avanzare, dall’interno, i movimenti di autoemancipazione. Occorre camminare domandando per cercare collettivamente le possibili risposte, ciascuno secondo le proprie capacità e i propri bisogni.
Alla luce di queste ultime considerazioni il tema dell’autoemancipazione, se preso sul serio, risulta essere meno “innocente” di quanto potrebbe apparire a prima vista. Ma proprio per questo un pensiero che si pretenda rivoluzionario, come sostiene Swain, deve prendere sul serio l’attualità della rivoluzione ponendosi, in ogni fase, la questione di cosa possa aiutare il proletariato a costruire e riconoscere la propria capacità di trasformare il mondo. E per fare questo non bisogna applicare schemi esterni alle lotte degli sfruttati o pretendere di educare e dirigere ex cathedra gli oppressi, ma occorre partecipare alla loro forme di resistenza cercando di far avanzare, dall’interno, i movimenti di autoemancipazione. Occorre camminare domandando per cercare collettivamente le possibili risposte, ciascuno secondo le proprie capacità e i propri bisogni.
