di Franco Pezzini
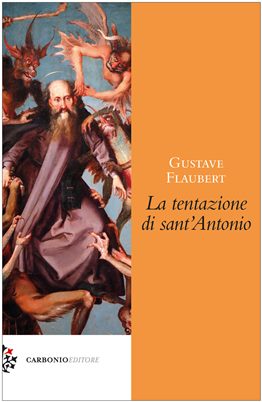 Gustave Flaubert, La tentazione di sant’Antonio, trad. e cura di Bruno Nacci, pp. 169, € 16,50, Carbonio, Milano 2023.
Gustave Flaubert, La tentazione di sant’Antonio, trad. e cura di Bruno Nacci, pp. 169, € 16,50, Carbonio, Milano 2023.
Mesi fa, una splendida mostra al Palazzo Reale di Milano, Bosch e un altro Rinascimento, inanellava una quantità di dipinti del genio fiammingo o a lui ispirati anche e proprio sul soggetto della tentazione di sant’Antonio. Modello per una diluviale iconografia, il tema mosso a monte da alcune pagine di grande potenza visionaria dell’agiografica, godibilissima Vita Antonii di Atanasio di Alessandria (circa 357) vede la trascrizione più lussureggiante di un topos – la tentazione, con lo scatenarsi del demoniaco in tutte le sue facies – dai mille richiami: si pensi solo alle tentazioni di Buddha, di Gesù, di una quantità di eroi dello spirito, fino in fondo alle riletture ironiche (per esempio il geniale Simón del desierto di Luis Buñuel, 1964) o tutte laiche nella cultura popolare (le “tentazioni” di Holmes da parte di Moriarty, di Van Helsing da parte di Dracula – in particolare nella trasposizione Universal – eccetera). Insomma, un tema enorme. Tanto più che, come la danza di Salomè, l’avventura di Giuditta, alcune scene dai martirologi e altre spigolate tra l’immaginario sacro e quello classico, la tentazione di sant’Antonio figura come una delle emblematiche strutture-tipo che nutrirono per secoli un fantastico pre-horror prima che nascesse un genere con questo nome.
Certo, l’Antonio storico (251-356), fondatore del monachesimo cristiano e protoabate, ha talora poco a che vedere con le sue immagini nelle fantasie artistiche: e certamente poco ha in comune con il tormentato protagonista – un “avatar di un autore-creatore” (Nacci: e ancora, “Antonio, il santo, è un eremita, fragile e inattaccabile come il Re nel gioco degli scacchi, che quando viene preso fa cessare la partita”) – di questo straordinario oggetto narrativo non identificato, riconducibile in qualche forma al teatro e tuttavia irriducibilmente altro. Un testo la cui esplosione lisergica si mantiene intatta (esperienza personale) a ogni rilettura, a distanza d’anni: visionario quanto i modelli nordeuropei che vi restano alla base (il primo cenno al progetto è in una lettera di Flaubert del 13 maggio 1845, dove cita la visione di un “dipinto di Brueghel” oggi attribuito a Jan Verbeeck) e tale da impegnare il “mistico che non crede a niente” fino al 1872, è nei fatti “l’opera di tutta la mia vita”, come al tempo confida.
Un’opera che di questo non credere a niente gronda in modo allucinatorio: certamente non nella militanza ideale (definisce antipaticamente chiens enragés gli insorti della Comune e sintetizza “Tutto il sogno della democrazia […] nell’elevare il proletariato al livello della stupidità borghese”) ma neppure nelle fedi. Purtroppo Baudelaire non scrive sull’opera l’intervento puntuale che si era ripromesso, quando aveva intuito che la Tentation, “chambre secrète” di Flaubert, come e più che Madame Bovary tenderebbe al lettore un filo per guidarlo nel “cafàrnao pandemoniaco della solitudine”. Riproporlo oggi come fa Carbonio, al mercato editoriale di un’Italia sempre più sola, demotivata, esaurita e amareggiata, infestata da demoni di quart’ordine – dove nessuna Arianna tende fili a salvarci e in compenso abbondano i Minotauri con le loro teste di manzo – sembra un’operazione di grande interesse, e l’edizione, ben commentata e glossata da Bruno Nacci, è molto bella.
Ovviamente l’opera, nel brulicare di nomi d’eresie e di bestie fantastiche, si rivela frutto di letture d’intere biblioteche, di visioni almeno idealmente d’intere quadrerie, con un gusto che prelude da un lato a Salammbô (1862, l’altro prodotto vertiginoso del delirio lisergico flaubertiano) e dall’altro a Bouvard et Pécuchet (1881, postumo – con il suo enciclopedismo da commedia). Ma forse visioni sovrannaturali, polemiche di fedi, febbri immaginali sono proiettate anche dal gioco d’ombre cinesi di notizie che Flaubert spigola sui giornali, in una Francia dove cattolicesimo e anticlericalismo si confrontano con clamore tra apparizioni mariane (La Salette 1846, Nouillan 1848, Lourdes 1858, Pontmain 1871…), epopee spirituali contro il diavolo (quelle per esempio del Curato d’Ars per circa trentacinque anni, 1824-1858) e deliri misticheggianti dai risvolti talora molto torbidi (da Eugène Vintras all’Abate Boullan, per non parlare di certo ambiguo esoterismo “cristiano”: Éliphas Lévi, Joséphin Péladan, Alexandre Saint-Yves d’Alveydre…) – e ci si prepara a una stagione che Flaubert non vedrà ma ben potrebbe essere anticipata in queste pagine, tra le goliardate truffaldine di Léo Taxil, le febbri mistiche di Huysmans e le riscoperte dei Grands Initiés di Schuré.
 Dagli scontri tra cattolici e ariani, in un trascolorare di sfondi favolosi, Antonio si trova così catapultato in un maelstrom di visioni alla Gustave Moreau che ne insidiano anima e (diremmo) salute mentale: prima ordinarie e umanissime, poi via via eccezionali. Almeno per noi, ai quali non sono mai apparsi sulla porta di casa la Regina di Saba – recuperata da tutta una tradizione di letture esotiche (si pensi solo a Nerval), e tuttavia qui evocata con febbrile originalità – o il profeta Mani o Tertulliano. Ecco dunque prima lo sciame di eresiarchi ed eretici tardoantichi, fino alle sette più malfamate come carpocraziani, nicolaiti e cainiti, e poi gli orfani dei morti per fede; quindi un gimnosofista, Simon Mago con Elena Ennoia e quell’Apollonio Tianeo di cui Éliphas Lévi avrebbe condotto negli anni Cinquanta l’evocazione necromantica, e che un lungo revival polemico anticristiano contrapporrà a Gesù. E non a caso ha uno spazio importante (con il suo Watson/Sancio Panza, Damide) in queste pagine di turbamenti di Antonio.
Dagli scontri tra cattolici e ariani, in un trascolorare di sfondi favolosi, Antonio si trova così catapultato in un maelstrom di visioni alla Gustave Moreau che ne insidiano anima e (diremmo) salute mentale: prima ordinarie e umanissime, poi via via eccezionali. Almeno per noi, ai quali non sono mai apparsi sulla porta di casa la Regina di Saba – recuperata da tutta una tradizione di letture esotiche (si pensi solo a Nerval), e tuttavia qui evocata con febbrile originalità – o il profeta Mani o Tertulliano. Ecco dunque prima lo sciame di eresiarchi ed eretici tardoantichi, fino alle sette più malfamate come carpocraziani, nicolaiti e cainiti, e poi gli orfani dei morti per fede; quindi un gimnosofista, Simon Mago con Elena Ennoia e quell’Apollonio Tianeo di cui Éliphas Lévi avrebbe condotto negli anni Cinquanta l’evocazione necromantica, e che un lungo revival polemico anticristiano contrapporrà a Gesù. E non a caso ha uno spazio importante (con il suo Watson/Sancio Panza, Damide) in queste pagine di turbamenti di Antonio.
Di lì si passa agli dei dell’India e a Buddah, a divinità dell’Oriente come Oanne, Ormuz e la Grande Diana di Efeso, a Cibele coi suoi Galli e Attis che si evira: poi ecco Iside, gli dei dell’Olimpo che fanno palpitare anche il cuore dell’eremita… ma via via cadono e muoiono. Dei minori e potenze di altri popoli – Sciti, Etruschi, Italici, Romani (compreso Crepitus, patrono delle flatulenze) scorrono via gemendo, ed è uno sberleffo dell’autore porre in coda il Dio degli eserciti ebraico: e alla fine il discepolo Ilarione con cui Antonio ha continuato a confrontarsi, sorta di Virgilio delle tenebre nella selva oscura delle opzioni spirituali, si presenta “Il mio nome è Scienza”… per poi rivelarsi chi in fondo sospettavamo fosse, il Diavolo. Questo, in un vertiginoso volo memore di infinite pagine devozionali o letterarie (si pensi solo alla conclusione del Monaco di Lewis), trasporta l’eremita nel cosmo, proclamando che in esso “Non c’è nessuno scopo!” e pretendendo la sua adorazione.
Frustrato, il Demonio lo abbandona a un’ultima schiera di tentazioni e visioni: la Morte e la Lussuria, la Chimera e la Sfinge, poi la schiera dei popoli favolosi, i mostri e le bestie marine, la varietà sconfinata delle creature fino agli altri ordini di esistenza – vegetali, minerali… Ma appunto dopo aver gioito dell’infinita ricchezza e varietà della vita e della materia, ormai purificato dai fanatismi spiritualistici, Antonio può riprendere a pregare: e lo fa davanti al volto di Gesù – il Dio incarnato nella materia – dardeggiante nel sole.
Una materia di cui in fondo, sappiamo, fa parte la stessa letteratura, precipitato del nostro essere carne e sangue. Ma nella nostra Tebaide quotidiana, di solitudine forzata e prolungata davanti agli schermi, ad apparire a tormentarci non sono gli Elkesaiti “in vesti di giacinto”, i Paterniani o gli Sciapodi libici. Basta aprire internet e un diverso sciame di voci nel segno del Catoblepa – la bestia tra bovino e maiale con occhi fissi in basso, forse trasfigurazione dello gnu – emerge per esempio nei titoli sguaiati e scandalistici di certi aggregatori web, tra amorazzi di starlette, presunte notizie-bomba troppo frequenti per esserlo, flatulenze reazionarie tra la malignità e il “Maestra, i progressisti mi hanno fatto male”. Voci che neanche Crepitus prenderebbe sotto il proprio patronato: ma in tale presente desolato, quella materia che è la letteratura arriva a offrirci qualche palpito di consolazione, almeno qualcuno, nel nostro “scendere fino in fondo alla materia, essere materia!”.


