di Sandro Moiso
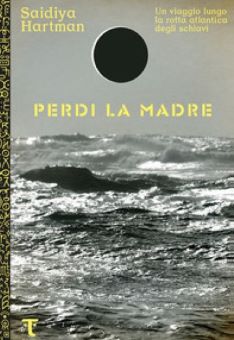 Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro
Saidiya Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, pp. 332, 18 euro
«Un viaggio lungo la rotta atlantica degli schiavi» recitano sia la copertina che il frontespizio del testo di Saidiya Hartman edito da Tamu, ma andrebbe aggiunto che involontariamente lo stesso libro ci accompagna lungo le linee di faglia di un percorso le cui fratture risultano essere altrettanto significative quanto l’apparente unità della sua eredità storica e sociale.
Quello che chi scrive non esiterebbe a definire come un romanzo-saggio, vista la passione e l’impegno compresi nel narrare elementi di storia che poco a poco sembrano fondersi con la vita e le memorie personali dell’autrice, costituisce infatti una sorta di viaggio lungo quella linea del colore che fin dall’epoca coloniale sembrerebbe aver costituito l’unico momento, per quanto doloroso, di unione tra coloro che dall’Africa furono deportati verso le Americhe e i loro discendenti.
Saidiya Hartman, che i lettori di Carmilla hanno avuto modo di incontrare già in occasione di due precedenti recensioni dei suoi libri (qui e qui ), per prima ha cercato di descrivere la “vita della schiavitù dopo la sua morte” ovvero la sopravvivenza di una separazione razziale insuperabile all’interno degli Stati Uniti, e forse dell’intero mondo occidentale bianco, che costituisce di fatto la base dei Black Studies più recenti basati spesso su quello che Kevin Ochieng Okoth ha definito come African Pessimism 2.01. Sempre secondo Okoth, però, a differenza di altri teorici dell’AP 2.0:
Per Hartman, l’abolizione formale della schiavitù negli Stati Uniti non ha prodotto una reale discontinuità nella violenza razziale. Troviamo oggi i segni di tale violenza nelle “ridotte chance di vita, nel limitato accesso alla salute e all’educazione, nelle morti premature, nelle incarcerazioni e nell’impoverimento” della gente nera. L’abolizione formale e la Ricostruzione non hanno portato all’emancipazione. Questi eventi sono piuttosto serviti come tappe della “transizione fra modi di servitù e subordinazione razziale”. Mettendo in primo piano il violento processo di subordinazione razziale, Hartman vuole mostrare che la violenza della schiavitù non è limitata alla “costruzione dello schiavo come oggetto”; infatti l’umanità dei soggetti resi schiavi era fondamentale per il progetto di subordinazione razziale. I neri, perciò, non sono oggetti subumani[…], bensì soggetti razzializzati che sono assolutamente parte della sfera sociale e politica.
Diversamente dall’AP 2.0 Hartman enfatizza la capacità di resistere della gente nera. In Vite ribelli, bellissimi esperimenti (2019) impiega il metodo della “affabulazione critica” per svelare le storie delle giovani donne nere e delle persone di genere non tradizionale negli Stati Uniti a cavallo del ventesimo secolo. In città come New York e Filadelfia, queste donne, a poche generazioni di distanza dalla schiavitù, erano sottoposte a nuove forme di razzializzazione e di asservimento e oppressione di genere. Hartman argomenta che queste donne nere erano impegnate in “piccole” rivoluzioni “per costruire vite autonome e bellissime, sottrarsi alle nuove forme di asservimento che le attendevano, e vivere come se fossero libere”. Hartman crea una contro-narrazione rispetto ai documenti ufficiali, nei quali troviamo silenzio o rimozione quando cerchiamo prove di queste vite ribelli. In una breve annotazione teorica, ci ricorda che il termine “ribelle” fa parte di una famiglia di parole che include “errante, fuggitivo, recalcitrante, anarchico, ostinato, spericolato, fastidioso, riottoso, tumultuoso, ribelle e selvaggio”. Il suo progetto appartiene alla tradizione dell’anarchismo americano (“anche se non ha letto God and the State o What is Property? oppure The Conquest of Bread, il pericolo che lei e altri come lei rappresentano è grande al pari di… Emma Goldman e Alexander Berkman”), tradizione alla quale non è però mai riducibile. Si tratta piuttosto di una pratica radicale nera che non può essere ricondotta ad altre ideologie politiche2.
 In Perdi la madre l’autrice, per ricostruire il passato della sua famiglia e dei suoi antenati e degli schiavi prelevati a forza per secoli dal continente africano, segue le tracce di una linea del colore che fu definita da William Edward Burghardt Du Bois3 fin dagli inizi del XX secolo, in occasione del Congresso panafricano che si tenne a Londra nel luglio del 1900 e da lui stesso presieduto. Occasione in cui i leader dei movimenti panafricani che in tale contesto ebbero modo di incontrarsi avevano ben chiara la rilevanza strategica che avevano e avrebbero avuto per il mondo il colore della pelle, la qualità del rapporto fra gli Stati seguiti alla Rivoluzione Francese e i popoli di colore.
In Perdi la madre l’autrice, per ricostruire il passato della sua famiglia e dei suoi antenati e degli schiavi prelevati a forza per secoli dal continente africano, segue le tracce di una linea del colore che fu definita da William Edward Burghardt Du Bois3 fin dagli inizi del XX secolo, in occasione del Congresso panafricano che si tenne a Londra nel luglio del 1900 e da lui stesso presieduto. Occasione in cui i leader dei movimenti panafricani che in tale contesto ebbero modo di incontrarsi avevano ben chiara la rilevanza strategica che avevano e avrebbero avuto per il mondo il colore della pelle, la qualità del rapporto fra gli Stati seguiti alla Rivoluzione Francese e i popoli di colore.
Una linea che è servita adeguatamente a dividere i bianchi dai “neri”, ma soprattutto un proletariato mai definitivamente formato, sia che si trattasse di quello delle origini della rivoluzione industriale che di quello americano degli ultimi due secoli oppure che si tratti di quello attuale, ancora sempre in via di definizione a causa di migrazioni, crisi, guerre e, come al solito, miseria diffusa, anche se non sempre equamente tra i poveri e i lavoratori dei diversi continenti. Sì, poiché il modo di produzione attuale, in base alla ripartizione coloniale e imperialistica del mondo, riesce comunque a ripartire diversamente non solo la ricchezza, ma anche la povertà, garantendo livelli diversi di consumo e accesso ai beni e ai servizi dello Stato.
Una ricostruzione della linea di discendenza famigliare, dalle origini africane alla sistemazione negli States, che porta Saidiya ad incrociare il cammino di Du Bois anche sul terreno dell’Africa, in quel Ghana dove lo studioso e politico afroamericano era morto nel 1963 ad Accra, la capitale, e dove era stato naturalizzato come cittadino ghanese proprio in quell’anno da Francis Nwia-Kofi Ngonloma (1909 – 1972), meglio noto come Kwame Nkrumah (scritto anche Kwame N’Krumah) e talvolta indicato con lo pseudonimo di Osagyefo, “il redentore” per il ruolo rivoluzionario svolto a favore dell’Africa e in particolare del Ghana, diventato definitivamente indipendente nel 1960. Un fatto che aveva fatto sì che, come documenta il testo della Hartman, dopo l’indipendenza formale raggiunta nel 1957 il Ghana potesse rappresentare un faro di libertà per il movimento dei diritti civili e Nkruma fosse idealizzato come il liberatore di tutti i popoli neri.
Non solo i neri americani si identificarono con la lotta anticoloniale, ma credevano che il loro stesso futuro dipendesse dalla vittoria di quella lotta. Un articolo pubblicato sul «Chicago Defender» nel febbraio del 1957 dichiarava: «Un giorno i neri del Ghana potranno presentarsi davanti all’Onu e perorare la causa dei Neri americani ed essere gli artefici della conquista della completa uguaglianza… Il popolo libero del Ghana potrà liberare i suoi fratelli in America dall’ultima delle catene». [Così] Durante gli anni ‘50 e ‘60, gli africani americani accorsero in Ghana in gran numero4.
Un sogno di libertà e realizzazione individuale e collettiva che, però, ai tempi del viaggio di Saidiya alla ricerca delle origini, mostrava già tutte le crepe della disillusione e, soprattutto, dell’incomprensione tra ghanesi e afro o obruni, come venivano definiti coloro che erano arrivati dagli Stati Uniti nei decenni precedenti. Una distanza che la Hartman avverte subito appena arrivata ad Elmina, una città del Ghana meridionale che è anche il più antico insediamento europeo in Africa occidentale dopo Cidade Velha.
Appena scesi dal bus a Elmina, lo sentii. Risuonò nell’aria tagliente e chiaro, e mi sferragliò nelle orecchie facendomi ritrarre. Obruni, Straniera. Una forestiera d’oltreoceano […] Mentre le parole si facevano strada tra la folla per raggiungermi, immaginai me stessa ai loro occhi […] Il mio aspetto lo confermava: ero la tipica straniera. Chi altro indossava vinile ai tropici? I miei costumi appartenevano a un altro paese […] Mondi vecchi e nuovi marcavano il mio viso, una miscela di popoli e nazioni e padroni e schiavi da molto tempo dimenticati nella confusione dei miei tratti, nessuna linea d’origine certa poteva essere tracciata. Era chiaro che non fossi una fanti, una asante, una ewe o una ga. […] Un viso nero non mi rendeva una di loro. Anche quando passavo inosservata, venivo tradita dalla parlata di Brooklyn di mio padre che increspava la mia pronuncia impostata appena aprivo bocca […] Il mio modo diretto di parlare suonava spigoloso e asciutto se paragonato alla discreta evasività e alla cortese opacità dell’inglese locale […] Ero la straniera del villaggio, un seme errante privato della possibilità di mettere radici […] Tutti evitavano la parola “schiava”, ma ognuno di noi sapeva chi fosse chi. In qualità di “figlia di schiava” rappresentavo ciò che la maggior parte della gente aveva scelto di rifuggire: la catastrofe che era il nostro passato, le vite scambiate per stoffa indiana, perle veneziane, conchiglie di ciprea5, armi e rum. Rappresentavo ciò di cui era proibito discutere: la questione delle origini6.
Non fa sconti a se stessa e a nessun altro l’autrice che, come afferma Barbara Ofosu-Somuah nella presentazione dell’edizione italiana del libro:
Fin dalle prime pagine di Perdi la madre, Saidiya Hartman chiarisce che «se la schiavitù rimane una questione aperta nella vita politica dell’America nera, non è a causa di un’ossessione antiquaria per i giorni andati o per il peso di una memoria troppo duratura, ma perché le vite nere vengono ancora svalutate e messe a repentaglio da un calcolo razziale e da un’aritmetica politica consolidatisi secoli fa». La schiavitù e i suoi lasciti, ovvero il mondo creato da schiavitù e colonialismo, fanno ancora oggi parte del vissuto delle persone della diaspora nera7.
Ma, come si affermava poc’anzi, fa anche i conti con una distanza inaspettata tra coloro che nella blackness dovrebbero, o avrebbero dovuto, riconoscersi nonostante le differenze di nazionalità e classe.
Nkrumah credeva che l’indipendenza del Ghana non significasse nulla se tutti gli africani non fossero stati liberi. Gli emigrati neri condividevano quel sogno. Arrivarono dagli Stati Uniti, dai Caraibi, dal Brasile, dal Regno Unito e da altri paesi africani ancora impegnati nella lotta contro il colonialismo e l’apartheid […] Malcom X visitò il Ghana e vi tenne conferenze nel tentativo di costruire l’Organizzazione dell’unità afroamericana. Frantz Fanon scrisse larga parte dei Dannati della terra mentre si trovava in Ghana […] Con tutta l’arroganza e l’ardore della giovinezza, un gruppetto si autonominò i Reduci Rivoluzionari. I ghanesi li chiamavano gli afro, diminutivo per africani americani. Arrivarono con […] un «terribile desiderio di essere accettati», per condividere il loro destino con quello dei ghanesi e intraprendere il duro lavoro di costruzione della nazione8.
Ma come afferma subito l’intellettuale afroamericana, dopo esser giunta lì diversi decenni dopo, «la mia non era l’epoca del romanticismo. L’Eden del Ghana era svanito molto tempo prima del mio arrivo.» Un Eden che era sparito con la crisi della figura dello stesso Nkrumah che aveva avviato meccanismi sempre più autoritari di governo, non sempre compresi dalla popolazione, che avevano portato ad una sua destituzione da parte dell’esercito nel 1966. Un fatto politico “concreto” che fece sì che molti di coloro che erano giunti in Ghana carichi di speranze e sogni panafricani rimanessero al loro posto subendo, però, nel tempo una sorta di allontanamento dalla popolazione locale.
Dopo aver appreso la notizia che Nkrumah era stato rovesciato, gli africani americani piangevano mentre i ghanesi esultavano e danzavano nelle strade. Gli émigrés non si facevano illusioni circa il loro stato, come spiega Leslie Lacy: «Ci tolleravano perché dovevano sopportare Nkrumah, e se avessero potuto ucciderlo alle otto in punto, alle otto e trenta il nostro destino sarebbe stato il suo». I ghanesi erano risentiti con gli afro perché questi occupavano delle posizioni che spettavano loro di diritto, godevano di alta considerazione e influenza presso il presidente, e avevano la presunzione di sapere cosa fosse meglio per l’Africa. Molti africani americani fuggirono volontariamente, alcuni di loro furono deportati9.
Altri rimasero e sono quelli che l’autrice incontra nel corso del suo viaggio e che gli permettono di narrare una storia quasi altrettanto dolorosa di quella degli schiavi deportati dopo essere stati traditi e venduti dai re locali e detenuti in condizioni orribili nei forti costruiti dai portoghesi e dagli olandesi lungo le coste dell’Atlantico. Una storia anche di neri bianchi intesi come ricchi dai residenti africani che guardano alle loro residenze in città come Elmina con un certo fastidio.
Uno sguardo alle lussuose case che torreggiavano sulla costa, sovrastate soltanto dal castello di Elmina, forniva tutte le evidenze necessarie. Le maestose residenze bianche dei discendenti degli schiavi alimentavano l’invidia, come anche il sospetto che la schiavitù non fosse poi stata così male, vista la ricchezza che gli africani americani chiaramente possedevano. Tutti concordavano che essi fossero arrivati troppo tardi per cambiare qualcosa, e provavano soddisfazione nel vedere sconfitti i desideri dei benestanti […] Altri li deridevano, affermando che i nouveaux riches ostentavano ogni minima loro ricchezza perché avevano il disperato bisogno di mostrare di essere gente che conta. Quelli che erano arrivati troppo tardi, non potendo sbarazzarsi di questa etichetta la accettarono con riluttanza […] non sfoggiavano la loro ricchezza,e non erano neppure ricchi, ma era impossibile non notare la disparità tra il loro stile di vita e quello della maggior parte dgli abitanti di Elmina […] Le elganti abitazioni allineate lungo la costa mi ricordavano le ampie dimore costruite in Liberia dagli ex-schiavi provenienti dalla Carolina del Sud e del Nord e dal Mississippi, che riproducevano quel mondo da cui erano migrati con l’eccezione che ora erano loro i nuovi padroni.
Le case dei ricchi erano anche un promemoria dolceamaro della libertà di cui non avrebbero mai goduto in America. Queste case annunciavano al resto di Elmina che i ricchi erano sbarcati, e che si trattava di neri uomini bianchi. Ogni mattone, ogni pilastro, testimoniava l’impossibilità di un ritorno e l’imprudenza di credere nelle origini, di provare a recuperarle. Costruite all’ombra del castello, a mo’ di provocazione – laddove una volta venivamo marchiati e venduti, ora prosperiamo – queste proprietà erano il frutto di una battaglia ancora in atto tra le razze creditrici e debitrici, predatori e prede, mercanti e schiavi10.
Se si è scelto, all’interno di una recensione che intende essere problematizzante, di soffermare maggiormente l’attenzione sulle vicende di coloro che, lasciandosi alle spalle gli Stati Uniti e credendo nel panafricanismo, avevano raggiunto il continente africano inseguendo un sogno di libertà e giustizia, è soltanto perché quel sogno portava con sé un mito. Lo stesso che insegue, in fin dei conti, anche l’autrice: quello del ritorno, impossibile, alle origini.
Origini talmente crudeli e devastanti da aver cancellato la possibilità di liberare i neri, africani e americani, inseguendo soltanto l’unicità e l’unità rappresentata dalla blackness o da una linea del colore capovolta. Come forse avrebbe voluto lo stesso Du Bois quando propose la formazione di uno stato afroamericano all’interno degli Stati Uniti11. Origini nazionali e culturali che, però, il proletariato non può permettersi di avere una volta formatosi come tale perché, in quanto tale, «non ha più nazione» e, tanto meno, può accettare di razzializzarsi, ovvero interiorizzare una razzializzazione imposta dall’alto secondo le ideologie nazionaliste, razziste o religiose.
 Un sogno, quello abbozzato prima, che, sostituendo invece la razza o il colore della pelle alle classi in lotta tra di loro, indipendentemente dalle linee del colore utilizzate per avvantaggiarne soltanto alcune, è fallito ormai da tempo. Nonostante gli sforzi della borghesia bianca e nera di utilizzarlo contro la lotta di classe, al di qua e al di là dell’Atlantico.
Un sogno, quello abbozzato prima, che, sostituendo invece la razza o il colore della pelle alle classi in lotta tra di loro, indipendentemente dalle linee del colore utilizzate per avvantaggiarne soltanto alcune, è fallito ormai da tempo. Nonostante gli sforzi della borghesia bianca e nera di utilizzarlo contro la lotta di classe, al di qua e al di là dell’Atlantico.
Soprattutto dopo che un afroamericano ha raggiunto la carica più alta dello stato americano per ben due mandati, senza nulla poter o voler cambiare sia sul piano dei rapporti politico-economici che razziali, l’immagine dei neri uomini bianchi ricchi arrivati comunque troppo tardi richiamata dalle parole della Hartman sembra essere pienamente confermata, insieme alla negazione della speranza in quegli “uomini eccezionali” che secondo Du Bois avrebbero dovuto e potuto salvare “la razza Negra”12.
Rivelando così come il libro della Hartman sia allo stesso tempo doloroso e indispensabile, la cui lettura attenta e la riflessione che è destinata ad accompagnarla in ogni caso rimane indispensabile per chiunque voglia avvicinarsi ai problemi e alle difficoltà connesse ai processi di liberazione di un’umanità divisa al suo interno lungo linee di ordine nazionalistico, razziale, religioso e cultural prestabilite, fino ad ora, dall’utopia capitale. Che proprio dall’Africa e dal commercio degli schiavi prese l’avvio per la sua affermazione e il suo dominio su scala planetaria.
-
K. O. Okoth, Red Africa. Questione coloniale e politiche rivoluzionarie, Meltemi Editore, Milano 2024, pp. 36 -51. ↩
-
K. O. Okoth, op. cit., pp. 42-44. ↩
-
Nato nel 1863 nel New England, Du Bois fu il primo afroamericano a prendere il dottorato a Harvard (studiando con William James), si perfezionò a Berlino con Max Weber (e al ritorno fondò la sociologia moderna negli Stati Uniti), creò la National Association for the Advancement of Colored People, promosse i congressi panafricani che preparano le indipendenze africane, morì nel 1960 ad Accra, capitale di un Ghana appena diventato indipendente, dopo essersi iscritto, a novant’anni, al partito comunista. ↩
-
S. Hartman, Perdi la madre, Tamu Edizioni, Napoli 2021, p. 53. ↩
-
Si veda in proposito: T. Green, Per un pugno di conchiglie. L’Africa occidentale dall’inizio della tratta degli schiavi all’Età delle rivoluzioni, Giulio Einaudi editore, Torino 2021. ↩
-
S. Hartman, op. cit., pp. 17-18. ↩
-
B. Ofosu-Somuah in S. Harman, op. cit., p. 7. ↩
-
S. Hartman, op. cit., pp. 55-56. ↩
-
Ivi, p. 57. ↩
-
Ibidem, pp.130-131. ↩
-
Si vedano gli scritti dello stesso contenuti in W.E. B. Du Bois, Sulla linea del colore. Razza e democrazia negli Stati Uniti e nel mondo, a cura e con un’introduzione di Sandro Mezzadra, Bologna, Il Mulino, 2010. ↩
-
W.E.B. Du Bois, The Talented Tenth (1903) ora in W.E.B. Du Bois, op. cit., con il titolo Il decimo con talento, pp. 155-177. ↩

