di Gioacchino Toni
 Gavin Mueller, Tecnoluddismo. Perché odi il tuo lavoro, traduzione di Valerio Cianci, Nero, Roma, 2021, pp. 170, € 20,00
Gavin Mueller, Tecnoluddismo. Perché odi il tuo lavoro, traduzione di Valerio Cianci, Nero, Roma, 2021, pp. 170, € 20,00
In Breaking Thing at Work: The Luddites Are Right About Why You Hate Your Job (Verso, 2021), tradotto da Valerio Cianci per le edizioni Nero, l’ottimismo tecnologico, sostiene Mueller, lungi dall’essere prerogativa di cinici miliardari come Jeff Bezos ed Elon Musk, lo si ritrova anche in ambienti di sinistra, ove «i cosiddetti accelerazionisti prevedono un comunismo di lusso pienamente automatizzato sulla scia delle più selvagge fantasie degli imprenditori della Silicon Valley» in continuità con una tradizione marxista poco propensa a criticare la tecnologia anche quando questa viene applicata in ambito lavorativo in maniera alienante.
Convinti della neutralità della tecnologia, molti marxisti hanno guardato quasi esclusivamente a chi disponesse del controllo su di essa (i lavoratori o il capitale), in alcuni casi giungendo persino a guardarla di buon occhio anche quando sottoposta al controllo del capitale in quanto «mezzo in grado di creare le condizioni per una trasformazione radicale proprio sotto al naso del datore di lavoro»; insomma, in vista del fine ultimo socialista, occorrerebbe saper accettare l’avanzamento tecnologico anche quando nel “breve” periodo – e poco importa se coincide con la vita lavorativa di intere generazioni – dovesse comportare conseguenze negative per gli stessi lavoratori (e l’ambiente in cui vivono).
Per quanto marxista, Mueller si pone nei confronti della tecnologia in maniera decisamente diversa rispetto ai tecnoentusiasti marxisti, mettendo in risalto le ricadute negative della massiccia applicazione delle tecnologie in ambito produttivo sui lavoratori, la propensione all’accentramento di ricchezza, dunque di potere, a vantaggio degli sfruttatori e la riduzione dell’autonomia dei lavoratori e della loro capacità di organizzarsi per tutelare i propri interessi. Se si è interessati al destino di queste persone e se si è mossi da principi egualitari, afferma Mueller, occorrerebbe essere «critici nei confronti della tecnologia e quindi prendere in considerazione tutti i frangenti in cui le persone, soprattutto i lavoratori, vi si sono opposte».
 L’autore inizia il volume indagando la prospettiva politica propria dei tessitori inglesi ottocenteschi che hanno combattuto la riorganizzazione tecnologica del lavoro imposta dai capitalisti dell’epoca. Per quanto, anche a sinistra, siano stati a lungo dipinti come anacronistici ed irrazionali antimodernisti, i luddisti, scrive Mueller, «credevano che le nuove macchine fossero una minaccia al loro stile di vita, che sarebbero state in grado di distruggere le loro comunità e che, di conseguenza, la distruzione di quelle stesse macchine fosse una valida strategia per opporvi resistenza».
L’autore inizia il volume indagando la prospettiva politica propria dei tessitori inglesi ottocenteschi che hanno combattuto la riorganizzazione tecnologica del lavoro imposta dai capitalisti dell’epoca. Per quanto, anche a sinistra, siano stati a lungo dipinti come anacronistici ed irrazionali antimodernisti, i luddisti, scrive Mueller, «credevano che le nuove macchine fossero una minaccia al loro stile di vita, che sarebbero state in grado di distruggere le loro comunità e che, di conseguenza, la distruzione di quelle stesse macchine fosse una valida strategia per opporvi resistenza».
Guardare sotto una diversa prospettiva quelle lotte può contribuire a vedere quanto di buono c’è nel riemergere di pratiche luddiste anche ai nostri giorni. Scopo dichiarato dell’autore è mostrare come «il luddismo sia intellettualmente compatibile con il marxismo», non tanto come esercizio astrattamente filosofico, ma per testare la teoria marxista mettendola a confronto con le effettive pratiche dei lavoratori. Per fare ciò, continua lo studioso, è importante recuperare «gli esempi fondamentali di lotte in cui i lavoratori non si sono focalizzati esclusivamente sui loro nemici di classe (rappresentati da padroni o manager) ma anche sulle macchine utilizzate in quelle lotte».
«Che lo si ammetta o meno, buona parte della critica tecnologica contemporanea deriva da una prospettiva umanistica e romantica, dall’idea che la tecnologia ci abbia allontanato da qualche nostra componente essenziale, e che ci separi da ciò che ci rende umani». Il recupero della dimensione umana alienata dalle tecnologie di cui parlano diversi studiosi spesso si limita a riprendere la critica heideggeriana nei confronti della tecnologia (tecnica) al fine di riconquistare l’Essere “autentico”. Il limite evidente di tali prospettive, sostiene Mueller, è che il problema fondamentale della tecnologia riguarda piuttosto «il suo ruolo nella perpetrazione delle gerarchie e delle ingiustizie imposteci da proprietari d’industria, capi e governi. In poche parole, il problema della tecnologia è il suo ruolo nel capitalismo», il fatto che attraverso questa si sia di fatto ampliato a dismisura il tempo di lavoro, limitando l’autonomia dei lavoratori ed agendo in maniera predittiva nei loro confronti dividendoli.
«In tutta risposta, un’efficace strategia di lotta di classe dovrà necessariamente prendere di mira le macchine con cui si trova costretta a convivere», come è accaduto in diversi momenti storici. L’obiettivo dell’autore, evidentemente, non è quello di invitare a “sfasciare le macchine”, bensì quello di «dimostrare come i lavoratori stessi si siano più volte dimostrati luddisti nel corso delle loro lotte. Questo è vero tanto per gli autoproclamati seguaci di re Ludd all’alba del XIX secolo, quanto per tutti gli altri lavoratori che ne hanno seguito le orme nel corso degli anni. E vale anche per i lavoratori tecnologici più qualificati nell’epoca del computer». Anziché perdere tempo nel giudicare o biasimare tali lotte, scrive l’autore, occorrerebbe articolare una teoria a partire da esse.
Lo storytelling, fatto proprio anche dalla sinistra, che auspicava uno sviluppo tecnologico esponenziale in grado di correggere le storture presenti ha mostrato la sua inconsistenza; basti guardare a come le recenti innovazioni delle reti digitali, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale siano accompagnate da esiti negativi per i lavoratori e per il Pianeta. Nel frattempo si sono manifestati in maniera crescente sentimenti ed episodi luddisti e anticapitalisti: è a partire da questi che, secondo Mueller si deve guardare per costruire un futuro migliore per tutti e tutte.
L’analisi attenta della stagione luddista ottocentesca contraddice la narrazione egemone che etichetta la resistenza alle macchine come tecnofoba, mossa da un’ingenua contrarietà al progresso. In realtà, scrive lo studioso, «le macchine industriali hanno sempre ispirato una particolare avversione non solo perché demolivano i modelli di vita tradizionali, ma anche perché logoravano e sfiancavano coloro che erano destinati a utilizzarle». Lungi dall’essere stata semplice tecnofobia, l’opposizione luddista alla tecnologia «non era contro le macchine in sé, ma contro la società industriale che minacciava il loro stile di vita, e che aveva trovato nelle macchine la propria arma principale».
La distruzione dei macchinari rappresenta soltanto una fra le tante tecniche utilizzate dai luddisti, riservata ai più intransigenti proprietari delle fabbriche, essa fa parte di una più ampia strategia volta ad implementare il potere dei lavoratori. Come ha mostrato lo storico Eric Hobsbawm1, le distruzioni delle macchine dei luddisti erano finalizzate all’ottenimento di un maggior potere contrattuale collettivo e deve essere considerata come espressione di una determinata composizione di classe: è attraverso «la distruzione dei macchinari che i luddisti si sono costituiti come classe, creando cosi legami di solidarietà», le varie forme di rivolta contro le macchine rappresentano dunque pratiche di organizzazione politica.
Nel caso dei luddisti si trattava perlopiù di lavoratori indipendenti la cui opposizione al loro assorbimento nelle fabbriche si coniugava ad altre forme di resistenza che avevano come obiettivo la salvaguardia di elementi specifici del loro stile di vita e delle loro comunità. Ovviamente non potevano organizzarsi allo stesso modo dei lavoratori di massa, e non limitavano le loro lotte al posto di lavoro. Questa classe invece si organizzo attorno a una figura mitologica e collettiva – re Ludd – e creo forme e pratiche di segretezza e di solidarietà comunitaria in modo da alimentare le lotte e al contempo proteggere chi vi prendeva parte. […] Gli attacchi organizzati ai macchinari delle fabbriche e la loro distruzione non erano parte di una strategia isolata – erano invece la trama stessa della resistenza, la fibra che univa i tessitori come classe. Era una pratica di solidarietà.2.
Mueller si sofferma anche sulla resistenza operaia all’introduzione del taylorismo a partire dal celebre sciopero spontaneo dell’11 agosto del 1911 degli operai dell’arsenale di Watertown in risposta al licenziamento di uno di loro che si era rifiutato di farsi cronometrare dai solerti responsabili della “verifica scientifica” della tempistica produttiva. La mobilitazione comportò la sospensione del taylorismo e la riassunzione dell’operaio. Il cronometro rappresentò la macchina per eccellenza del nuovo sistema di organizzazione del lavoro e con esso delle attività operaie.
Se fino ad allora i lavoratori detenevano il monopolio delle conoscenze necessarie all’organizzazione ed al funzionamento dei meccanismi produttivi, tanto da poter contrarre o dilatare i tempi a piacimento, il nuovo sistema produttivo fondato sull’organizzazione scientifica del lavoro, di fatto, più che a determinare metodi di lavoro ideali, mirava ad esautorare il controllo operaio sulla produzione, dunque a toglier loro potere. «La terminologia moderna della “scienza” e dell’“efficienza” mascherava il desiderio di disciplinare e controllare i lavoratori». L’organizzazione scientifica, scrive lo studioso, più che una «scienza dell’efficienza» si è rivelata «un programma politico per rendere i lavoratori soggetti docili e obbedienti». Non a caso «le priorità produttive» durante la seconda guerra mondiale «erano la costanza e il controllo, non la riduzione delle tempistiche o il risparmio di denaro, benché il controllo della domanda e dei salari durante il periodo bellico riuscissero in ogni caso a mantenere in attivo i fondi delle industrie».
Che negli Stati Uniti l’obiettivo principale nelle fabbriche durante il periodo bellico fosse il controllo ben più che l’efficienza è chiaramente comprensibile se si pensa che nel corso degli anni Quaranta il numero di scioperi, spesso attuati senza preavviso, superò quello della Grande Depressione, tanto che per qualche tempo negli stabilimenti Ford si arrivò in media a scioperare a giorni alterni. Per arginare un tale livello di conflittualità, che rischiava di aumentare con il reinserimento dei militari di ritorno dalla guerra, oltre alla repressione diretta si fece ricorso anche a qualche apparente concessione sotto forma di accordo con le principali organizzazioni sindacali affinché i salari fossero sempre più strettamente legati alla produttività, dunque all’accettazione dei macchinari e dei sistemi di automazione sui luoghi di lavoro nonostante ciò portasse ad una sottrazione del sapere operaio nella gestione dei processi produttivi e con esso del potere contrattuale.
Alla Bethlehem Steel, in Pennsylvania, ove intraprese i sui primi esperimenti di riorganizzazione del lavoro, Taylor si trovò a fare i conti con una lunga serie di guasti alle macchine provocati dai lavoratori. Dopo la scomparsa di Taylor nel 1915, scrive Mueller, a portare avanti la sua rivoluzione furono paradossalmente i sindacati operai.
Agli inizi del XX secolo, i leader marxisti dei movimenti operai vedevano le tecnologie capitaliste e la gestione scientifica allo stesso modo di Taylor: si trattava di una tecnica obiettiva di incremento della produzione, e quindi di miglioramento della condizione dei lavoratori. Fondandosi su un’interpretazione particolare della teoria marxiana, credevano che il capitalismo, nella sua incessante ricerca di profitto, garantisse l’aumento della produttività grazie a innovazioni tecnologiche competitive e all’elaborazione di metodi lavorativi sempre più efficienti. Queste scoperte non avevano una politica intrinseca: la tecnologia era neutra e sarebbe stato possibile appropriarsene sottraendola al capitale privato e affidandone il controllo allo Stato, che l’avrebbe di conseguenza usata per l’emancipazione operaia dal logorio della vita lavorativa.
Insomma, scrive Mueller, «per la teoria marxista ortodossa, la produzione socialista era già contenuta nei modi di produzione capitalisti, a patto che questi avessero continuato a svilupparsi». La fiducia che i teorici marxisti riponevano nella tecnologia e nella scienza della produzione e più in generale nel progresso, si trovò spesso in contrasto con l’attività pratica dei lavoratori. Mentre il taylorismo si diffondeva nelle fabbriche statunitensi, a differenza delle leadership dei partiti e dei principali sindacati di sinistra, i militanti dell’Industrial Workers of the World (IWW) compresero immediatamente le ricadute nefaste dell’organizzazione scientifica del lavoro sulla classe operaia, tanto da agire di conseguenza con i più diversi atti di sabotaggio.
Dopo aver tratteggiato il dibatto interno alla Seconda internazionale e le scelte prese dall’Unione Sovietica a proposito della tecnologia, del processo lavorativo e delle produttività, Mueller si sofferma sull’azione autonoma dei lavoratori statunitensi ed europei nelle lotte contro l’automazione nell’era postbellica, quando, non badando agli inviti alla cautela e alla pazienza delle maggiori organizzazioni sindacali, i lavoratori abbandonavano le postazioni di lavoro o manomettevano i macchinari. Negli Stati Uniti, tra le fila di questi operai in lotta contro l’automazione, ricorda Mueller, «c’era posto per chi spesso veniva marginalizzato dai movimenti dei lavoratori ufficiali, ossia le donne e gli afroamericani – a cui, per altro, dobbiamo buona parte delle più efficaci analisi critiche sulle nuove tecnologie».
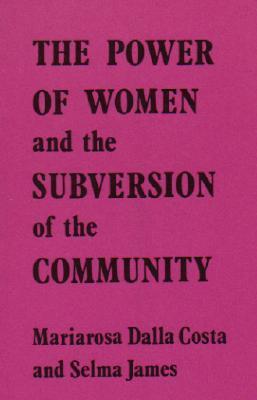 Nel corso degli anni Sessanta, ricorda lo studioso, «nelle loro analisi e nelle loro politiche i maggiori gruppi radicali neri assegnarono un’importanza fondamentale alla critica della tecnologia. Capirono che la ricomposizione della forza lavoro innescata della tecnologia avrebbe segnato il destino delle loro lotte». Non a caso nel 1972 le Black Panther aggiornarono il loro programma inserendo il «controllo delle nuove tecnologie da parte delle comunità». Anche in ambito femminista furono numerose le denunce di come la tecnologia, nella sfera domestica come in fabbrica, rafforzasse la divisione di genere del lavoro3.
Nel corso degli anni Sessanta, ricorda lo studioso, «nelle loro analisi e nelle loro politiche i maggiori gruppi radicali neri assegnarono un’importanza fondamentale alla critica della tecnologia. Capirono che la ricomposizione della forza lavoro innescata della tecnologia avrebbe segnato il destino delle loro lotte». Non a caso nel 1972 le Black Panther aggiornarono il loro programma inserendo il «controllo delle nuove tecnologie da parte delle comunità». Anche in ambito femminista furono numerose le denunce di come la tecnologia, nella sfera domestica come in fabbrica, rafforzasse la divisione di genere del lavoro3.
Come avvenne per i tessitori, anche i lavoratori portuali americani si resero conto di come l’introduzione massiccia di tecnologia stesse minando il loro controllo sulle attività ed i legami di solidarietà. «L’automazione fu un vero e proprio rovesciamento del sistema portuale: nei porti ormai containerizzati, non solo erano necessari sempre meno scaricatori, ma, per via della drastica riduzione dei tempi di carico e scarico con il conseguente deprezzamento delle spedizioni marittime, divennero necessari sempre meno porti. Molte città, fra cui New York, videro i loro porti e le comunità che li animavano decimarsi nel giro di pochi anni».
Ad avere la meglio nel pensiero di sinistra sarà una visione che, quando non si limita ad accogliere acriticamente l’automazione nei processi produttivi con annesse finalità produttivistiche, giunge persino a farne una vera e propria apologia, tanto da vedere nel mito della “piena automazione” un passaggio obbligato per il superamento dello sfruttamento capitalista, come se i fini ultimi bastassero a redimere una routine di fabbrica fatta di fatica, parcellizzazione, alienazione e corsa contro il tempo.
Ai nostri giorni l’automazione – che agisce sulla forza lavoro «atomizzando e ricombinando i compiti, modificandone le richieste ed eliminando le occupazioni di fascia media» – comporta la sostituzione soprattutto del lavoro fisico ripetitivo e quello proprio delle posizioni manageriali intermedie.
Per esempio, i magazzini di Amazon utilizzano un sistema a gestione software per coordinare i lavoratori umani che selezionano uno specifico bene e i robot che invece si occupano dello spostamento di grandi scaffali. Gli algoritmi sostituiscono le posizioni organizzative intermedie, comportando la polarizzazione della forza lavoro, fatta di dirigenti sempre più ricchi e potenti e lavoratori declassati che non sono sostituibili dalle macchine, ma da altri lavoratori: in sostanza manodopera tranquillamente rimpiazzabile all’occorrenza.
Nel dopoguerra, attorno all’automazione si consumarono accese discussioni in seno alla sinistra. Sebbene i lavoratori si fossero a più riprese rivoltati contro l’introduzione di nuove tecnologie nell’ambito lavorativo, non di rado le organizzazioni sindacali hanno in qualche modo collaborato con i datori di lavoro «per assoggettare l’irrequieta forza lavoro alle macchine. Con l’intensificazione dell’attivismo nel corso degli anni Sessanta, il capitale ha accelerato il processo di cambiamento tecnologico come parte di una ristrutturazione globale radicata nelle varie destabilizzazioni dell’ordine postbellico. Al centro di tali cambiamenti c’era una tecnologia che le controculture accolsero con fascinazione e terrore: il computer».
[continua]
We are not robots – serie completa
-
Eric Hobsbawm, The Machine Breakers, “Past and Present”, n. 1, 1952. ↩
-
A tal proposito si veda Peter Linebaugh, King Ludd and Queen Mab Machine-Breaking, Romanticism, and the Several Commons of 1811-12, PM press, Oakland, CA, 2012. ↩
-
Cfr.: Selma James, Mariarosa Dalla Costa, The Power of Women and the Subversion of Community, Falling Wall Press Limited, Bristol, 1975; Ruth Schwartz Cowan, More work for mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave, Basic Books, New York, 1983. ↩
